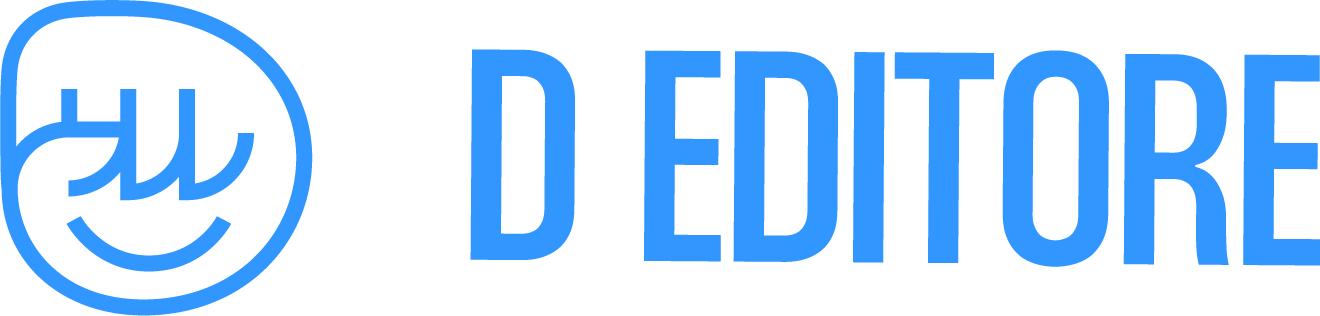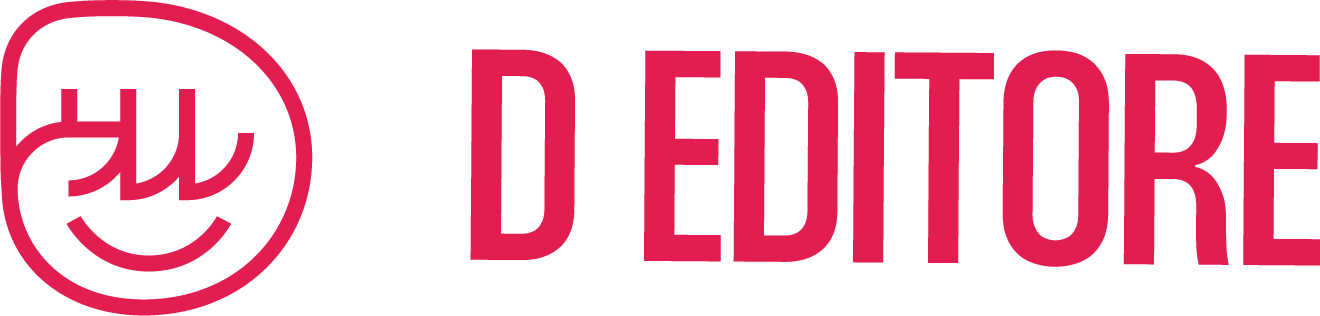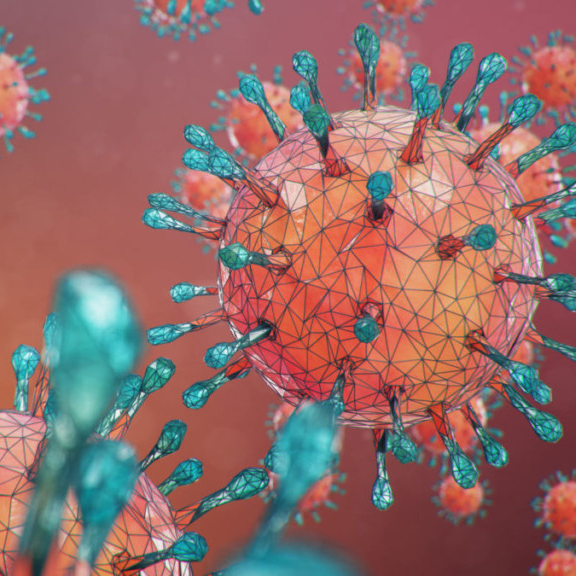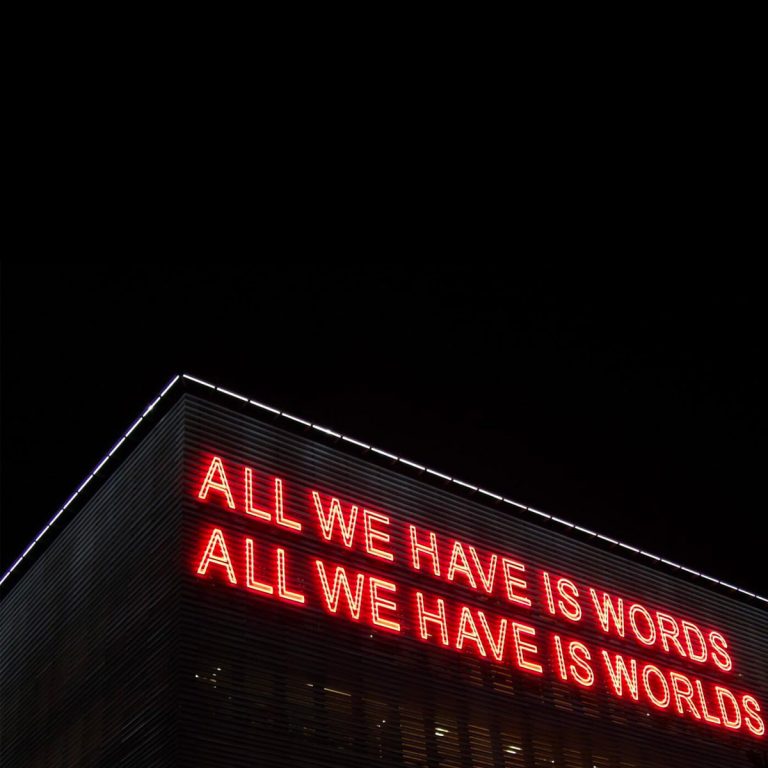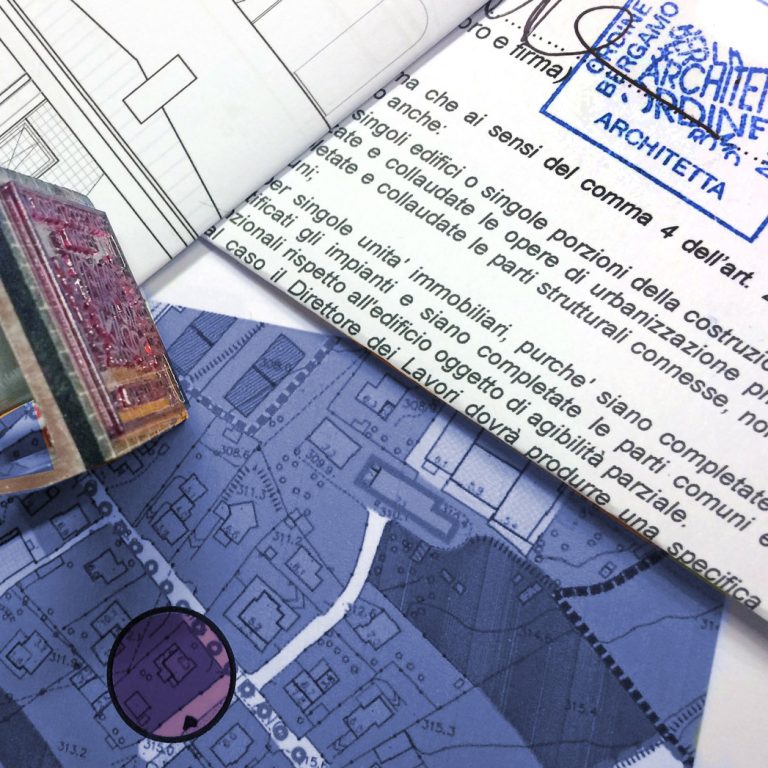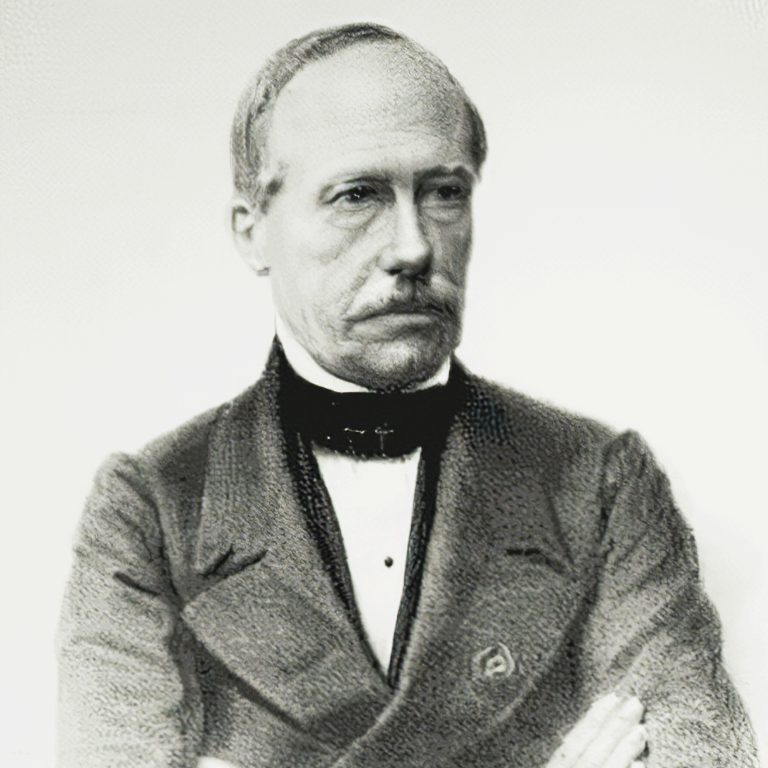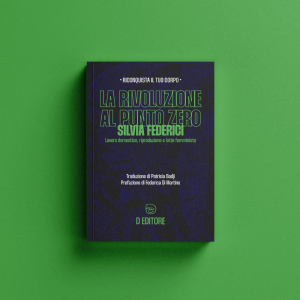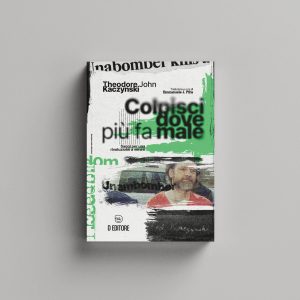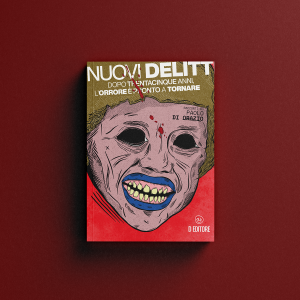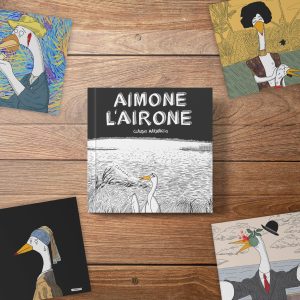Guerra, globalizzazione e riproduzione
Attivista, autrice e docente, Silvia Federici ha diviso la sua vita tra il mondo accademico e quello della militanza. Nata in Italia nel 1942, Federici ha conseguito il dottorato presso l’università statunitense di Buffalo e in seguito ha insegnato in diversi campus, a lungo in Nigeria e di nuovo negli Stati Uniti, dove tuttora risiede. Teorica d’impostazione marxista, è figura di primissimo piano nello sviluppo del pensiero femminista contemporaneo. Con D Editore ha pubblicato Oltre la periferia della pelle.
Di seguito troverete un estratto da La rivoluzione al punto zero, in occasione della sua prossima uscita.
Ⓐ
Per primi arrivarono i banchieri stranieri smaniosi di elargire prestiti a tassi da estorsione; poi i controllori finanziari per accertarsi che gli interessi fossero stati pagati; poi le migliaia di consulenti stranieri a prendersi la loro parte. Infine, quando il Paese era in bancarotta e senza alcuna speranza, venne il momento delle truppe straniere per “salvare” il governatore dal popolo “ribelle”. Un ultimo colpo e il paese era finito
Thomas Pakenham, The Scramble for Africa1
Affamato, chi ti sfamerà?
chi non ne ha per sé. Vieni con noi,
affamati ti sfameremo.
Bertolt Brecht, All or Nothing
Ⓐ
Come dimostra la proliferazione di conflitti in Africa, Asia e nel Medio Oriente, oltre allo zelo statunitense per l’intervento militare per tutti gli anni Ottanta e Novanta, la guerra fa parte dell’agenda mondiale2. Il motivo risiede nella nuova fase di espansionismo capitalista che richiede la distruzione di qualsiasi attività economica non subordinata alla logica dell’accumulazione, processo necessariamente violento. Il capitale sociale non può estendere i suoi tentacoli sulle risorse del pianeta – dai mari alle foreste, fino al lavoro delle persone e al nostro patrimonio genetico – senza provocare una forte resistenza in tutto il globo. Inoltre, è nella natura dell’odierna crisi capitalista il fatto che non sia possibile alcuna mediazione e che pianificare lo sviluppo nel cosiddetto “Terzo Mondo” spiani la strada alla guerra3.
Che il collegamento tra integrazione nell’economia mondiale e guerra non sia sempre riconosciuto è perché la globalizzazione, oggigiorno, sebbene porti essenzialmente avanti il progetto imperiale del xix secolo, si presenta innanzitutto come un programma economico. Le sue armi principali e più riconoscibili sono i programmi di adeguamento strutturale, la liberalizzazione degli scambi commerciali, la privatizzazione, i diritti di proprietà intellettuale. Tutte queste politiche sono responsabili dell’immane trasferimento di ricchezza dalle “colonie” alle metropoli, senza che esso necessiti la conquista di territori, e perciò si ritiene funzioni puramente attraverso strumenti di pace4.
Anche l’intervento militare sta assumendo nuove forme, presentandosi spesso sotto le spoglie di iniziative filantropiche del tipo “aiuti alimentari” e “soccorso umanitario” o, nell’America Latina, “guerra alla droga”. Un ulteriore motivo per cui la relazione tra guerra e globalizzazione – forma odierna dell’imperialismo – non è chiaramente riconoscibile è che la maggior parte delle “guerre della globalizzazione” sono state combattute nel continente africano, la cui storia recente è sistematicamente distorta dai media, che incolpano di ogni crisi la supposta “arretratezza” degli africani, il loro “tribalismo” e la loro incapacità di instaurare istituzioni democratiche.
Africa, guerra e adeguamenti strutturali
In realtà, la situazione in Africa rivela la stretta connessione tra l’implementazione dei programmi di adeguamento strutturale (pas), introdotti negli anni Ottanta dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale (fmi) per facilitare l’avanzata del capitale delle multinazionali nella regione, e lo sviluppo di un perenne stato di guerra. Dimostra che gli adeguamenti strutturali generano guerre e che le guerre, a loro volta, completano il lavoro iniziato dagli adeguamenti strutturali, cioè rendono i paesi in guerra dipendenti dal Capitale internazionale e dai poteri che esso rappresenta, a cominciare dagli Stati Uniti, l’Unione Europea e le Nazioni Unite. In altre parole, parafrasando Clausewitz, “gli adeguamenti strutturali sono una guerra senza uso di armi”.
Sono molti i modi in cui gli “adeguamenti strutturali” promuovono la guerra. Furono imposti dalla Banca Mondiale e dal fmi su quasi tutti gli stati africani a partire dai primi anni Ottanta, presumibilmente per stimolare la ripresa economica e aiutare i governi locali a ripagare i debiti contratti durante il decennio precedente per finanziare progetti di sviluppo. Tra le riforme previste vi sono la privatizzazione della terra (a cominciare dall’abolizione della proprietà comunitaria), la liberalizzazione degli scambi commerciali (eliminando i dazi sui beni importati), la deregolamentazione delle transazioni in valuta estera, il ridimensionamento del settore pubblico, la sospensione dei fondi ai servizi assistenziali e un sistema di controlli che trasferisca efficacemente la pianificazione economica dai governi africani alla Banca Mondiale e alle organizzazioni non governative (ong)5.
Questa riorganizzazione economica sarebbe dovuta servire a dare una spinta alla produttività, a eliminare l’inefficienza e ad aumentare la “vena competitiva” dell’Africa sul mercato globale. Ma è accaduto il contrario. Oltre un decennio dopo la sua adozione, le economie locali sono collassate, gli investimenti esteri non sono avvenuti e le uniche attività produttive presenti nella maggioranza delle nazioni africane sono ancora una volta, come durante il periodo coloniale, l’estrazione mineraria e l’agricoltura incentrata sull’esportazione che contribuisce ad alimentare il mercato internazionale mentre gli africani non hanno abbastanza cibo per sfamarsi.
In questo contesto di bancarotta economica generalizzata, sono esplose ovunque delle rivalità violente tra le diverse fazioni della classe dirigente africana che, incapace di arricchirsi tramite lo sfruttamento del lavoro, lotta per avere accesso al potere statale in modo da accumulare ricchezza. Il potere dello stato, infatti, è la chiave per appropriarsi e vendere sul mercato internazionale o risorse e beni nazionali (terra, oro, diamanti, petrolio, legname), o i beni di un rivale o di gruppi più deboli6. Ne consegue che la guerra sia diventata la parte vulnerabile di una nuova economia mercantile o (secondo qualcuno), di una “economia del saccheggio”7, che fiorisce con la complicità delle aziende straniere e degli organismi internazionali che, per quanto si lamentino della “corruzione”, ne traggono beneficio.
L’insistenza della Banca Mondiale affinché tutto venga privatizzato ha indebolito lo stato, come è successo in Russia, ed esasperato questo processo. Allo stesso modo, la deregolamentazione delle attività bancarie e delle transazioni di valuta estera (sempre richieste dalla Banca Mondiale) hanno aiutato la diffusione del commercio di droga che fin dagli anni Ottanta ha giocato un ruolo preponderante nella politica economica dell’Africa, contribuendo alla formazione di eserciti privati8.
Un ulteriore fattore che alimenta la guerra in Africa è il violento impoverimento in cui gli adeguamenti strutturali hanno fatto sprofondare la quasi totalità della popolazione. Questo, oltre a intensificare le proteste sociali, ha nel corso degli anni strappato il tessuto sociale di molti paesi della regione, costringendo milioni di persone a lasciare il proprio paese per andare all’estero in cerca di nuove fonti di sostentamento; e la lotta per la sopravvivenza ha gettato le basi per la manipolazione di antagonismi locali e il reclutamento di disoccupati (particolarmente tra i giovani) tra parti già in conflitto tra loro. Molti conflitti “tribali” e religiosi in Africa (non meno dei conflitti “etnici” in Jugoslavia) affondano le proprie radici in questi processi. Dalle espulsioni di massa di immigrati e i disordini religiosi in Nigeria della prima metà degli anni Ottanta, alle guerre tra “clan” in Somalia dei primi anni Novanta, per arrivare alle guerre sanguinarie tra lo stato e i fondamentalisti in Algeria, sullo sfondo della maggior parte dei conflitti africani contemporanei stanno le “condizioni” dettate dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale, che hanno distrutto la vita delle persone e minato le condizioni per una solidarietà sociale10.
Per esempio, possiamo dire con sicurezza che i giovani che hanno combattuto le numerose guerre africane degli ultimi anni siano gli stessi che decenni prima sarebbero potuti andare a scuola, che avrebbero potuto sperare di guadagnarsi da vivere con il commercio o con un lavoro nel pubblico, e che avrebbero potuto guardare al futuro con la speranza di riuscire a contribuire al benessere della famiglia. Analogamente, la comparsa di bambini-soldato negli anni Ottanta e Novanta non sarebbe potuta accadere se, in molti paesi, la famiglia allargata non fosse stata minacciata da ristrettezze economiche e milioni di bambini non fossero rimasti senza un posto dove andare che non fosse la strada e avessero avuto qualcuno che pensava ai loro bisogni11.
La guerra non è stata unicamente la conseguenza del cambiamento economico; è stata anche uno strumento attraverso il quale produrre tale cambiamento. Sono due gli obiettivi che saltano all’occhio quando pensiamo ai modelli di guerra predominanti in Africa e al modo in cui la guerra si interseca con la globalizzazione. Innanzitutto, essa costringe le persone ad allontanarsi dalla terra, cioè separa i produttori dai mezzi di produzione, condizione essenziale per l’espansione del mercato del lavoro globale. La guerra rivendica la terra anche per un suo uso capitalista, incoraggiando la produzione di colture da reddito e un’economia orientata all’esportazione. In particolare in Africa, dove la gestione comunitaria della terra è ancora diffusa, questo è stato uno degli obiettivi principali della Banca Mondiale, la cui ragion d’essere in quanto istituzione è stata la capitalizzazione dell’agricoltura12. È dunque difficile vedere oggi milioni di rifugiati o vittime della carestia fuggire dal proprio paese senza pensare alla soddisfazione che i funzionari della Banca Mondiale, così come le aziende agroalimentari, provino, vedendovi certamente la mano del progresso all’opera.
La guerra mina anche l’opposizione delle persone alle “riforme di mercato” rimodellando il territorio e distruggendo le reti sociali che forniscono la base di una resistenza. Qui è importante notare la correlazione – frequente nell’Africa contemporanea – tra le proteste anti-fmi e i conflitti sociali13. È palese in Algeria, dove l’ascesa del fondamentalismo islamico antigovernativo è nata della rivolta anti-FMI del 1988, quando migliaia di giovani scesero nelle strade della capitale per diversi giorni in quella che fu la più intensa e diffusa protesta dai giorni d’oro della lotta anticolonialista14.
L’intervento esterno – spesso facendo leva sulle lotte locali e trasformandole in conflitti globali – ha giocato un ruolo primario in questo contesto. Si può osservare nel caso degli interventi militari degli Stati Uniti che vengono solitamente letti attraverso il prisma della “geopolitica” e la Guerra Fredda, come il sostegno che l’amministrazione Reagan diede ai governi del Sudan e della Somalia e alla Unione Nazionale per l’Indipendenza Totale dell’Angola (unita). Dei sap erano in corso sia in Sudan che in Somalia fin dai primi anni Ottanta, quando i due paesi erano tra i principali beneficiari di aiuti militari statunitensi. In Sudan, l’aiuto militare statunitense rafforzò la mano del regime di Neimeri contro la coalizione di forza che si opponeva ai tagli richiesti dal fmi anche se, alla fine, non riuscì a fermare la rivoluzione che l’avrebbe deposto nel 1985. In Somalia, gli aiuti militari statunitensi aiutarono Siad Barre ad attaccare gli Isaak, un episodio della perenne guerra portata avanti nell’ultimo decennio dagli organismi nazionali e internazionali contro i gruppi di pastori africani15. Anche in Angola, l’aiuto dell’esercito statunitense all’unita servì a costringere il governo a rinunciare al socialismo e all’aiuto delle truppe cubane, oltre che a negoziare con il fmi, e indubbiamente rafforzò il potere contrattuale delle compagnie petrolifere che operavano nel paese16.
Aiuti alimentari e guerre invisibili
In molti casi, quello che le armi non riuscirono a ottenere fu conquistato attraverso “aiuti alimentari” forniti dagli Stati Uniti, le Nazioni Unite e varie ong ai rifugiati e alle vittime delle carestie causate dalle guerre. Spesso somministrati a tutte e due le parti in conflitto (come in Sudan, Etiopia e Angola), gli aiuti alimentari sono diventati una componente cruciale della macchina da guerra neocolonialista contemporanea, e nell’economia della guerra generata da essa. Innanzitutto, ha concesso alle organizzazioni internazionali che non fossero la Croce Rossa il diritto a intervenire in aree di conflitto invocando il prestare soccorso (nel 1988 le Nazioni Unite approvarono una risoluzione che affermava il diritto dei donatori a fornire aiuti)17. È su queste basi che venne giustificato l’intervento militare statunitense/delle Nazioni Unite in Somalia nel 1992-1993 (Operation Restore Hope).
Pur quando non accompagnata da truppe militari, la fornitura di “aiuti alimentari” in situazioni di conflitto è sempre una forma di intervento politico e militare, poiché prolunga la guerra alimentando eserciti in lotta (spesso più della popolazione civile), modella la strategia militare e aiuta la parte più forte – quella meglio equipaggiata a trarre vantaggio dalla distribuzione del cibo – a vincere18. È esattamente quello che è successo in Sudan ed Etiopia negli anni Ottanta dove, fornendo “aiuti alimentari”, gli Stati Uniti, le Nazioni Unite e le ong come care divennero protagonisti della guerra allora in atto in quei paesi19.
Inoltre, gli aiuti alimentari contribuiscono allo spostamento e alla ricollocazione delle comunità rurali: costruendo centri organizzati attorno ai bisogni delle ong; essi minano oltretutto l’agricoltura locale facendo crollare il prezzo dei prodotti commercializzati e introducono una nuova fonte di alimentazione della guerra, perché la prospettiva di appropriarsi di grandi quantità di cibo e venderle localmente o sul mercato internazionale fornisce un ulteriore motivo di conflitto, creando un’economia della guerra specialmente in quei paesi radicalmente impoveriti20.
Gli effetti del sostegno alimentare sono tanto problematici, tanto è dubbiosa la loro capacità di garantire la sopravvivenza (che avrebbe funzionato meglio con la distribuzione di strumenti agricoli e semi, e soprattutto con la fine delle ostilità), che ci si deve chiedere se il vero motivo dietro a questa iniziativa non fosse l’eliminazione graduale dell’agricoltura di sussistenza e la creazione di una dipendenza a lungo termine dal cibo importato – entrambi punti focali della riforma portata avanti dalla Banca Mondiale, condizioni affinché le nazioni africane si “integrino” nel quadro dell’economia mondiale. Il dubbio è ancora più legittimo se consideriamo che gli effetti negativi degli “aiuti alimentari” sono noti fin dagli anni Sessanta, quando divennero oggetto di grandi proteste e ricerche in tutto il mondo delle ex colonie. Da allora, è quasi un assioma che “non si aiutano le persone dando loro cibo, ma dando loro gli strumenti affinché si nutrano da sole”, e che anche in condizioni di carestia, quello di cui le persone necessitano maggiormente per sopravvivere è conservare la capacità di coltivare. Come possano le Nazioni Unite e la Banca Mondiale aver dimenticato la lezione è inspiegabile, a meno che non presumiamo che l’arrivo degli “aiuti alimentari” nelle operazioni di guerra contemporanee in Africa abbia avuto come obiettivo primario la mercificazione della terra e dell’agricoltura, oltre alla sostituzione dei mercati alimentari africani con le imprese agroalimentari internazionali.
A questo si aggiunga che le “operazioni di soccorso”, contando sull’intervento di ong straniere e organizzazioni umanitarie, hanno marginalizzato ulteriormente le vittime di conflitti e carestie. È stato dato loro il diritto di controllare le attività di soccorso mentre sia i media internazionali che le stesse ong le hanno dipinte come essere impotenti incapaci di prendersi cura di loro stessi. Proprio come sottolineano Joanna Macrae e Anthony Swi, l’unico diritto riconosciuto è stato quello dei “donatori” di fornire assistenza che, come abbiamo visto, è stata usata (in Somalia nel 1992-1993) per richiedere l’intervento militare21.
Mozambico: un caso esemplare di guerra contemporanea
È con il caso del Mozambico che possiamo osservare al meglio come la guerra prima e i soccorsi umanitari poi possano essere utilizzati per ricolonizzare un paese, portarlo sul mercato e distruggere la sua resistenza alla dipendenza economica e politica22. La guerra che la Renamo (Mozambique National Resistence), un sostituto dell’apartheid in Sudafrica e negli Stati Uniti, scatenò contro questo paese per quasi un decennio (1981-1990) racchiude tutti gli elementi chiave dell’odierna globalizzazione della guerra:
-
La distruzione dell’infrastruttura di (ri)produzione fisica e sociale del Paese per provocare una crisi nella riproduzione e rafforzare la subordinazione economica e politica.
La Renamo è riuscita nel suo intento attraverso (a) l’uso del terrore sistemico nei confronti della popolazione (massacri, schiavitù, orrende mutilazioni) per costringere la gente a lasciare la terra e rendendola rifugiata (in questa guerra furono uccise oltre un milione di persone); (b) la demolizione di strade, ponti, ospedali, scuole, e soprattutto delle attività agricole e di ciò che producono – i mezzi di sussistenza basilari per una popolazione di agricoltori. Il caso del Mozambico dimostra l’importanza strategica della “guerra a bassa intensità”, a cominciare dall’uso delle mine che rendono impossibile alle persone coltivare la terra, creando di conseguenza una situazione di carestia che necessita di aiuto esterno.
-
L’uso di “aiuti alimentari” per spostare le persone e le vittime della carestia con l’obiettivo di assicurare che la condizionalità economica venga rispettata, creando dipendenze a lungo termine e minacciando la capacità del Paese di controllare il proprio futuro economico e politico. Non si deve dimenticare che gli aiuti alimentari fungono da forte spinta per le industrie agroalimentari statunitensi che ci guadagnano doppiamente, prima di tutto togliendosi di mezzo i propri enormi surplus, in secondo luogo traendo profitto dalla dipendenza dal cibo importato della nazione “aiutata”.
-
Il trasferimento del processo decisionale dallo stato alle organizzazioni internazionali e alle ong. L’attacco alla sovranità mozambicana fu così accurato che, una volta costretto a chiedere aiuto, il paese dovette accettare di lasciare carta bianca alle ong per quanto riguardava la gestione delle operazioni di soccorso, incluso il diritto a entrare in qualunque area del suo territorio e di distribuire cibo direttamente alla popolazione dove preferissero. Come rende noto Joseph Hanlon in Mozambique: Who Calls the Shots?, il governo non riuscì a protestare contro le politiche delle ong, pure nel caso di ong di destra come World Vision, che utilizzò la distribuzione dei soccorsi per fare propaganda politica e religiosa, o ong come care, sospettate di collaborare con la cia.
-
L’imposizione di condizioni di pace impossibili, come la “riconciliazione” e la condivisione del potere con Renamo – il nemico più grande del popolo e del governo mozambicano, responsabile di molte atrocità e del massacro di oltre un milione di persone – che hanno creato il potenziale per una destabilizzazione permanente. Questa politica di “riconciliazione”, oggigiorno cinicamente e ampiamente imposta, da Haiti al Sudafrica, come “condizione di pace”, è l’equivalente politico di una delle espressioni più rivelatrici della spinta ricolonizzatrice dei nostri giorni, poiché sostiene che i popoli del “Terzo Mondo” non dovrebbero mai avere il diritto di vivere in pace e di proteggersi da nemici ben noti. Sostiene anche che le nazioni non hanno tutte gli stessi diritti dato che gli Stati Uniti, o un qualsiasi paese dell’ue, non si sognerebbe mai di accettare una proposta tanto scellerata.
Conclusione: dall’Africa alla Jugoslavia e oltre
Il caso del Mozambico non è isolato. Non solo la maggior parte delle nazioni africane è praticamente guidata da organismi e ong supportati dagli Stati Uniti, la sequenza – distruzione delle infrastrutture, imposizione di riforme di mercato, riconciliazioni forzate con nemici assassini “incompatibili”, destabilizzazione – è possibile trovarla, a vari gradi e combinazioni, ovunque nell’odierna Africa, al punto che diversi paesi, come l’Angola e il Sudan, sono in uno stato di emergenza permanente, dove la loro possibilità di sopravvivenza in quanto entità politiche è ora dubbia.
È tramite questa combinazione di guerra finanziaria e militare che la resistenza dei popoli africani contro la globalizzazione è stata finora tenuta a bada, così come succede in America Centrale (El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panama) dove per tutti gli anni Ottanta l’intervento militare statunitense era la regola.
La differenza sta nel fatto che, in Africa, il diritto degli Stati Uniti/delle Nazioni Unite di mandare truppe è stato principalmente giustificato in nome del “mantenimento della pace”, “instaurazione della pace” e “intervento umanitario”, probabilmente perché sotto ogni altra condizione, l’arrivo dei marines (del tipo che abbiamo potuto osservare a Panama e Grenada) non sarebbe stato accettato a livello internazionale. Questi interventi, però, sono il nuovo volto del colonialismo, e non solo in Africa. È un colonialismo che punta a controllare le politiche e le risorse piuttosto che a guadagnare territorio. Nel contesto politico, è un colonialismo “filantropico”, “umanitario”, “a piede libero” che ha l’obiettivo di “amministrare” piuttosto che “governare”, poiché quest’ultimo implica un impegno a instaurare una specifica organizzazione istituzionale ed economica, mentre il libero imperialismo aziendale moderno intende mantenere la sua libertà di scegliere sempre l’organizzazione istituzionale, le forme economiche e i luoghi che meglio si adattano alle proprie esigenze23.
Che significato assume questo scenario per il movimento contro la guerra?
Innanzitutto, dovremmo aspettarci che la situazione sviluppatasi post modifiche in Africa – con il suo miscuglio di guerra economica e militare e la sequenza di adeguamenti strutturali-conflitto-interventi venga continuamente riprodotto negli anni successivi in tutto il pianeta. Possiamo aspettarci anche di vedere scoppiare altre guerre nelle ex-nazioni socialiste, dato che le istituzioni e le forze che stanno spingendo il processo di globalizzazione ritengono le aziende statali e altri residui del socialismo un grosso ostacolo alla “libera impresa”, come nel caso del comunitarismo africano.
Rispetto a questo, la guerra della nato contro la Jugoslavia costituisce probabilmente il primo esempio (dopo la Bosnia) di ciò che accadrà: la fine del socialismo di stato rimpiazzato dalla liberalizzazione e dal mercato libero, e l’avanzata della nato in Oriente fornisce una “struttura di sicurezza” alla regione. La relazione tra “l’intervento umanitario” della nato in Jugoslavia e “l’intervento umanitario” dei soccorritori – truppe di terra della macchina da guerra contemporanea – è così stretta da farci portare l’Africa nel Kosovo, dove si è visto come le vite africane ed europee agli occhi delle organizzazioni internazionali abbiamo un valore relativo, misurando la qualità e quantità delle risorse fornite ai rifugiati.
Vediamo anche come la situazione sia molto diversa dall’imperialismo del tardo Ottocento-inizio Novecento. I poteri imperialisti di quei tempi erano legati, ed erano responsabili, di sistemare il territorio socialmente, politicamente e a livello di infrastrutture. Perciò, all’epoca imperialista delle cannoniere e delle mitragliatrici, che potevano uccidere migliaia di persone da lontano, la responsabilità dei massacri, delle carestie e di altre forme di omicidio di massa erano sempre identificabili. Per esempio, sappiamo che fu re Leopoldo del Belgio ad avere una responsabilità personale per l’uccisione di milioni di persone in Congo24. Oggi milioni di africani muoiono ogni anno a causa delle conseguenze degli adeguamenti strutturali, ma nessuno è ritenuto responsabile di ciò che accade. Al contrario, le cause sociali di morte in Africa stanno diventando sempre più invisibili, come la “mano invisibile” del mercato capitalista25.
Infine, dobbiamo capire che non possiamo mobilitarci solamente contro i bombardamenti, né chiedere che essi abbiano fine e pensare di aver ottenuto la “pace”. Grazie allo scenario postbellico in Iraq sappiamo che la distruzione delle infrastrutture di un paese causa più morte delle bombe stesse. Dobbiamo accettare che la morte, la fame, malattie e distruzione sono ad oggi la realtà quotidiana per la maggior parte delle persone che vivono su questo pianeta. In aggiunta a questo, dobbiamo riconoscere che gli adeguamenti strutturali – il programma più universale del mondo odierno, quello che, in tutte le sue forme (che sia Crescita Africana o Opportunity Act), rappresentano il volto contemporaneo del capitalismo e del colonialismo, cioè la guerra. Perciò, il programma del movimento contro la guerra deve includere l’eliminazione dei programmi di adeguamento strutturale in tutte le sue forme e, cosa fondamentale, la costruzione di un mondo non più fondato sulla logica capitalista dell’accumulazione, se vogliamo che la guerra e il progetto imperialista che essa cela abbiano fine.
1 Thomas Pakenham, The Scramble of Africa. White Man’s Conquest of the Dark Continent From 1876 to 1912, Avon Books, New York 1991, p. 126.
2 Un conteggio ha individuato settantacinque paesi dove si sta svolgendo una qualche forma di guerra nel 1999 (Effe. La Rivista delle Librerie Feltrinelli, n°13, Feltrinelli, Milano 1999); tra questi, trentatré si trovano tra le quarantatré nazioni Africane. Si tratta della “Quarta Guerra Mondiale” contro i poveri del mondo di cui il Subcomandante Marcos scrive spesso.
3 Per una descrizione di questa nuova fase del capitalismo che enfatizza la scomparsa delle mediazioni tra classi si veda Midnight Notes Collective, Midnight Oil. La definizione “nuove chiusure” è utilizzata in questi articoli per indicare che la spinta del capitalismo contemporaneo è di distruggere qualsiasi garanzia di sussistenza riconosciuta dagli stati socialisti, postcoloniali o keynesiani negli anni Cinquanta e Sessanta. Per riuscire, il processo dev’essere violento.
4 L’enorme letteratura esistente sugli adeguamenti strutturali, la globalizzazione e il neoliberalismo ha ampiamente descritto questo trasferimento di ricchezza. Si veda Jeremy Brecher e Tim Costello, Global Village or Global Pillage. Economic Reconstruction from Bottom Up, South End Press, Boston 1994 (Trad. It. Contro il capitale globale. Strategie di resistenza, traduzione di Luigi Piccioni, Feltrinelli, Milano 2001); Walden Bello, Dark Victory. The United States, Structural Adjustment and Global Poverty, Pluto Press, London 1994 (Trad. It. La vittoria della povertà. La ricchezza degli Stati Uniti e la povertà globale, traduzione di Ester Dornetti, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2004); Richard J. Barnet e John Cavanagh, Global Dreams. Imperial Corporations and the New World Order, Simon and Schuster, New York 1994.
5 La letteratura sugli adeguamenti strutturali in Africa è altrettanto ampia. Dagli anni Ottanta, le ong (internazionali e locali) sono divenute essenziali per l’applicazione dei programmi di adeguamento strutturale; hanno preso possesso di aree di riproduzione sociale cui lo Stato è stato costretto a togliere fondi a causa degli stessi adeguamenti strutturali. Come scrive Alex de Waal: «La combinazione di neoliberalismo e difesa di un “volto umano” ha creato un nuovo ruolo per le ong, rendendole subappaltatrici di una gigantesca fornitura di servizi di base quali sanità, ampliamento agricolo e razioni di cibo… Spesso, le più grandi ong che forniscono servizi (care, Catholic Relief Services, Save the Children Fund), sono state chiamate durate crisi di carestia o dovute a crolli di governo, e da lì sono rimaste. In altri casi, le ong hanno messo i propri consiglieri nei ministeri (la sanità è il prediletto) e occasionalmente hanno preso la gestione di interi servizi. La fornitura di base per le cliniche nella capitale del Sudan, la prima assistenza sanitaria nell’Uganda rurale e quasi tutti i programmi di tubercolosi e lebbra in Tanzania sono solo tre dei programmi “nazionali” di sanità gestiti direttamente dalle ong internazionali con i fondi dei donatori istituzionali di Europa e America (Famine Crimes. Politics & the Disaster Relief Industry in Africa, African rights & The International African Institute, London 1997, p. 53).
6 Un buon esempio di questo saccheggio dei gruppi più deboli si può trovare in Sudan dove, sul finire degli anni Ottanta, il governo diede alla milizia Murahaliin, portata dai Baggara Arabs, il diritto di razziare le greggi dei Dinka. «Le razzie erano frequenti, diffuse e devastanti. Rubavano bestiame, distruggevano villaggi, avvelenavano i pozzi e uccidevano indiscriminatamente. Chi veniva catturato finiva in schiavitù. Chi sopravviveva perché non era presente al momento dell’attacco, scappava nelle città di guarnigione dove veniva costretto a vendere il proprio bestiame e altre proprietà a poco prezzo» (Alex de Waal, op. cit., p.94). Per ulteriori informazioni si veda Mark Duffield, The Political Economy of the Internal War. Assett Transfer, Complex emergencies, and International Aid, in Joanna Macrae e Anthony Swi, op. cit., pp. 54-57.
7 Jean-Francois Bayart, Stephen Ellis e Béatrice Hibou , The Criminalization of the State in Africa, The International African Institute in Association with James Curry, Oxford 1999.
8 Ibid.; Ohil Williams, The Nature of Drug-Trafficking Networks, in Current History, aprile, University of California Press, Oakland 1998.
10 Martin Stone, The Agony of Algeria, Columbia University Press, New York 1997.
11 Human Rights Watch, Africa, Slaves, Street Children and Child Soldiers, Human Rights Watch, New York 1995.
12 Per un’analisi delle politiche della Banca Mondiale per la promozione della capitalizzazione dell’agricoltura in Africa si veda George Caffentzis, The Fundamental Implications of the Debt Crisis for Social Reproduction in Africa, in Mariarosa Dalla Costa e Giovanna Franca Dalla Costa (a cura di), Paying the Price. Women and the Politics of International Economic Strategy, Zed Books, London 1995, pp. 15-41 (traduzione da: Donne e politiche del debito. Condizione e lavoro femminile nella crisi del debito internazionale, Franco Angeli, Milano 1993).
13 Silvia Federici, The Debt Crisis, Africa and the New Enclosures, in Midnight Notes (a cura di) Midnight Oil. Work, Energy, War, 1973-1992, Autonomedia, New York 1992, pp. 303-317.
14 L’effettiva guerra tra il governo e i fondamentalisti islamici cominciò con il rifiuto da parte del primo di riconoscere la vittoria elettorale dei fondamentalisti nel 1992. Ma le radici del conflitto devono ricercarsi nella dura risposta che il governo diede nel 1988 durante i disordini in protesta contro il fmi. Si veda Martin Stone, op. cit.
15 Nel 1987, Oxfam riportò che un funzionario della Commissione Europea rispose alla richiesta di aiutare i pastori nel Sudan meridionale con una profetizzazione: «A suo dire, il pastoralismo e, in ogni caso, non vitale e in declino in tutta la regione». Oxfam commentò: «È importante notare che usaid, unicef ed eec hanno tutte espresso visioni simili riguardo il pastoralismo nel Sud; cioè che sta per finire e che in vent’anni sarebbe comunque successo. David Keene e Ken Wilson, Engaging with Violence. A Reassessment of Relief in Wartime, in Joanna Macrae e Anthony Zwi (a cura di), op.cit., p. 214; Africa Watch Report, Somalia. A Government at War with Its People, Human Rights Watch, New York 1990.
16 David Sogge, Angola. Surviving against Rollback and Petrodollars, in Joanna Macrae e Anthony Zwi (a cura di), op. cit., p. 105.
17 Ivi, pp. 11-12. Come scrive Alex de Waal: «Il primo accordo di negoziato per l’accesso a una zona di guerra [fu] l’Operation Lifeline in Sudan, nell’aprile del 1989… [a questo] seguì nel 1991-91 il concetto di operazioni “transfrontaliere”, per esempio nell’Etiopia dell’Est, dove unhcr, unicef e wfp assistevano rifugiati, persone lontane da casa e residenti impoveriti senza alcuna discriminazione. Questo approccio si sviluppò poi nell’ex Jugoslavia, in Alex de Waal, op. cit., p. 69.
18 Duffield, The Political Economy of Internal War, pp. 60-63.
19 Uno degli esempi migliori di questa trasformazione degli enti umanitari in protagonisti militari è l’assistenza fornita dagli Stati Uniti e dalle Nazioni Unite al governo etiope nella guerra contro il Fronte di liberazione del popolo eritreo (eplf) e del Fronte di liberazione del popolo del Tigray (tplf) negli anni Ottanta. La famosa carestia “Siamo bambini” del 1984-85 non fu causata dalla siccità, dalla sovrappopolazione o dall’uso improprio della terra come si diceva. La sua vera causa furono le varie offensive del governo etiope contro l’eplf e il tplf, oltre ai suoi programmi di ricollocazione che spostarono a forza centinaia di migliaia di persone dal nord al sud del paese (durante la traversata morirono in cinquantamila). Gli aiuti alimentari offerti dagli Stati Uniti, dalle Nazioni Unite e da varie ong (che ammontarono a quasi tre miliardi di dollari tra il 1985 e il 1988) furono cruciali per continuare lo sforzo bellico del governo etiope, oltre al suo programma di ricollocazione. La cooperazione e complicità con gli Stati Uniti, le Nazioni Unite e le ong fu talmente intensa che il personale dei tre enti, insieme al governo etiope, nascosero le cause della carestia; nascosero il dirottamento degli aiuti alimentari all’esercito (al massimo il 15% degli aiuti andò ai civili), nascosero i costi umani del programma di ricollocamento, accompagnarono l’esercito etiope nella sua corsa facendogli “guadagnare accesso alle aree afflitte dalla carestia” e, ciliegina sulla torta, si lamentarono a gran voce che i loro sforzi umanitari erano ostacolati quando l’eplf o il tplf riconquistarono il territorio! Alex de Waal, codirettore di African Rights, ci ha donato un resoconto accurato e illuminante di questa truffa, importante soprattutto perché l’autore del testo fu coinvolto direttamente negli eventi di cui parla (Alex de Waalm, op. cit., pp. 115-127).
20 Mark Duffield, op. cit.
21 Joanna Macrae e Anthony Swi, op. cit.
22 Joseph Hanlon, Mozambique and Peace Without Profit. How the IMF Blocks Rebuilding in Mozambique, James Currey, Oxford 1996.
23 Analogamente alla “nuova schiavitù” discussa da Kevin Bales, dove i proprietari di schiavi contemporanei in Thailandia e Brasile rifuggono dalla responsabilità dei propri schiavi, in modo che siano “usa e getta” quando non generano più profitto (Disposable People. New Slavery in the Global Economy, University of California Press, Berkeley 1999; Trad. It. I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale, traduzione di Maria Nadotti, Feltrinelli, Milano 2010).
24 Adam Hochschild, King Leopold’s Ghost, Houghton Mifflin Co., Boston 1998; Trad. It. Gli spettri del Congo. La storia di un genocidio dimenticato, traduzione di Roberta Zuppet, Garzanti, Milano 2022.
25 John Walton e David Seddon, op. cit.