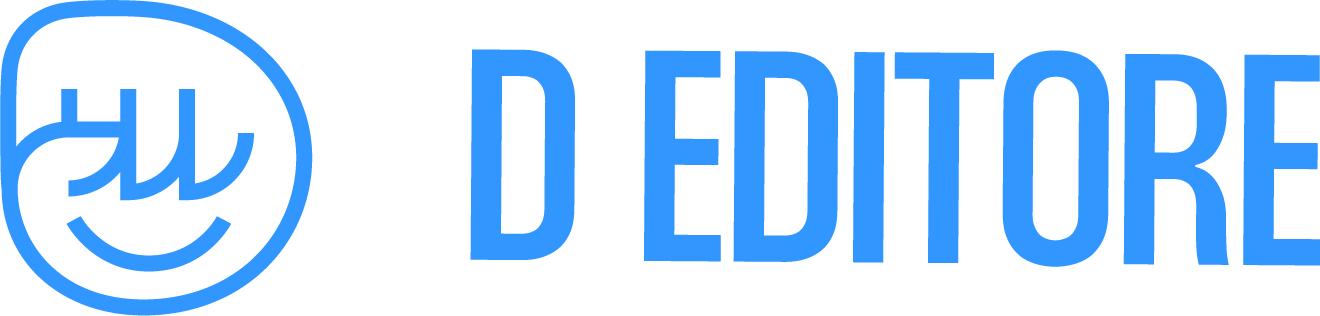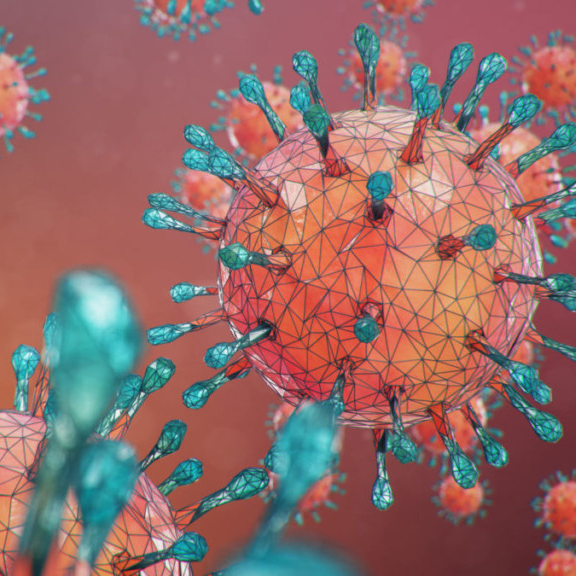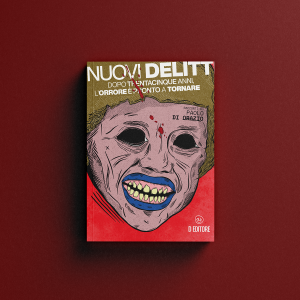Città inclusive per la fine del Mondo
Pubblichiamo in quest’occasione un saggio apparso in ZombieCity, raccolta curata da Alessandro Melis e in uscita per D Editore.
∞
Oltre che dagli uomini, fin dall’antichità le città sono state popolate da dei onnipotenti, benigni ma a volte crudeli. Spesso vivevano accanto a noi, vicino al focolare, al centro degli spazi pubblici o nelle viscere della terra. Altre volte in città separate e celesti. Poi venne il tempo dei diavoli e degli angeli. Infine, quello dei vampiri e degli orchi. Nella modernità, abbiamo incontrato zombie, alieni, robot e avatar.
Ognuna di queste rappresentazioni era il risultato di un conflitto interiore dell’uomo, fin dalla nascita del pensiero associativo, tra l’ideale platonico dell’astrazione per categorie e la minaccia di un universo parallelo, a volte oscuro e irrazionale.
Grazie a Freud, solo in tempi recenti abbiamo compreso che alcune di queste paure si nascondevano nelle profondità dell’inconscio e, talvolta, ci raccontavano che l’uomo è la più grande minaccia alla propria sopravvivenza.
Da allora la certezza che il mondo potesse essere suddiviso in categorie, immutabili e razionali ci ha abbandonato.
Le classificazioni, infatti, non sono «dispositivi di ordinamento passivo in un mondo oggettivamente suddiviso in categorie ovvie. Le tassonomie sono decisioni umane imposte alla natura – teorie sulle cause dell’ordine delle nature. La cronaca dei cambiamenti storici nella classificazione fornisce la nostra migliore comprensione delle rivoluzioni concettuali nel pensiero umano. La natura oggettiva esiste, ma possiamo dialogare con lei solo attraverso la struttura dei nostri sistemi tassonomici».
Più di ogni altro prodotto della creatività dell’uomo, la città, che si basa sulle sue categorizzazioni, ha risentito di questi conflitti. Per questo, la fenomenologia dei morti viventi, ancora oggi, ha il potenziale di una profezia, sulla degenerazione delle città e come luogo ideale di proliferazione del parassitismo umano.
La vastissima cinematografia e letteratura sugli zombie, ci insegna che la resilienza delle città, intesa come capacità di adattamento ai cambiamenti spesso inaspettati, è una prerogativa essenziale per la futura pianificazione urbana. La resilienza, con le sue opportunità, la variabilità e la ridondanza delle forme, l’autosufficienza delle risorse, è quindi l’unica via per la sopravvivenza in caso di zombie outbreak. Al di fuori della metafora, il caso della pandemia attuale ne è conferma.
Diversi studiosi hanno esplorato l’importanza dell’impatto sulle città delle crisi e quali siano le tendenze positive verso il cambiamento. Sappiamo, ad esempio, che gli spazi verdi integrati con l’edilizia abitativa aumentano la resistenza ambientale e psicologica degli abitanti, oltre a ridurre i disturbi mentali.
La resilienza delle città è quindi proporzionale alle molteplicità di opzioni ed opportunità che è in grado di offrire, indipendentemente da ciò per cui è stata progettata. Questa convinzione deriva dalla trasposizione in urbanistica delle teorie della biologia dell’evoluzione e della paleoantropologia e, conseguentemente, corrobora l’immagine metaforica dello zombie come agente di crisi.
La biologia dell’evoluzione ci insegna, infatti, che la resilienza di una struttura è data dalla proliferazione di forme e sottostrutture creative, cioè potenzialmente cooptabili da funzioni anche inaspettate, come conseguenza a cambiamenti ambientali anche improvvisi.
La progettazione delle città, per garantire resilienza, deve offrire opportunità di adattamento al cambiamento, attraverso la molteplicità di scelte, tra cui anche quelle non previste dalla progettazione stessa.
Proseguendo il ragionamento, si può affermare che la crisi della città attuale risieda nel suo determinismo e nell’avere interpretato alcune soggettive posizioni culturali come tendenze oggettive verso un presunto progresso.
È qui che il conflitto interiore dell’essere umano, dovuto all’insufficienza della razionalizzazione per categorie, si riflette nella rappresentazione della città.
Secondo gli storici, la città che conosciamo, la sua organizzazione e, in una certa misura, la sua mancanza di resilienza, è il prodotto di una società centrata sull’uomo, inteso come essere umano di sesso maschile.
Secondo Stephen Jay Gould, «Stiamo ancora soffrendo di un retaggio vecchio quanto Platone, una tendenza ad astrarre un singolo aspetto ideale o una media per farne l’essenza di un intero sistema, e a svalutare o ignorare le variazioni tra gli individui che costituiscono l’intera popolazione».
Questa è stata, appunto, un’idea di progresso fallimentare anche per la città.
Nonostante le persone potessero essere categorizzate in due grandi gruppi, chiamati maschio e femmina, secondo la prospettiva dell’umanesimo, la città ideale era chiaramente un «modello a un solo sesso, basata sul corpo umano maschile, inteso come modello di eccellenza ed elevata idealizzazione […]. Esisteva solo un’idea o un corpo archetipico e tutte le espressioni reali (persone) dovevano rientrare in uno gradino lungo un singolo continuum dell’avanzamento metafisico».
Questa concezione era il risultato, appunto, di un’astrazione che allora, platonicamente, sembrava un’invariante e quindi metafisica. Nel one-sex model, la virilità convenzionale, in virtù di una maggiore forza, si trovava vicino all’apice della singola sequenza, mentre la caratteristica forma femminile, attraverso la relativa debolezza delle stesse forze generiche, era posizionata molto in basso nella singola scala evolutiva.
Tra gli esempi che si possono fare oggi, certamente la maggiore resistenza delle donne al COVID-19 e, più in generale la loro aspettativa di vita, non solo ci confermano che la presunta forza dell’uomo fosse il risultato di una limitata comprensione del mondo in tutta la sua complessità, ma che oggi rischieremmo di fare lo stesso errore se pretendessimo di costruire una classificazione oggettiva su queste più recenti conoscenze. Per questo, lo zombie è oggi una wild card necessaria per comprendere che ogni tassonomia può essere destabilizzata dalle forze della natura e dalla natura stessa dell’uomo. Lo zombie ci ricorda che in biologia non esiste il concetto di singola scala evolutiva che tende al progresso e che nessun essere animato, e perfino inanimato secondo Heidegger, occupa un ruolo di privilegio nell’ecosistema.
La prospettiva femminile è oggi un potenziale innovativo, dirompente e originale, non solo come alternativa di genere a quella maschile. L’ideologia femminista e l’uguaglianza, o le teorie di genere, non sono rilevanti in quanto ideologie: è più importante riscoprire un patrimonio di conoscenze che è stato finora ai margini della società convenzionale, che potrebbe condurre a opportunità per tutti.
La domanda “Come può una città progettata da/per la donna contribuire ad aumentare la resilienza urbana?” implica che una città costruita dalle donne per accogliere il comfort e le esigenze delle donne possa di conseguenza avere un impatto positivo per tutti e non solo per il genere femminile.
Gli effetti del contesto urbano sulla salute mentale sono stati riconosciuti e dimostrati dagli studiosi, ma la prospettiva della donna come un soggetto in grado di alimentare la pratica della pianificazione urbana potrebbe potenzialmente offrire un nuovo approccio più equilibrato al benessere della società.
L’idea della città femminile, quindi, è il punto di partenza per futuri studi sulle città che accolgono un ampio numero di soggetti, anche non umani, i quali possono contribuire alla sua evoluzione.
Tuttavia, se accettiamo la lettura, in chiave biologica, dell’evoluzione resiliente dalla città, la prospettiva femminile può essere quindi uno strumento importante, ma non sufficiente, nel processo di diversificazione della città in chiave di resilienza.
Dobbiamo ammettere che il vecchio modello è sicuramente sessista, come il successivo «”modello a due sessi” che presenta differenze innate e predeterminate di valore fin dall’inizio, ma per ragioni diverse – e dobbiamo capire questa storia di tassonomia radicalmente modificata se vogliamo cogliere la profondità dell’oppressione attraverso i secoli».
Infatti, anche il modello a due sessi è il risultato di una classificazione. Possiamo considerare quella del “maschio contro femmina” come una dicotomia permanente, come espressione di due percorsi alternativi nello sviluppo embriologico e nella successiva crescita. Eppure, anche il “modello a due sessi” ha prevalso solo di recente nella storia occidentale, «e non riuscì a dominare fino a quando la filosofia meccanica di Newton e Cartesio sconfisse il neoplatonismo delle precedenti visioni del mondo».
Le categorie cambiano nel tempo, e rispondono alla cultura. Seppure in continuo dialogo con essa, le categorie sono l’imposizione umana sulla natura e, pertanto, cambiano e rispondono alla cultura del tempo, come la divisione “ovvia”, secondo noi, degli esseri umani in due sessi.
Lo zombie è, quindi, di volta in volta, la categoria che non conosciamo, a cui tuttavia dovremmo rispondere. Il prossimo passo per la resilienza sarà quindi la città organizzata secondo una classificazione multi-sessuale. E, oltre ad essa, si dovrà riflettere sui modelli meta-sessuali.
Forme e usi della città “diversa”
Ma in cosa si potrebbe differenziare la città, o meglio l’insediamento che accolga la diversità a partire dalla multi- e meta-sessualità?
Coerentemente con la premessa, possiamo immaginare una città femminile, come un primo passo per la diversificazione e l’inclusività. Marco Romano, nel suo recente Città delle donne, sostiene di aver trovato tracce dell’influenza, sempre sottovalutata o nascosta, delle donne nella organizzazione delle città storiche. L’accoglienza di alcuni spazi pubblici, come per esempio i portici di fronte alle botteghe, sembrano preludere all’uso dello spazio da parte delle donne. In alcuni tratti scenografici, come le facciate barocche, si può intravedere nella città la vocazione per lo spazio teatrale declinato al femminile.
Tuttavia, si ha l’impressione che quella di Romano, per quanto intrigante, sia piuttosto una narrazione che però non consente di indulgere sul fatto che anche un’eventuale influenza femminile nella progettazione sia passata attraverso una lettura e interpretazione al maschile.
Per incontrare i primi tentativi di reimpostare in modo paradigmatico la città sulla diversità di genere bisogna aspettare fino ai tempi più recenti. Proprio negli anni delle sperimentazioni delle comunità hippie, che della liberazione sessuale avevano fatto un manifesto, risale la prima evidenza incontrovertibile dell’influenza femminile nell’idea di città. Nel 1962, Jane Jacobs scrive, infatti, il rivoluzionario The Death and the Life of the Great America Cities, che mette in crisi il modello urbano dominante, anche come feticcio della fase eroica del capitalismo americano, ormai agonizzante. Allo stesso tempo, questo testo mostra anche che la prospettiva femminile, meno compromessa dalla convenzionalità, consente un imprevisto slancio in avanti, lo stesso che, in architettura, aveva contribuito al successo di architetti come Lina Bo Bardi e Denise Scott Brown.
E stupisce che le intuizioni di Jacobs siano presenti in una dimensione programmatica soltanto in tempi recentissimi, come nella Vienna contemporanea. Il quartiere di Aspern, ad esempio, che è stato deliberatamente progettato con una chiara identità di genere femminile, offre esempi di spazi a dimensione d’uomo (e donna!) e di inclusività estesi. Tutte le strade e gli spazi pubblici prendono il nome da donne, come a dire che anche l’aspetto simbolico ha la sua importanza comunicativa.
Il complesso Frauen-Werk-Stadt (Women-Work-City), del 1997, progettato da donne, offre una prospettiva su usi in genere poco considerati dagli uomini: «Il deposito carrozzina su ogni piano e le ampie scale a incoraggiare le interazioni del vicinato; layout flessibili e locali secondari di alta qualità; fino all’altezza dell’edificio, abbastanza basso da garantire la vista della strada».
Due anni dopo, a Margareten, sono stati preferiti i campi per pallavolo e badminton alle convenzionali gabbie da basket; le corti sono state progettate per accogliere sedute per gruppi di ragazze, per chiacchierare e guardarsi intorno. La qualità dell’illuminazione e l’ergonomia dei percorsi favoriscono il senso di sicurezza e incoraggiano la sosta.
Il dibattito sull’equità di genere a Vienna, come detto, si è rapidamente orientato verso strumenti di emancipazione sociale soprattutto in termini di accessibilità universale.
I lavori di Mariahilf, tra il 2002 e 2006, hanno riguardato un miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle aree che, secondo le indagini preliminari, causavano un senso d’ansia; i semafori sono stati modificati per dare la priorità ai pedoni; sono aumentate le seduti pubbliche; sono state eliminate le barriere architettoniche, in modo da accogliere le carrozzine, oltre alle sedie a rotelle e favorire l’accoglienza delle persone anziane.
Secondo Giorgia Vitale di Arup, la pianificazione e la progettazione attente all’equità di genere devono essere fondamentalmente più inclusive in generale per l’intera comunità. Se vogliamo che questa si appropri del luogo, ne curi e celebri, gli spazi condivisi, è indispensabile ripensare la città in termini di brevi distanze e considerare l’accessibilità, mirare all’accoglienza e all’utilità dello spazio: mixed use degli edifici e uso del suolo differenziato, trasporto pubblico più accessibile, con maggiore frequenza e opzioni, maggiore la sicurezza e localizzazione più strategica e ibrida delle strutture sociali.
Gli esempi su citati mostrano dunque un’attenzione verso usi desueti o non riconosciuti che acquisiscono centralità nella città al femminile come strumento di apertura verso una città multi-sessuale più resiliente, ma che ancora poco ci dice riguardo alla percezione estetica dell’architettura da una prospettiva femminile.
Su questo occorrerebbe approfondire il tema a partire dalle due autrici forse più emblematici: Kazuko Sejima e Zaha Hadid.
Gli estremi del minimalismo architettonici della prima e il profluvio massimalista della seconda propongono due interpretazioni opposte di sensualità estetica che lasciano presagire che oltre ad un universo di usi, un’architettura femminile apra le porte anche a un universo di forme ancora oggi sconosciute.
Conclusione
Nelle premesse abbiamo individuato una tendenza rivolta alla centralità dell’uomo, nella società umana che ha condotto a un modello che oggi, di fronte a crisi globali, si è dimostrato poco resiliente. La diversità aumenta la variabilità e dunque la possibilità di adattamento. Giustizia ed equità non sono dunque categorie esclusivamente ideologiche, ma esprimono qualità che aumentano le nostre possibilità di sopravvivenza. Negli esperimenti recenti il punto di vista femminile è stato fondamentale non solo per una maggiore fruizione dello spazio da parte delle donne, ma anche per porre maggiore attenzione verso le minoranze e le categorie meno avvantaggiate. Infatti, la prospettiva femminile, più orientata all’accoglimento, ha consentito lo sviluppo di quartieri più sicuri, con migliori infrastrutture e maggiormente accessibili, contaminazione ed estensione degli usi convenzionale verso attività prima sottovalutate. Tuttavia, l’ecologia oggi ci insegna che anche il modello a due sessi è un modello limitato. Gli esempi proposti in questo testo mostrano che la visione radicale ed eversiva della donna apre a prospettive più estese e inclusive che superano anche la tradizionale interpretazione dei generi. Nuove prospettive ci impongono di rivolgere la nostra attenzione a modelli multi-sessuali e meta-sessuali di cui, purtroppo, oggi non esistono esempi significativi.