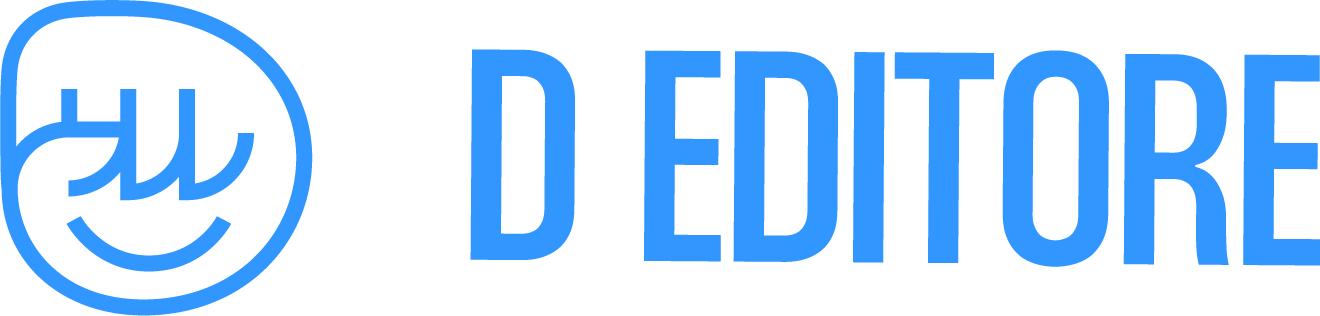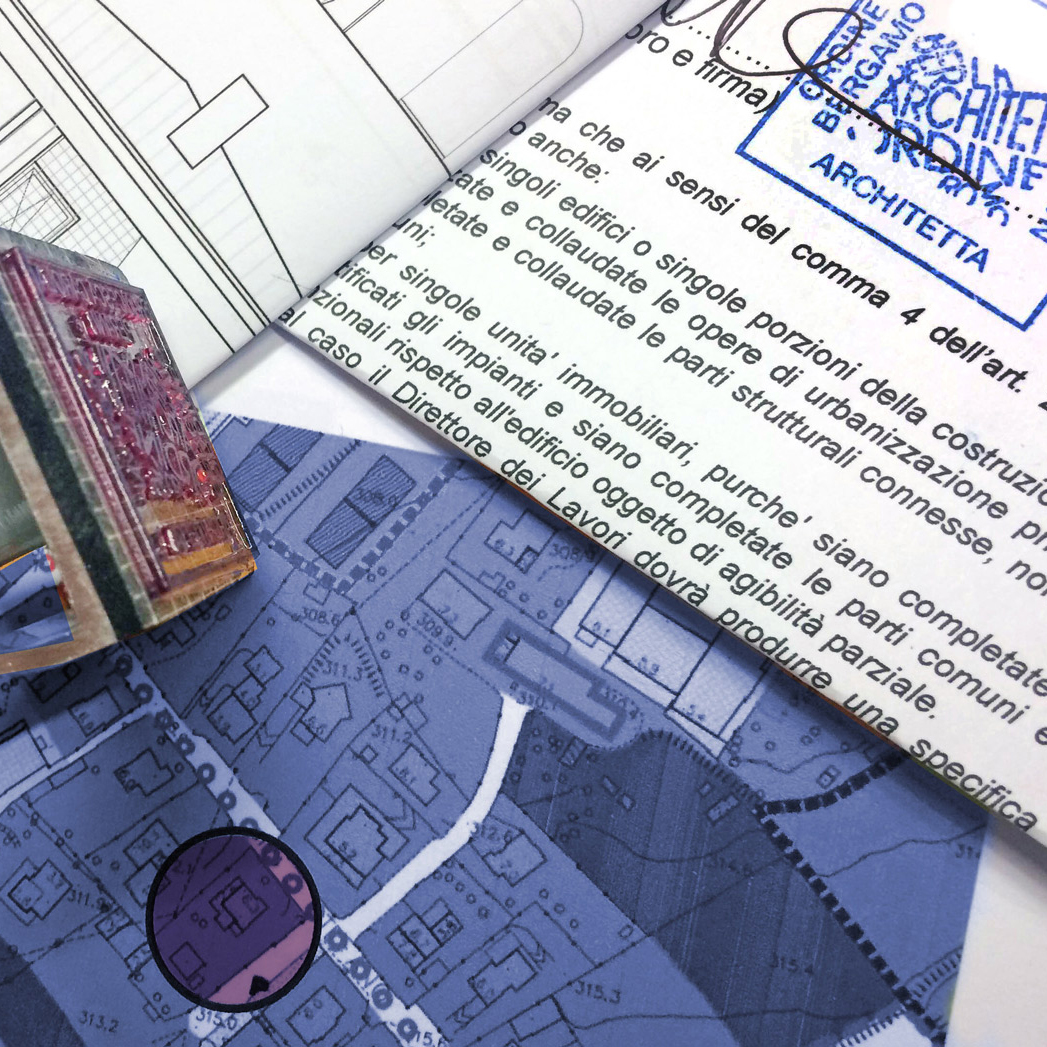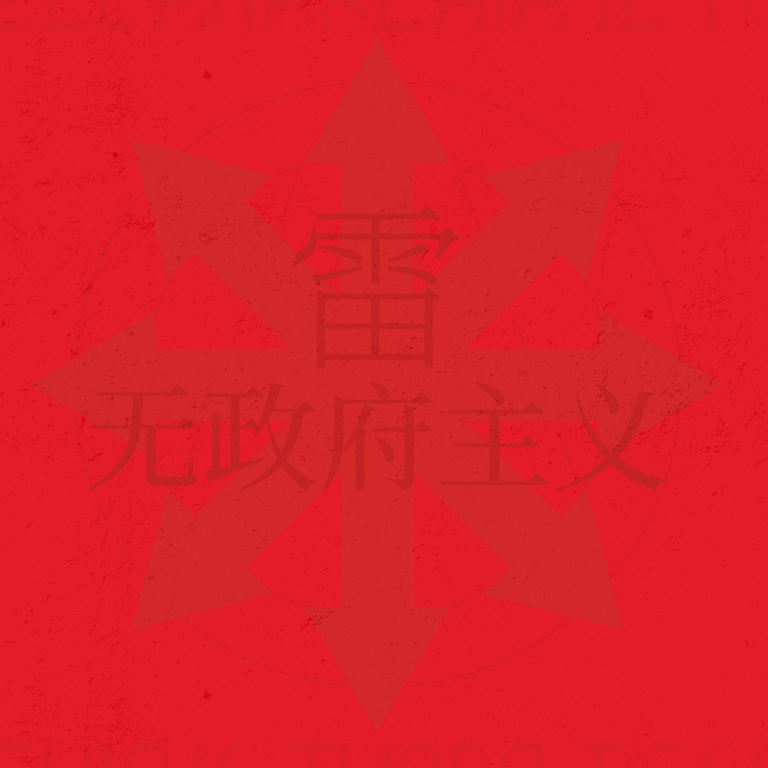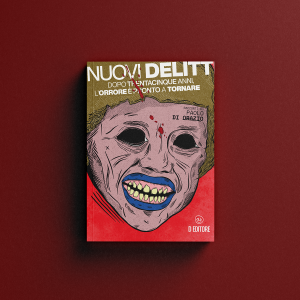Un architetto, due architette
∞
Quando si parla di mestieri al femminile inizia sempre a serpeggiare una sorta di imbarazzo, una nube nera che si ammassa sopra le nostre teste. Un misto di rabbia e confusione che ci infastidisce come ogni cosa non meglio definita. La questione delle donne in architettura solleva una molteplicità di voci, obiezioni, retorica e proteste che si fa fatica a mettere in ordine e a cui è difficile dare una forma. Intrappolati nel retaggio sessista e reticente della società maschilista, ci dimentichiamo spesso che essere architettrici, o architette, non è qualcosa che accade soltanto oggi. Plautilla Bricci, o Briccia, così come ce la racconta Melania Mazzucco ne L’architettrice, è esistita e ha realizzato, con il suo talento, dei lavori straordinari. Ma allora perché non si parla mai abbastanza del lavoro delle donne? Perché è sempre sottopagato rispetto a quello dell’uomo? Possibile che la parità di genere risieda nella declinazione al femminile dei nomi e delle professioni? Possibile che in pieno XXI secolo si debba ancora lottare per questo?
Più volte io stessa ho pensato che la soluzione fosse la neutralità del nome. Mettere una bella “n” affianco alla parola architetto nel vocabolario, complice anche il fatto che nella mia terra la società antica tradizionale è profondamente matriarcale. È la donna che gestisce le finanze, che organizza la vita della casa e pianifica le nuove attività. Mentre l’uomo lavora e porta, come si suol dire, i soldi a casa, la donna non perde il suo valore. O meglio ancora, il suo merito. Ma perché non è sufficiente? La realtà è che la nostra eredità sociale, economica e sistemica è così antica e pesa così tanto sulle nostre spalle che facciamo fatica a sovvertire l’ordine dei fattori.
Ho assunto allora una posizione ipotetica diametralmente opposta. E se il termine architetto funzionasse come la parola carcere o come gregge? Se fosse: 1 architetto, 2 architette/architettrici. Cosa ne penserebbe la nostra società patriarcale, narcisista ed egocentrica?
Se mi è concesso un paragone molto azzardato (o forse no?), la condizione della donna è come la schiavitù del popolo africano deportato in America. È come se fosse successo l’altro giorno. Si tende ad ignorare i vari Lincoln e Martin Luther King, che abbiamo talmente tanto interiorizzato da diventare delle figure mitologiche quasi innocue. Non sto cercando di sminuire l’importanza di coloro che hanno lottato per i propri diritti, per una causa più alta, al contrario, vorrei spostare l’attenzione sull’altra parte in causa ed evidenziare la sua ostinazione e tendenza all’ingiustizia sociale, l’ignoranza e la paura che si genera quando un cambiamento è in atto, soprattutto se si tratta di un cambiamento inascoltato. Sembra che in generale, il genere umano tenga sempre l’istinto di autoconservazione attivo finché può ed eviti di modificare un qualunque tratto comportamentale, finché questo non diventa inevitabile e a tratti violento. Non sta forse succedendo lo stesso con il cambiamento climatico? Con l’uso indiscriminato di tutte le nostre riserve di materie prime? Con l’impiego dei combustibili fossili? (che a questo punto, spererei che finissero una volta per tutte, se non sapessi che: 1) non abbiamo abbastanza tempo e 2) non servirebbe a niente se non ad alimentare la disperazione per il crollo delle borse, il crack dell’economia di una società che ancora non si è predisposta al cambiamento e ora come ora è destinata a frantumarsi). La società prettamente maschile e illuminata non aveva considerato il rovescio della medaglia. La donna è l’attrice in grado di riportare l’equilibrio in una società per definizione e composizione ingiusta. Quale gruppo, comunità, entità potrebbe mai funzionare se costituita da un solo genere di componente?
Le donne in architettura (ma non solo) hanno ancora bisogno di gridare. E la questione del nome, com’è stato detto più volte, è solo la punta dell’iceberg e non deve essere confusa con una versione sciocca e becera di femminismo. Un nome non è nulla, eppure è tutto quando non viene riconosciuto. Quando questo implica la mancanza di imparzialità, la presenza costante di approvazione di cui una delle parti non beneficia mai, la sconcertante ovvietà di una differenza di salario, episodi di stupido sessismo, il gridare al miracolo quando professioniste come Zaha Hadid, Lina Bo Bardi, Charlotte Perriand o Eileen Gray conquistano il loro spazio e un riconoscimento.
Non si tratta di eccezionali rarità esotiche. Non è straordinarietà, ma è la normalità. Non si tratta di mosche bianche (o elefanti bianchi, piuttosto! Ingombranti, ma invisibili allo sguardo che non vuole vederli), il fatto che non vengano prese in considerazione non significa che non esistano. Davvero stiamo ancora parlando delle donne mettendone in dubbio le capacità, l’intelligenza e l’attitudine? È possibile sapere perché e secondo quale assunto scientifico?
Davvero stiamo ancora decidendo chi è più bravo, intelligente o talentuoso tra generi diversi, ignorando deliberatamente la compagine variegata e ricca della comunità di cui fanno parte?
Basterebbe pensare a Jane Jacobs e alle sue intuizioni di 60 anni fa per comprendere che le capacità delle architette e delle architettrici ci servono, almeno quanto ci servono quelle degli architetti. Che in una società equa e giusta non c’è necessità di distinzione tra uomini e donne. Che in un ambiente, in questo caso lavorativo, un clima di parità ‒ come quello che si respira nel Padiglione Italia di quest’anno e che rappresenta una delle nostre più profonde convinzioni ‒ annulla la necessità di essere altro rispetto al resto, di farsi valere a discapito degli altri, di individuare il genere debole (gentil sesso, per essere più carini) e cercare di farlo fuori per puro pregiudizio (spesso e volentieri anche di altre donne). In una comunità come questa, in cui esiste diversità, variabilità, equità (e non più tolleranza) non si tratta più di individuare il nome corretto.
Esiste solo la possibilità di agire come professionista. Senza articolo, senza genere. Meravigliosamente neutro.