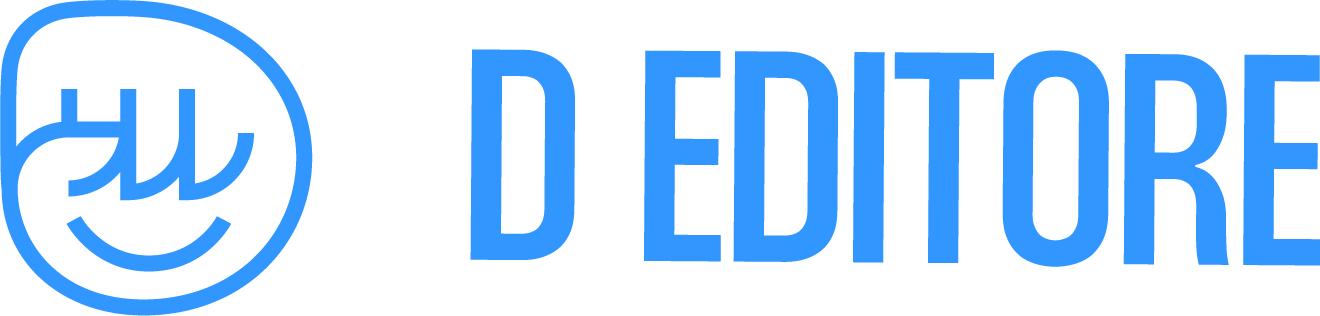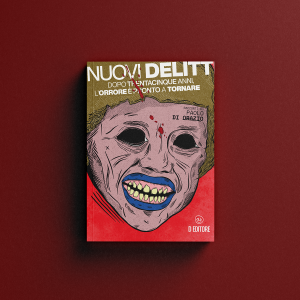Amore e morte
di Itziar Ziga
La violenza di genere è un dramma sociale terribile, e per molte persone rappresenta una gabbia da cui è impossibile fuggire. Nel suo ultimo libro, La felice e violenta vita di Maribel Ziga, la nota attivista transfemminista Itziar Ziga racconta le violenze subite da sua madre Maribel. Qui, un estratto.
∞
Mentre mia madre entrava in coma irreversibile, Jimmy Somerville cantava nei miei sogni. You may break the skin but you can’t kill the soul I’ve had all I can take. I’m leaving tomorrow… Mi svegliò il messaggio fatale di mia sorella. Quella notte toccava a lei stare in ospedale. Tornai alla UCI, crisi cardio-respiratoria. Sapevo che era la fine. Uscendo di casa con María, gennaio regalava un’alba rosa brillante e gli accordi epici della canzone ancora mi risuonavano dentro. Non arrivai in tempo per vederla cosciente.
Alla mia amatxo e a me piaceva The Communards e la sua disco music aggressiva. E a lei piaceva moltissimo come si muoveva Jimmy Somerville, che le ricordava una lucertola. Penso che questo controtenore frocio e ribelle che cantava contro l’omofobia, contro la crudeltà e contro la Thatcher, ha musicato l’addio più difficile della mia vita, e gli sarò sempre grata per questo. Sei anni dopo, fatico ancora ad ascoltare Tomorrow, pur essendo una delle mie preferite da bambina. Eppure, spesso torno col pensiero a quelle note e ritrovo la luce.
Morì a fine gennaio, in poche settimane. Le dissi che poteva andare, che io e Ainhoa saremmo state bene, che non avrei lasciata Ainhoa sola, che il suo amore prezioso e mai asfissiante ci aveva insegnato a cercare la felicità… Appoggiai la mia fronte sulla sua, guardai i suoi occhi velati per il coma e le parlai di quel pomeriggio d’estate del 1987.
Improvvisamente, avevamo deciso di sdraiarci nello stretto balcone – non lo avevamo mai fatto – quindi siamo corse verso il mio materasso. Fu una madre burlona, come le madri migliori, che faceva le ragazzate. Non riuscivamo a smettere di ridere. Spiavamo i passanti attraverso un buco tra i mattoni e gridavamo cose assurde. La Ari si è unita a noi euforica e noi tre siamo rimaste così, la madre, la figlia e la cana, fluttuando in una felicità assoluta. Quasi trent’anni dopo, le ricordai quel pomeriggio radioso e le dissi che poteva andare.
Tutte e due eravamo in pace con i nostri demoni e con la violenza di mio padre.
Le infermiere avevano appena finito di ritirare tutta la ferraglia medica che l’aveva sostenuta mentre la sua vita terminava. Erano tre o quattro, ci avevano accompagnato durante le ultime settimane come solo loro sapevano fare, tanto decise quanto delicate, e per questo amerò sempre le infermiere. Al mio arrivo, uscirono senza dire una parola. Accompagnarono silenziose e presenti l’immenso amore e dolore del momento: non scorderò mai la loro scenografica ritirata. Lasciarono me e María con mia madre.
Era nuda e splendida, non aveva più tubi né cavi né aghi né cerotti. In pace. È vero che morendo diventiamo freddi. La accarezzai, la baciai, ero felice al solo guardarla. Quelle palpebre da attrice patinata di Hollywood. Pulimmo la sua pelle di seta con un unguento alla mandragola che avevamo portato in una bottiglietta. I suoi seni, la sua pancia, il suo ombelico. Baciai quella collinetta di pelle dalla quale ero uscita 39 anni prima. María disse: avete persino la fica uguale!
A mia madre sarebbe piaciuto questo rituale tanto improvvisato quanto antico come quelli delle streghe. Onorare il corpo di mia madre e salutarla in questo modo è tra le cose più belle che ho vissuto. Amo molto, perché la mia amatxo mi ha insegnato ad amare.
Nel giugno del 2008 fu a un passo dalla morte. Ci riavvicinammo una volta superata la crisi. Vivevo felice a Barcellona dal 2000 e non avevo mai pensato di andarmene, ma non esitai a tornare a Iruñea per stare vicino alla mia meravigliosa genitrice quando la vita ce ne diede la possibilità. L’ennesima.
Perderla ha ferito parti di me che neanche sapevo esistessero e la ricorderò fino al mio ultimo respiro, ma so che è morta in un momento difficile per lei: avrebbe continuato a perdere la sua indipendenza, lentamente, e non le sarebbe piaciuto. Era diventato uno sforzo attraversare il nostro corridoio per andare al bagno da sola ben prima di entrare in ospedale per un’insufficienza respiratoria alla fine del 2013. Non voleva morire, ma la perdita inesorabile di mobilità le impediva di godersi la vita. Lei, che aveva scalato le mille scale e gli ostacoli di Rentería sui suoi tacchi a spillo di nove centimetri.
Ogni notte l’accompagnavo a letto, come lei faceva con noi quando eravamo piccole. Le rimboccavo le coperte e la baciavo. A volte parlavamo. Sentivo la sua disperazione quando avvolgevo il suo meraviglioso metro e cinquanta nelle coperte e spegnevo la luce, anche se la mattina si svegliava contenta.
Mia madre morì nel 2014. Aveva paura degli anni bisestili perché le avevano sempre portato catastrofi. Tra le peggiori, la morte di una figlia appena nata. Il 2014 non fu bisestile e così finirono le maledizioni. Anche se nulla è veramente invivibile mentre lo stai vivendo, mi angoscia il ricordo di quel dolore così nitido dei primi mesi senza di lei. Da molti mesi pensavo a come riorganizzare la casa quando se ne sarebbe andata, come se qualcosa in me si stesse preparando alla grande perdita che sembrava imminente. E lo fu. Alcune mattine non la sentivo respirare quando sbirciavo nella sua stanza, e il mondo si fermava. Resuscitava con un rumore, come se russasse. Io ho preso la sua camera da letto e, da allora, ho una stanza tutta mia per scrivere.
Una notte, mettendomi a letto nella stanza di mia madre pochi giorni dopo la sua morte, sono stata presa da un pianto inarrestabile. Mia sorella è uscita dalla sua stanza in mio soccorso e si è sdraiata accanto a me.
Ci prendiamo una birra da orfanelle? Dai, vieni. Guardandoci così, distese sul suo letto, ognuna con una lattina di birra appoggiata sui comodini tondi di nostra madre appena defunta, abbiamo cominciato a ridere. A vederci così nostra madre avrebbe detto: eccole lì, le mie due figlie, ubriache come sempre.
Celebrai le prime feste di San Firmino senza di lei. Ovviamente furono tragicomiche. Nella foto di copertina mia amatxo indossa un fazzoletto rosso annodato e strizza l’occhio. Io indossavo un vestito di lycra rosso scarlatto e le maniche con volant bianchi, rossi e argentati. Avevo il rimmel colato per le lacrime.
Uscii da un club in via Jarauta col sole già alto. All’improvviso, vidi una gigante ballare in fondo alla strada e corsi verso di lei. Le giganti di Iruñea con il loro txisto ci fanno continuare a ballare come se fossimo possedute da un’antica e capricciosa dea. Era la processione del 7 luglio. Mi feci strada tra la calca del corteo che stavo aspettando da ore. L’assurdità del mio dolore mi donò i superpoteri e arrivai in prima fila. Una donna che era lì con i suoi figli si lamentava con me, con tutte le sacrosante ragioni. La fulminai con i miei occhi da pazza e le dissi: non dirmi ni-en-te! Beh, non te lo dico, ha risposto. Aveva delle meches con riflessi biondi e orecchini di perle. Non potevamo essere più diverse. Se potessi, la abbraccerei ora.
Quando avevo quattordici anni, mia madre smantellò la nostra vita familiare a Rentería nel tentativo di separarsi da mio padre. Quella volta non ci riuscì. Ainhoa e io eravamo già a Iruñea, con mia nonna e mia zia, con la famiglia di mia madre. Lei rimase accanto a mio padre, nel tentativo di vendere il nostro appartamento. Ed erano ancora una coppia. Tutti i giorni, sentivo che mia madre era stata annientata da mio padre e mi si torcevano le budella. Ma all’epoca non avevo risposte. Adesso le ho. Il femminismo me le ha date sotto forma di conoscenza, lotta, comunità e terapia.
Mia madre e io parlavamo sempre apertamente e animatamente di tutto. Non misi mai limiti ai temi di conversazione tra noi, nemmeno in piena idiozia adolescenziale, quando hai bisogno di isolarti dai tuoi genitori, nel mio caso solo da lei perché avevo un legame solo con lei. Abbiamo sempre saputo che eravamo in due e che eravamo complici in questo mondo.
A tredici anni mi aprì la porta di casa, mi guardò e mi disse: hai rotto il cazzo. Aveva ragione, ovviamente. Una volta avvertì un mio ragazzo, ridendo: ti ha detto che è bisessuale, una puttana e una drogata?
I maltrattamenti di mio padre non erano un tabù tra noi. Abbiamo avuto delle conversazioni sincere e tranquille sulla nostra storia di violenza condivisa, soprattutto dopo esserci definitivamente sbarazzate di lui. Un pomeriggio le chiesi quando l’aveva picchiata per la prima volta. Ci pensò: “Probabilmente poco dopo che ci siamo sposati. Aspetta, aspetta, mi ha dato uno schiaffo prima del matrimonio, ora lo ricordo! Mi ha chiesto perdono, mi ha detto che era a causa dei nervi e che non lo avrebbe mai più fatto. Vedrai!” E ne ridemmo. Una volta mi disse, ironicamente: “All’inizio, dopo le botte, giurava che non l’avrebbe fatto mai più. Col tempo gli sono stata grata perché almeno non cercava più di ingannarmi”.
Mio padre, a volte ci guardava e diceva: pensate che non mi accorga che mi evitate tutto il giorno?
Poco prima di morire, in una di quelle chiacchierate che facevamo quando l’accompagnavo a letto, mi disse: “Sai? Non ho più bisogno di pensare che ero così innamorata di tuo padre, non ci penso più”. Il suo processo di liberazione era finito, era padrona della sua storia. Sapeva che avrei scritto questo libro, perché è anche la mia storia. E perché sento il desiderio rivoluzionario di chiarire che non eravamo solo donne che hanno subito violenza, e che molto spesso eravamo tremendamente felici.