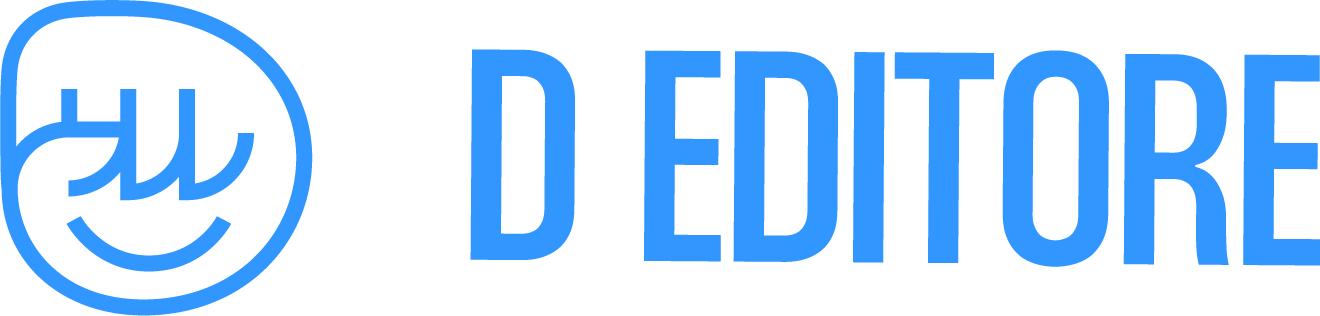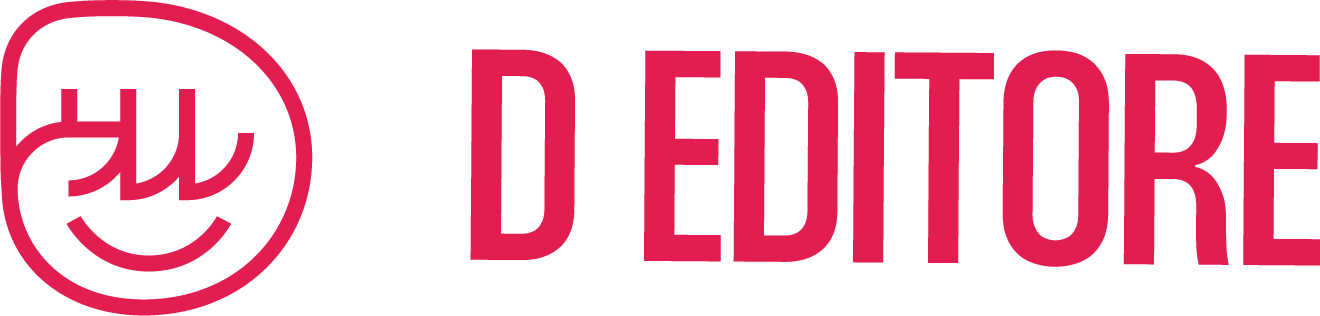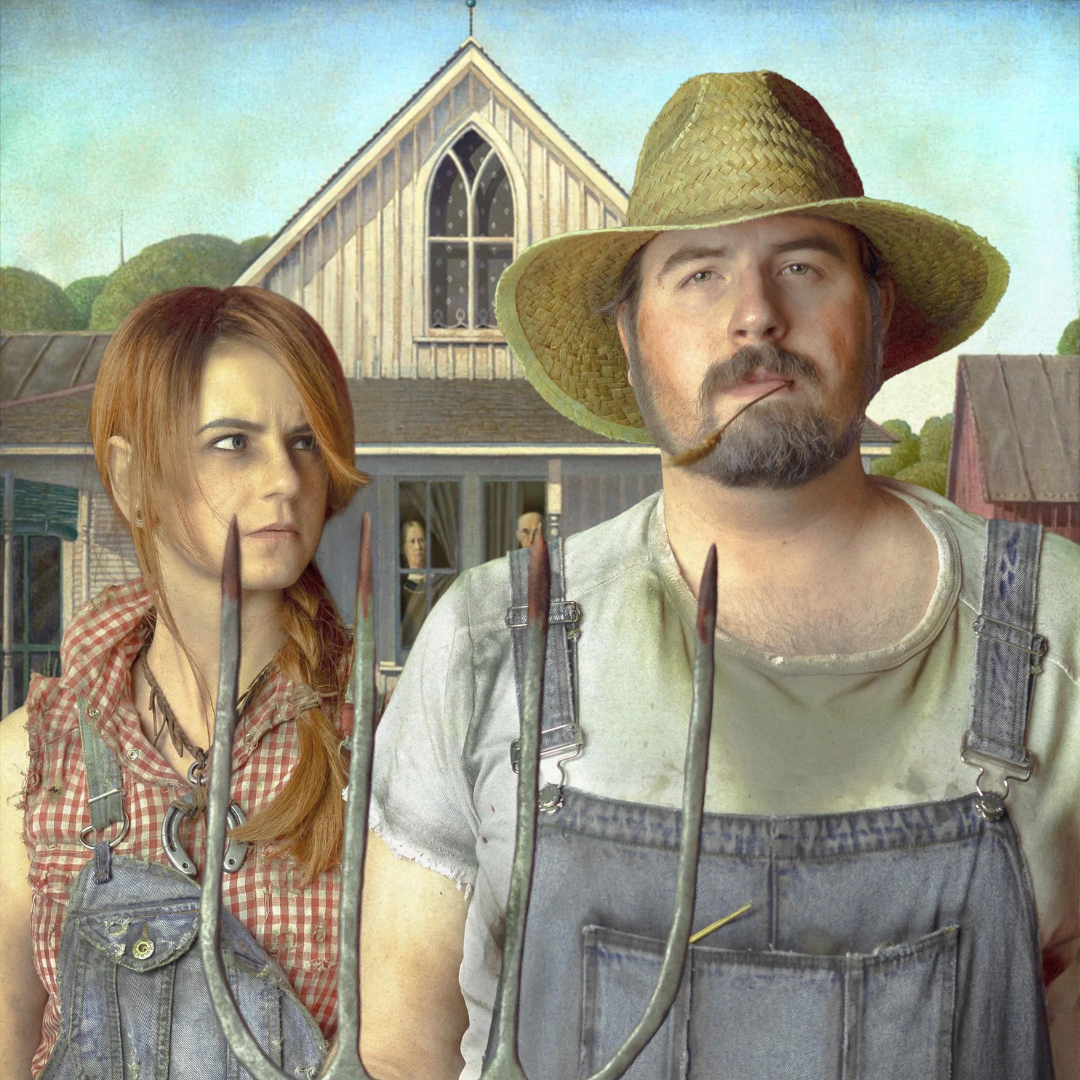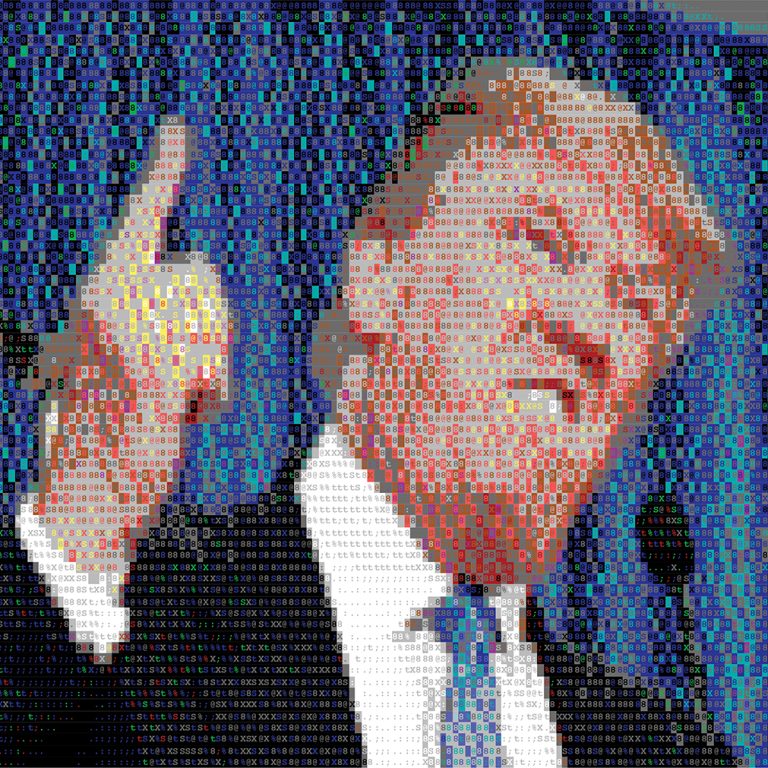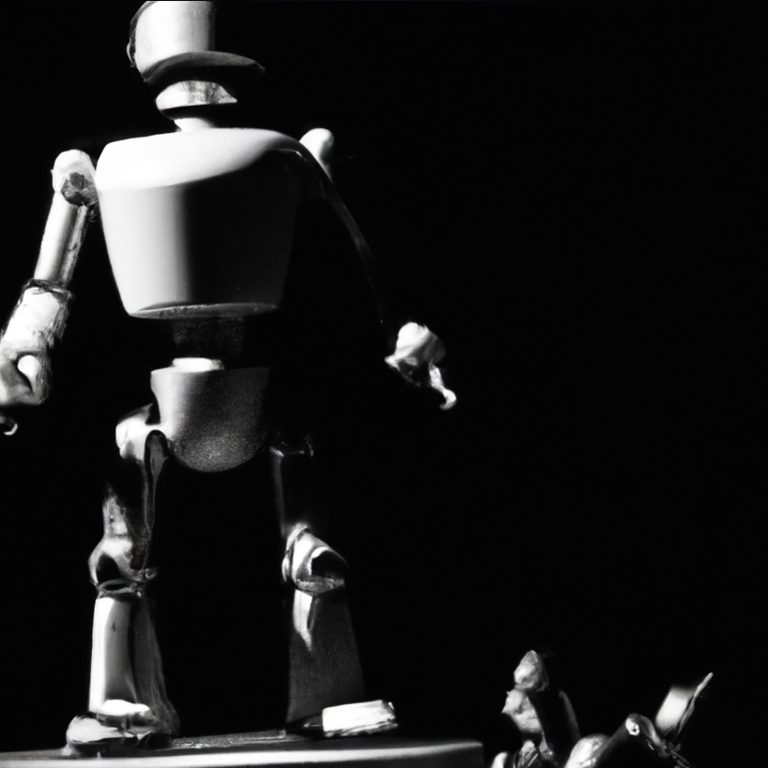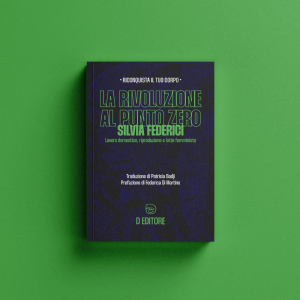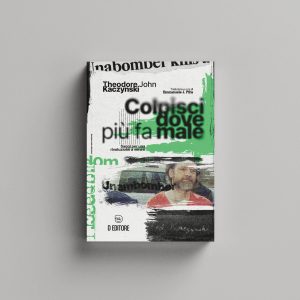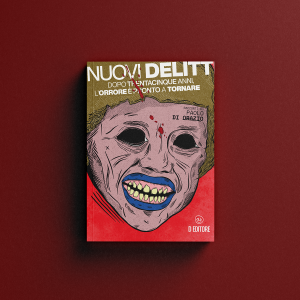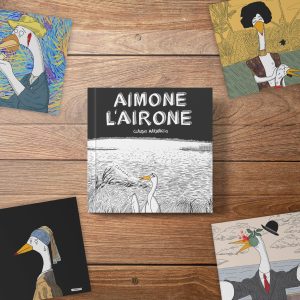La neolingua applicata dai redneck che scopano fra cugini
Ⓐ
Il 24 luglio, presso la Libreria Sinestetica, si è tenuto l’ultimo incontro per quest’anno editoriale per Oblivion. Il titolo dell’incontro? Contro la letteratura borghese. Da quel partecipatissimo incontro, sono emerse diverse riflessioni. Abbiamo così deciso di dedicare alcuni articoli di D Zine proprio a questo dibattito che, nato internamente a Oblivion, è ormai approdato su giornali mainstream e simili.
Il secondo articolo della serie è di Stefano Tevini, che ha redatto un testo dall’omonimo titolo: Contro la letteratura borghese: buona lettura!
Ⓐ
Dal dizionario della lingua italiana Oxford Languages:
Letteratura
sostantivo femminile
1. L’insieme delle opere variamente fondate sui valori della parola e affidate alla scrittura, pertinenti a una cultura o civiltà, a un’epoca o a un genere: l. latina, provenzale, italiana; l. contemporanea; l. popolare, per ragazzi; corso, professore di l.; spec. in quanto oggetto di ricostruzione o d’indagine storico-critica.
Dal vocabolario on line Treccani:
Borghese
3. Partecipe dello spirito della borghesia, talvolta con più o meno forte accentuazione polemica, che si precisa in due diverse accezioni: da un lato, uomo amante del vivere quieto e ordinato, attaccato al proprio benessere materiale, anche modesto, e perciò conservatore, cioè ligio all’ordine politico e morale costituito; e dall’altro, uomo amante di forme d’arte e di cultura tradizionali, avverso al nuovo e all’audace, e quindi assunto spesso come simbolo polemico di una certa aridità e angustia mentale.
«Certo», potrebbe obiettare chi legge, «facile cucire insieme un patchwork di definizioni per validare la propria tesi». D’altra parte, risponde chi scrive, per quanto l’operazione sia funzionale non si può dire che si avvalga di definizioni false. E ciò che accostate l’una all’altra le rende calzanti alla luce di questa possibile opinione è che proprio il tipo di estetica che chi scrive sta individuando è improntata alla più bieca e strumentale funzionalità, prima che a ogni altro fine, e lo è a più livelli. Anzitutto a livello politico.
Sì, perché la letteratura borghese, politicamente, è un’applicazione pratica a modo suo creativa della neolingua inventata da Orwell in 1984: un dispositivo linguistico che, consapevolmente o meno (lascio a chi fa parte di questa scena letteraria il beneficio del dubbio in quanto operare scientemente in questo senso richiede competenze niente affatto banali), causa una contrazione significativa dell’orizzonte dell’immaginazione, e degli strumenti atti a elaborare la complessità del reale che ne derivano. La letteratura borghese è infatti l’espressione, in forma di scrittura, dei valori di una classe sociale. Di chi ne fa parte, di chi è scivolato verso il basso lungo la scala sociale ma vorrebbe tanto tornare a farne parte, di chi aspira a farne parte ma intanto, o proprio in quanto, ne ha assorbito i valori e le logiche. La letteratura borghese racconta la borghesia. Ne racconta la realtà. Ne racconta le ansie. Ne racconta la visione del mondo. La discussione su quali caratteristiche definiscano la letteratura borghese imporrebbe una disamina articolata che andrebbe ad allungare inutilmente questo articolo, ma su alcune caratteristiche salienti è opportuno indicarle.
Per prima, la prospettiva. Il tipico romanzo borghese (forse non l’unica forma di letteratura borghese ma di certo la più utilizzata) racconta le vicende dalla prospettiva degli esponenti della borghesia. Situazioni, punto di vista, conflitti, tutto è riconducibile a quel tipo di realtà e di vissuto. I conflitti e i problemi ruotano intorno alla realizzazione professionale, alla stabilità della famiglia, alla vita quotidiana che va stretta e alla scoperta di un mondo selvaggio, sregolato, diverso che comunque alla fine termina, in un modo o nell’altro, con il rientro nei ranghi seppur con una consapevolezza diversa, qualunque cosa ciò possa realmente significare. Il romanzo borghese racconta di liberi professionisti o di creativi, di persone la cui vita amorosa è sconvolta da un’improvvisa, inaspettata quanto telefonata, situazione adulterina che le porta ad affacciarsi su un mondo istintuale che risveglia i loro sensi, un altro topos è il momento di fuga presso una figura di mentore originale, burbero e magari artistoide che fuori dai binari del conformismo ci vive da sempre e che aiuta il/la protagonista a capirsi e a tornare alla propria vita operando gli aggiustamenti necessari, perché il pensiero borghese parla sempre di aggiustamenti a un sistema che tutto sommato funziona e mai di vere rivoluzioni che mettano realmente in gioco lo status quo, ma portandosi dietro un pizzico, per lo più innocuo, del coraggio selvatico del mentore che osserva compiaciuto ma a debita distanza.
Una seconda e complementare caratteristica della letteratura borghese è l’addomesticazione del perturbante. Si parla quasi sempre di trame realistiche, le rare fughe nel fantastico hanno un valore per lo più cosmetico, da cartolina, mai speculativo. Le vicende raccontate sono sempre la storia di uno strappo che viene richiuso, di una crisi che rientra, di una perturbazione che viene normalizzata. Lo status quo non viene mai rovesciato e i conflitti, in ogni caso, si risolvono in un contesto, in un’ambientazione, in un worldbuilding le cui coordinate fondamentali sono sempre semplici da individuare e da capire. La realtà è sempre riconoscibile, al limite sono le persone a dover adattare la propria visione del mondo, le proprie categorie, il proprio sentire ma proprio questo è garanzia che, in ogni caso, se siamo sotto controllo noi lo è il mondo intorno a noi, nei limiti della fatalità che comunque, quando interviene, ha sempre una funzione correlata a un cambiamento interiore.
E questo ci porta a una terza caratteristica, l’ipertrofia dell’interiorità. L’intimismo come vero e unico orizzonte degli eventi. Tutto succede in funzione dell’interiorità dei personaggi. Tutto serve all’esplorazione, all’evoluzione, a vivere meglio, a una vicenda che mette realmente in discussione la sola dimensione interiore e mai il mondo inteso come quella cosa che esiste fuori dalla scatola cranica. Una res cogitans cartesiana sotto steroidi senza la lucida razionalità di Renè Descartes perché in tutto questo chiudersi nella cameretta mentale quel che conta davvero sono le emozioni, i sentimenti, tutto inizia e finisce lì, quel che c’è in mezzo è un contorno. La crescita emotiva. L’educazione sentimentale. Harmony, ma più fighetto e presentabile alle feste di natale degli editori fighi.
A questo punto il parallelismo con la neolingua orwelliana pare chiaro. Nutrirsi di letteratura borghese significa ingurgitare comfort food semplice da capire ma con valori nutrizionali da rachitismo intellettuale istantaneo. La letteratura borghese non problematizza, non costringe ad alzare l’asticella, ad aprire la mente, a informarsi e a capire. Riduce il campo da gioco a pochi, semplici elementi facili da capire, che fanno sentire colti senza il vero bisogno di esserlo, che ti permettono di fare il figo all’aperitivo parlando di quanto sono cari gli affitti a Milano se vuoi disperatamente fare lo scrittore e non di qualcosa di complesso come la precarietà di una società dipendente da una logistica globale fragile e complicata.
E questo ci porta comodamente alla seconda grande finalità della letteratura borghese: ritardare il disfacimento del gigante annegato. Sì, quello di Ballard. Proprio come lui la letteratura borghese se ne sta lì, sulla spiaggia, e imputridisce. Culturalmente morta, senza nulla più da dire di significativo, continua a esistere. Perché in un corpo morto, se non opportunamente trattato, fanno casa i parassiti, le larve, piccoli scavenger che si nutrono di carne in putrefazione. Scrittori e scrittrici la cui esistenza trova un senso solamente nel far parte di un determinato ambiente. Sì, ok, che palle il solito discorso dell’amichettismo. Ok, ma non è che sminuirlo con uno sbuffo e con un meme di Tony Stark che rotea gli occhi lo renda meno reale.
La cultura, quella blasonata, quella glamour, quella scena di cui in molti vogliono far parte, è una scena a modo suo compatta. Gli amici supportano gli amici, parlano dei libri degli amici, promuovono gli eventi degli amici e difendono gli amici anche di fronte a prese di posizione improponibili che portano a fallimenti di eventi patetici finanziati da soldi pubblici, perché tutto fa curriculum, tutto fa prestigio anche la presenza a un numero esorbitante di panel all’evento di qualche sodale anche se i corridoi sono vuoti e gli editori che han pagato gli stand incazzati come uno sciame di calabroni giganti asiatici. La letteratura borghese è la forma di espressione adottata da un ambiente incestuoso, autoreferenziale, come un trailer park pieno di redneck che si scopano tra cugini.
Il che, chi legge potrebbe obiettare, male non fa, che te ne frega a te?
Beh, il punto è questo. Difendere e favorire gli amici nel privato è un conto, ma la stessa condotta cambia di valenza nella dimensione pubblica, e fare cultura è una dimensione pubblica. Il fine del lavoro culturale non è l’autoconservazione o la conservazione del gruppo dei pari, è sempre il progresso del pensiero. Altrimenti si fa del familismo amorale, che sta alla base di tante dinamiche che rendono questo paese putrido come il gigante annegato. E siccome la cultura incide sulla realtà, anche per via indiretta ma incide, se il fine è preservare la propria nicchia non si sta facendo niente di diverso che far vincere il proprio cugino di cui sopra a un appalto pubblico.
Questo è in definitiva la letteratura borghese. Conservazione dello status quo con una spruzzata di glamour. A livello associazionistico e a livello politico. Ergo, è una scelta di campo. Poi, intendiamoci, una scelta che chiunque è libero di compiere. Anche tu. Decidi da che parte stare.
L’abbiamo fatto anche noi.