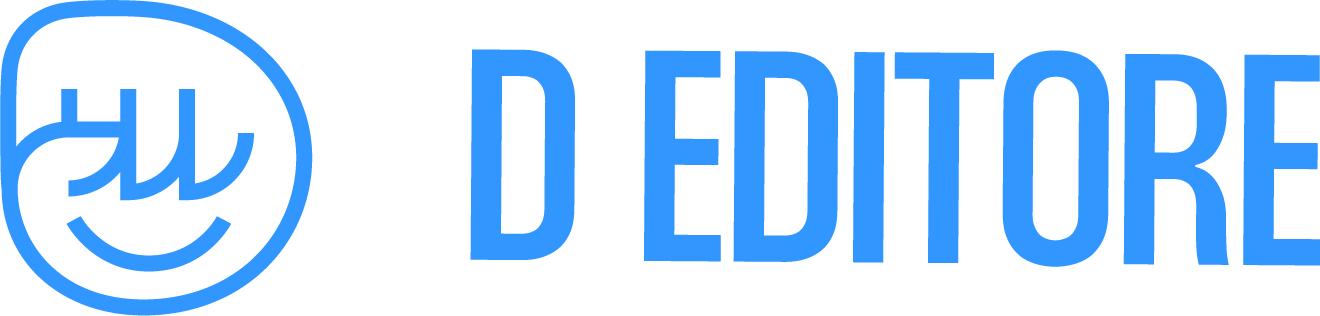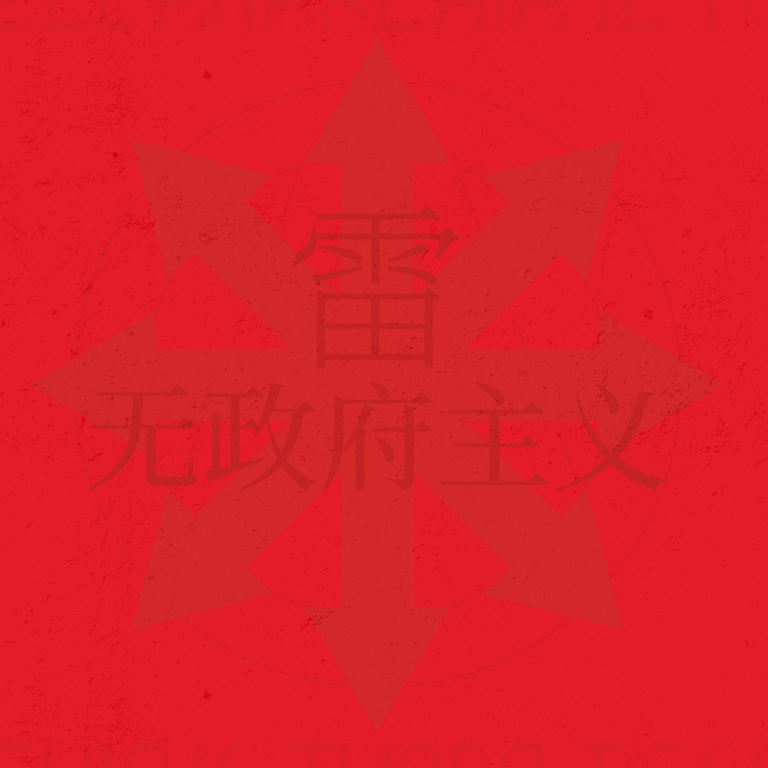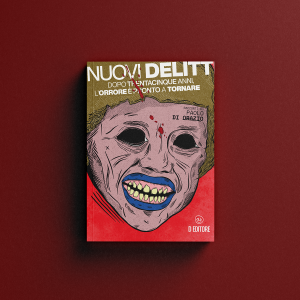Hijab e mingonne
Di Itziar Ziga
Capitolo estratto da Diventare cagna
Le donne musulmane di oggi hanno conquistato l’accesso all’oceano. Hanno abbattuto la frontiera dell’harem e ottenuto accesso allo spazio pubblico. Con o senza velo, oggi noi donne siamo nelle strade, e siamo milioni.
Fatema Mernissi
∞
Quando la bimba di origini marocchine Fátima El Idrisi venne espulsa dalla scuola dell’Escorial nel febbraio del 2002 perché seguiva le lezioni con il suo hijab, stavo lavorando come reporter nel giornale per donne Andra.
A quei tempi questa polemica era relativamente nuova, qui. Non dimentichiamo che la Spagna è uno dei paesi dell’UE che più di altri ha tardato a diventare meta dell’immigrazione economica e politica di Africa, Asia, America Latina ed Europa dell’est. Tuttavia, in Francia, senza andare tanto lontano, erano già nate norme che impedivano di andare a scuola indossando simboli religiosi, formula legale che la legislazione francese ha inventato per invisibilizzare e reprimere la popolazione magrebina fin dalla più tenera età. Perché, che io sappia, nessuno si scandalizza, né qui, né lì, se le bambine vanno a scuola portando le medagliette della Madonna ricevute per la prima comunione.
Fátima ha subito, a soli 13 anni, lo stigma sociale della donna sottomessa, quando le hanno impedito di continuare ad andare a scuola. A niente è servito che lei ripetesse che si copriva i capelli con lo hijab, uscendo di casa, per sua scelta e non perché obbligata dalla famiglia. Nemmeno si è dato importanza, per esempio, al fatto che l’adolescente era arrivata dal Marocco solo pochi mesi prima di mettere piede, per la prima volta, in un’aula spagnola. Le autorità accademiche hanno negato a Fátima il diritto all’educazione per quattro mesi e i mezzi di comunicazione spagnoli hanno scatenato la polemica sullo hijab – non sulla scolarizzazione obbligatoria – senza posa. Persino nel mio giornale femminista avevano cominciato a correre voci contro l’infausto fazzoletto e io non ne potevo più. Mi mancavano le parole delle donne originarie dei paesi musulmani che vivevano qui e delle persone che lavorano giorno per giorno per risolvere i conflitti interculturali.
In uno di quei giorni in cui si parlava tanto dello hijab, mi sono trovata su un autobus urbano con una ragazza molto giovane, magrebina, che indossava il suo foulard annodato. Solo noi, quelle strane, stigmatizzate, noi che subiamo continuamente gli sguardi inquisitori delle persone “normali” – perché sembriamo puttane, perché ci mostriamo lesbiche, perché portiamo la cresta ‒, sappiamo riconoscere l’asservimento silenzioso anche quando è rivolto verso le altre. Ho sorriso alla ragazza che teneva la testa bassa e si sentiva chiaramente a disagio, e ho pensato: cazzo, ora vediamo cosa succede! E ho scritto un articolo su Andra che si chiamava Fátima svelata.
Nel 2004 la casa editrice El Roure ha pubblicato El velo elegido (Il velo scelto), una serie di chiavi di lettura per ripensare collettivamente alla polemica – ereditata dalla Francia – che stava iniziando a montare anche qui riguardo allo hijab. Le autrici sono: Fátima Taleb, femminista marocchina musulmana stabilitasi a Badalona, Lena de Botton, europea di padre egiziano che ha dedicato la sua tesi di laurea a Il velo politico e il velo personale e Lidia Puigvert, femminista catalana e insegnante di sociologia dell’Università di Barcellona.
Nella copertina compare una foto di ognuna di loro e in un’altra tutte e tre mentre chiacchierano. Lena con i suoi capelli lunghi e neri legati in una coda, Fatima con il suo hijab e Lidia, chioma bionda e minigonna. Questa immagine non è né casuale né innocente, è un manifesto politico che io sottoscrivo piena di euforia.
Il libro mi è capitato tra le mani come manna dal cielo. Ho fatto i collegamenti, come loro, tra tutte le controversie che suscita l’abbigliamento delle donne – e solo delle donne – e ho capito perché mi ha sempre dato così tanto fastidio che alcune vengano giudicate perché portano la minigonna, e altre perché utilizzano – o no – lo hijab. El velo elegido comincia così: minigonne e hijab. Panni così semplici eppure così fastidiosi. Raccolgo la palla a mia volta, e continuiamo a giocare e a passarcela tra di noi, con la libertà di movimento che ci dà sapere che, qualsiasi cosa copra i nostri corpi, lo abbiamo scelto noi. E di tanto in tanto lanciamo la palla con tutta la nostra forza contro la vetrina dell’ipocrisia eteropatriarcale.
Hijab, non velo
Uso da allora il termine hijab, come fanno le donne che lo indossano. Mi approprio di questo termine esotico, perché quello che infastidisce è il fazzoletto che si annodano al collo le magrebine, e non le contadine galiziane. Ma nelle riviste, la parola abituale è velo. Velo, deriva da velare, nascondere, e questa non è una definizione innocente, nessuna definizione lo è. Velo e non fazzoletto, come quello delle contadine italiane o basche. Velo, con tutte le sue connotazioni rituali. Il velo lo utilizzano le promesse spose e le vedove, che sono tali a seconda della relazione con il marito, vivo o morto. Velo che nasconde noi stesse in relazione alla dominazione maschile.
Così vogliono che consideriamo le donne magrebine che incrociamo per strada con il loro hijab: sottomesse, passive, nascoste. Sebbene passino al nostro fianco con la testa ben alta.
L’identificazione di questo indumento, lo hijab, con la sottomissione delle donne è uno di quei misteri semiotico-politici che non riesco a comprendere, benché non abbia dubbi su chi ne beneficia. Loro, le donne della cui cultura fa parte lo hijab e che decidono di metterselo o no, nemmeno lo capiscono.
Fatiha, dottoressa algerina residente a Barcellona, quando l’ho intervistata per Andra mi ha detto: «Quando vado in vacanza in Algeria, mi piace mettermi la gellaba e lo hijab perché mi sento molto a mio agio, molto comoda. Ma non ha nessun significato religioso, né di sottomissione, ovviamente. Suppongo che mi piace perché fa parte della mia cultura e della mia vita e le donne del mio paese lo hanno sempre portato».
Il fazzoletto sulla testa è molto utilizzato in tutto il mondo, e non solo in quello musulmano. Basta semplicemente guardare le foto delle donne del nostro paese di trent’anni fa, o addirittura di adesso. Di certo le mie antenate basche portavano la testa coperta. E non erano musulmane. Coprirsi la testa è molto pratico quando il sole batte forte, in special modo quando si lavora nei campi. Lo dico io che anni fa ho patito una insolazione e, da allora, non vado mai in montagna d’estate senza una sciarpa o un foulard. E a volte, quando mi guardo allo specchio e mi dico “che capelli orrendi”, mi copro con un foulard e mi vedo divina. E vi assicuro che non divento docile/sottomessa per questo. Come dice la mia amata Vero: rifiutiamo la ragazza musulmana che porta lo hijab, ma guarda le nostre comunioni. Anche le madri e le nonne di Plaza de Mayo argentine portano il fazzoletto sulla testa, qualcuno le considera sottomesse?
Lo hijab è la scusa per stigmatizzarle. Punto. Allo stesso modo in cui per noi, lo è la minigonna. Inoltre, forse non escono per strada molti uomini e bambini dei paesi musulmani con i loro gellabi fino alle ginocchia? Qualcuno si è scandalizzato vedendo dei bambini con un vestito? Perché, che io sappia, la gellaba è come un vestito da donna largo che si è soliti portare col pantalone sotto. Vedere uomini e bambini vestiti così per le nostre strade è molto inusuale – a meno che non siano preti – ma il modo di vestire maschile non è mai fonte di polemica. Se un ragazzo porta i pantaloni bassi e gli si vedono le mutande fino a mezza natica, è uno skater. Se a portarli così è una ragazza, è una puttana.
Cosa ne è stato di Fatima
Di recente ho interrogato la sfera di cristallo di Google su Fátima El Idrisi. Adesso ha 19 anni. Ha interrotto gli studi nel 2005 e non ha mai seguito una lezione senza il suo hijab. Racconta che per lei studiare è stata una lotta quotidiana. Al suo primo giorno in una scuola pubblica, alla quale era stata assegnata dopo essere stata rifiutata da una scuola privata cattolica, l’aspettavano una schiera di telecamere e giornalisti. La direttrice del centro aveva dichiarato che non l’avrebbe lasciata entrare se non avesse scoperto la testa, ma, alla fine, Fatima è riuscita a entrare. Dice che vorrebbe riprendere gli studi senza tanta pressione, adesso che è maggiorenne. Mi piacerebbe chiedere a tutte quelle che hanno appoggiato l’attacco istituzionale a questa ragazza, per strapparle lo hijab dalla testa, in che modo pensano di averla aiutata. Se questo significa difendere i diritti delle donne, smetto di essere femminista.
Fortunatamente, le cose non sono andate oltre e nello Stato spagnolo (al quale mi obbligano ad appartenere, per adesso) non è stata approvata nessuna legge che impedisca alle bimbe di frequentare la scuola con i capelli coperti, alcuni istituti continuano a optare per la linea proibizionista dura, ma tanti altri affrontano la cosa con serenità e cercando il dialogo.
La dottoressa algerina Fatiha è stata sorpresa dal cambio di atteggiamento della gente dopo questa polemica. «Io lavoro nelle scuole e bambine e bambini hanno iniziato a chiedermi in continuazione: perché portate il velo? È curioso, perché nelle scuole di Barcellona ci sono sempre state bambine con lo hijab».
In Marocco ci sono molti genitori che cercano di impedire alle proprie figlie di utilizzare lo hijab, come qui ci sono adolescenti che si fanno un piercing di nascosto dai loro famigliari. Anche per le strade di Barcellona vedo ragazze magrebine con minigonna e zatteroni, però di loro le televisioni non parlano. Anna Sebastià di SoS Racisme, quando l’ho intervistata nel pieno della polemica di Fátima, mi ha detto: «Si può anche arrivare a pensare che ci siano adolescenti di altre religioni che subiscono la pressione di fare la comunione o la cresima, e andando oltre alle origini culturali e alle opzioni religiose, tenete presente che stiamo parlando di una ragazza che, come tutte, sta costruendo la sua personalità. E che ha un padre e una madre che cercano di indirizzarla a un modello di vita che ritengono conveniente».
Attenzione a chi ti protegge
Ciò che maggiormente mi insospettisce di questa polemica alimentata tendenziosamente è che, quando nelle riviste e in televisione la difesa dei diritti delle donne finisce in prima pagina, è sempre per rafforzare il sistema di controllo su tutta la popolazione. Non stupisce che, a seguito del clamore suscitato dall’indifferenza giudiziaria che aveva permesso a un pedofilo già condannato di assassinare Mari Luz, ci si concentri sulla certezza della pena per stupratori, pederasti… e terroristi. Cosa avrà a che vedere una cosa con l’altra?
Con lo hijab succede la stessa cosa: i nostri uomini di legge e ordine se ne fottono delle donne musulmane. Se non danno valore né al nostro modo di vivere, né al nostro benessere, quello delle loro donne, come può importargli la vita delle altre? Per me è più che evidente che, quando dicono di difendere le donne e le bambine musulmane dalla dominazione familiare maschile, dietro c’è solo islamofobia. L’islamofobia che hanno bisogno di inculcarci i governi occidentali per continuare con le invasioni in Iraq, Afghanistan, Palestina… È così evidente che fa male.
«Si va consolidando l’idea dell’esistenza di due mondi: quello civilizzato occidentale e quello barbarico, incolto e repressivo islamico, e gli occidentali hanno una missione civilizzatrice. Tutta questa polemica fa parte del piano delle potenze occidentali, guidate da un personaggio oscuro come G.W. Bush per appropriarsi delle ricchezze di quel mondo “incivilizzato”. Se realmente gli fossero interessati i diritti delle donne, perché Bush e i suoi alleati avrebbero messo il potere nelle mani di quei mostri dei talebani senza avere nulla da ridire sull’imposizione del burka dal 1994 e sulla lapidazione di donne e uomini? È molto semplice: quando hanno deciso di togliere di mezzo questo gruppo erano guidati da altri interessi, e per questo hanno iniziato a riempire le pagine dei giornali con le atrocità commesse dai talebani contro le donne». Lo dice Nazanin Amiriam, una giornalista iraniana illuminata e formidabile, rifugiata a Barcellona, che ho intervistato diverse volte.
Lei sa di cosa parla. L’imperialismo occidentale “civilizzato” e le sue guerre, con la sua falsa difesa dei diritti delle donne, è ciò che allontana ogni giorno di più la possibilità di un ritorno di Nazanin nel suo agognato paese. Una mattina ci siamo viste per un’intervista. La notte precedente c’era stata una violenta tempesta su Barcellona e siamo passate accanto a un albero sradicato dal vento. Nazanin mi ha detto: «Se dovessi rinascere, mi piacerebbe essere un albero. Perché gli alberi non si muovono dalla loro terra a meno che non li sradichino». Tanto è il dolore e la determinazione di chi è costretto a vivere a mille chilometri dai propri ricordi, dal luogo in cui desidererebbe continuare a lottare.
Le mie sorelle arabe
Grazie al mio appassionante lavoro per la redazione di Andra ho avuto l’opportunità di conoscere molte femministe provenienti da paesi musulmani. Quando chi parla è una femminista occidentale, per quanto situata ai margini del femminismo e dell’occidente come lo sono io, l’uso di certi termini è sempre rischioso e fuorviante. Se loro sono femministe islamiche, noi siamo femministe cristiane, culturalmente parlando. Per molte, sia tra di loro che tra di noi, i nostri grandi dei monoteisti (e siamesi) sono acqua passata, altre invece sono credenti. Lo ammetto: sono una fan sfegatata delle mie sorelle di lotta arabe! Una volta mi sono trovata di fronte la filosofa egiziana Nawal El Saadawi e sono rimasta muta ed estasiata.
Fatiha me lo diceva la mattina che l’ho intervistata: «Non dico che il mio paese sia il paradiso, però bisogna conoscerlo e vederlo per poter dare un giudizio. Si parla sempre delle donne sottomesse, che non hanno diritti… Le persone ti domandano: “E le donne, in Algeria, non lottano?”. Certo che sì, però qui non se ne parla, non si parla dei movimenti femministi o delle donne che lottano, non si parla delle donne che lavorano… Si parla solamente delle donne sottomesse, che ovviamente ci sono. Come ce ne sono qui».
Loro, che non sono bianche né europee, quando si sentono messe in discussione da parte del femminismo occidentale ed eurocentrico, sono molto svelte e abituate a ribaltare il punto di vista per permetterci di guardarci allo specchio.
Mama Samateh è una donna gambiana arrivata in Catalogna a ventitré anni. Qui ha fondato l’associazione AMAM, uno spazio di dibattito tra donne del suo Paese sull’importanza di abbandonare la pratica dell’infibulazione. Alcune potrebbero pensare che Mama abbia “visto la luce” grazie al contatto con la nostra cultura “avanzata”. Al contrario. In un viaggio in Gambia nel 1998, Mama ha conosciuto l’attivismo di GAMCOTRAP, un’associazione di donne contro l’infibulazione. Sono state loro a insegnarle come lavorare con le migranti provenienti dal suo paese per convincerle a non mutilare le proprie figlie. Se c’è qualcuno in questo mondo che può riuscire a fermare questa tradizione, sono le donne come lei: con la sua delicatezza, intelligenza e la conoscenza della cultura dei luoghi dove si pratica l’infibulazione. Quando l’ho intervistata, Mama mi ha detto una cosa che non dimenticherò mai: «Voi vi scandalizzate di questa nostra tradizione, noi non capiamo perché i vostri mariti vi picchiano». Ha centrato il punto: quello spagnolo è uno degli stati con il maggior tasso di maltrattamenti domestici nel mondo.
Tra le pagine di El velo elegido, Fátima Taleb sorride con il suo hijab addosso e dice: «Non ho bisogno di fondamentaliste occidentali per salvarmi senza il mio consenso, né di leggi che mi proibiscano di vestirmi come desidero». Ha provato sulla sua pelle la perversione dei discorsi che vorrebbero sovradeterminarla, con la scusa di salvarla dalla sua cultura. «Se sei una donna appartenente a una minoranza culturale e di livello socio-economico umile, o sei straniera e non hai una formazione accademica, incontrerai più ostacoli nel far rispettare quello che hai da dire su te stessa e il tuo stile di vita».
Questa è davvero la questione centrale: ci sono donne a cui si riconosce l’autorità di nominarsi e spiegarsi (quelle perbene) e poi ci sono quelle a cui si nega questa autorità (quelle permale: le puttane, le migranti, le zingare, le disabili, le nere, le arabe, le lesbiche, le transessuali, le indigenti, le vecchie, le alcoliste, le maltrattate, le tossiche, le ribelli, le pazze, le povere in generale…). Poco cambia che a zittirci sia la Chiesa Cattolica, l’autorità medica o accademica, i giornali o alcune femministe. Anzi, non è proprio uguale: è molto più perverso e doloroso quando chi ti nega la parola è parte del movimento nato per liberarci (tutte).
Le autrici di El velo elegido denunciano spesso il fatto che il femminismo occidentale si concentri unicamente sulla segregazione di genere e faccia apparire le altre forme di esclusione (etnica, culturale, economica) come se non fossero affar loro. Ci stiamo comunque svegliando, anche se solo perché costretti a farlo. Come dice la mia cagna Sara, «Grazie all’emigrazione, apro la porta sul mio pianerottolo e le vedo lì». Con le loro lotte, le loro contraddizioni, le loro speranze, le loro alleanze. Come noi.
Il velo intimo e il tanga
Nelle ultime decadi la svolta integralista che ha caratterizzato alcuni paesi di tradizione musulmana (promossa nella maggior parte dei casi dall’interventismo permanente e insidioso degli Stati Uniti e dell’Europa) è culminata con l’obbligatorietà, sancita dalla legge, dell’uso di determinati indumenti da parte delle donne negli spazi pubblici. Per questi governi l’uniformità dell’immagine delle donne è la rappresentazione simbolica del loro potere autoritario. Non conosco nessuna musulmana che rivendichi lo hijab e difenda per di più la sua imposizione a tutta la popolazione femminile, anche se non metto in dubbio che donne del genere possano esistere. Il patriarcato non sta nascosto nello hijab, ma nella proibizione o obbligatorietà di indossarlo. Il tema è molto controverso: oggi la questione riguarda la capacità di scelta delle donne e lo hijab è stato talmente caricato di significato politico che non si può toccare. Morde.
La sociologa di origine egiziana Lena de Botton ha deciso di affrontare questo tema e di chiedere quale significato riveste per le donne che lo indossano questo piccolo e rabbioso pezzetto di tessuto. Al di là del suo uso politico, per molte musulmane lo hijab ha un valore personale, intimo, che a noi può sfuggire per via della distanza culturale e che Lena interpreta così: «Lo hijab permette alle donne di dare una continuità tra due spazi sociali, quello privato e quello pubblico». Aiuta a delimitare quello che una mostra o espone di sé stessa all’esterno. Per questo motivo, le infonde sicurezza e protegge simbolicamente dagli sguardi esterni ciò che non vuole condividere, ciò che è solo suo e delle persone che reputa la sua cerchia più intima.
Quando Carmela è stata in Marocco qualche anno fa, ha visitato un hammam. Si è innamorata della complicità e del calore di quel circolo esclusivo di donne. Forse per strada sono tutte molto accollate, molto più di noi, ma nei bagni pubblici si mostrano, si toccano, si prendono cura l’una dell’altra, con una intima nudità sconosciuta alla nostra cultura occidentale cristiana. Carmela è stata accolta senza domande, una donna anziana ha cominciato a massaggiarle tutto il corpo con vigoroso affetto e la nostra cagna è uscita piangendo dall’hammam per l’emozione di aver ricevuto tanta inattesa generosità. È evidente che abbiamo un’esperienza diversa di ciò che è pubblico o intimo.
Quando Carmela, uscendo dall’hammam, ha reincontrato Gaizkay e Dudu, i suoi compagni di viaggio, questi le hanno chiesto: «Ti sei eccitata tra tante donne nude?». In fondo non è poi così maliziosa come domanda: nella nostra cultura se c’è un gruppo di persone adulte e nude che interagiscono fisicamente si può trattare solo di un’orgia. E le orge, in realtà, non sono poi così frequenti. In Occidente la nudità è legata al sesso, e il sesso è un tabù. Qui il cristianesimo è andato eliminando gli antichi bagni pubblici romani e condannava la nudità come peccaminosa, anche negli spazi privati. Così le donne in Marocco, per quanto coprano i loro capelli per strada, godono di un paradiso privato di libertà fisica ed emotiva che a noi è stato portato via secoli fa e che non siamo riuscite a recuperare, tranne che in piacevoli occasioni.
Una volta ho sentito affermare in tv che la spettacolare spogliarellista Chiqui Martí non mostrava la fica in spiaggia, che era molto pudica. Il pubblico e gli ospiti in studio ridevano. Come è possibile che questa donna le cui tette, gambe e culo conosciamo meglio dei nostri, affermi di essere timida? Io la capisco: Chiqui mostra tutto il suo corpo, tranne il triangolo nascosto dal tanga. Lei tiene per sé (e per i fortunati che sceglie) quei centimetri della sua gloriosa anatomia. Mostra tutto tranne la fica, e tenere qualcosa per sé l’aiuta a ricordarsi che è lei quella che mostra e che ha il controllo. Anche se il suo lavoro è spogliarsi.
RAWA e Butler
A volte, quando sono in modalità apocalittica e, come a Shakira, la rabbia (e la paura) mi pesa più del cemento, penso alle donne di RAWA e mi sento quasi invincibile. In questo momento, mentre scrivo, Meena, fondatrice e martire, protegge la mia mente dalla cornice perennemente posata sulla mia scrivania. Associazione delle Donne Rivoluzionarie dell’Afghanistan: sembra fantascienza, eroine alla Mad Max; lo sono. Nate durante la resistenza contro l’invasione sovietica nel 1977, non hanno mai smesso di difendere le proprie sorelle, specialmente da quando i fondamentalisti talebani instaurarono il terrore, la tortura e l’uccisione sistematica delle donne (con il sostegno dell’Unione Europea, come ricordava Nazanin).
Le donne (e uomini, perché ce ne sono) di RAWA avevano – e continuano ad avere – una rete di resistenza clandestina e inarrestabile, sotto al regime talebano. Hanno offerto assistenza medica e corsi di informatica e inglese alle donne e alle ragazze isolate nelle loro case. La loro audacia veniva punita con la morte. Ho incontrato Behjat nel dicembre del 2000, sua madre era già da tempo un’attivista di RAWA. Alle domande sul burka ci ha risposto: «Come credi che possiamo essere irriconoscibili e continuare il nostro lavoro clandestino?» L’indumento soffocante che simboleggia il dominio assoluto sulle donne e che le invisibilizza, è stato il miglior alleato delle eroine di RAWA. Da allora, quando vedo una sagoma che dà corpo a un burqa, non percepisco solo l’umiliazione e la rabbia. Sorrido e immagino che, sotto quella grossa tela, si nasconda uno di loro.
In Fare e disfare il genere, la filosofa lesbica statunitense Judith Butler riflette sui limiti della “vivibilità umana”, e su coloro che lottano instancabilmente per superare questi limiti e rendere la vita vivibile. «Alcuni esseri umani, infine, non vengono riconosciuti affatto come umani e ciò produce un altro ordine ancora di vita invivibile».
Questo accade in situazioni estreme di repressione e annichilimento. Cinque esempi: le donne in Afghanistan; i migranti senza documenti; le donne torturate dai loro padri, mariti o fidanzati; gli uomini e le donne transessuali che lottano ogni giorno per rivendicare un genere che è socialmente negato loro in ogni angolo del mondo, le prigioniere e i prigionieri in tutte le carceri. Basta aprire un libro di storia per iniziare a tremare. «Possono aspirare a una vita possibile solo coloro che già sanno di essere possibili. Ma per coloro che stanno ancora cercando di diventare possibili, il concetto di possibilità rappresenta una necessità».
Le autrici de El velo elegido citano anche le attiviste di RAWA – impossibile dimenticarle – e mettono il loro coraggio estremo in relazione al concetto butleriano di “vite non vivibili”. Riporto le loro parole con eccitazione: «Arrivati a questo punto, dovremmo chiederci in quale luogo si sviluppano queste vite non vivibili, non contemplate, non pensabili rispetto alla normatività del genere. Beh, si può dire senza mezzi termini che RAWA è uno di questi spazi che stanno lentamente ottenendo un riconoscimento veramente rivoluzionario, poiché stanno trasformando il “non vivibile” nel possibile, anche se è proibito. Ci stanno dicendo che sotto quel burqa le donne hanno la capacità di decidere, trasformare e ribellarsi… Hanno fatto il primo passo sulla strada che le porta a non appartenere a quelle vite che non possono essere immaginate».
I panni del femminismo
«Quando esaminiamo la questione dello hijab, non possiamo dimenticare la lunga tradizione femminista di analisi critica delle imposizioni o dei divieti legati all’abbigliamento femminile», affermano le autrici de El velo elegido, indicando vari capi d’abbigliamento fondamentali nella lotta delle donne per l’autodeterminazione (reggiseno, pantaloni, minigonna). Il corpo e l’abbigliamento delle donne è sempre stato un campo di battaglia, di controllo e di emancipazione. Per una giovane appartenente a una famiglia ultraconservatrice, indossare una minigonna è un atto di insubordinazione.
Per la mia amica Marta ‒ che è una frocia maschiaccio ‒ essere obbligata a indossare la gonna nel caffè dove lavora è una piccola umiliazione quotidiana, che accetta pensando ai soldi, e la affronta con una risata. Per le attiviste di RAWA, scoprirsi il volto e truccarsi tutte insieme è un atto di resistenza, di ribellione. Mentre per molte femministe occidentali truccarsi il volto è un segno di sottomissione ai canoni estetici. La regista e compositrice vietnamita Trint T. Minh-ha, lo spiega in questi termini: «Se l’atto di s-velare ha un potenziale liberatorio, allo stesso modo lo ha quello di velare, dipende dal contesto stesso del velo, dalla modalità secondo la quale le donne percepiscono la dominazione». Anche se sembra tanto ovvio, a volte bisogna spiegarlo.
La mia amica transessuale Janna mi spiegava, cinque anni fa in un autobus, di come avesse cominciato ad approfittare del potere che le aveva dato il suo nuovo aspetto da bonazza, e di come le piacesse la galanteria degli uomini nei suoi confronti. Per quanto mi riguarda, dal momento che mi sono rotta abbastanza le ovaie di imbattermi in questi pretendenti per niente cinematografici, l’entusiasmo di Janna è stata una rivelazione. Non si può ignorare il contesto in cui si muove ognuna di noi: per lei è stato molto faticoso essere trattata come una signorina, e non come un frocio, dagli uomini. Ma ho anche capito che, attraverso di lei, riuscivo a intravedere recessi della femminilità che mi erano sfuggiti. Quella conversazione di sei ore – il tempo impiegato dall’autobus per portarci da Pamplona a Barcellona – è stata un’altra delle motivazioni di questo libro.
Se lo hijab è misteriosamente legato alla sottomissione della donna all’autorità patriarcale, la minigonna è accusata di scatenare irrefrenabilmente il desiderio sessuale maschile. E non si tratta di un pregiudizio obsoleto. Il 17 agosto del 2008, decine di messicane in minigonna e scollatura si sono riunite di fronte alla cattedrale metropolitana per dire ai vescovi che se gli uomini le aggrediscono sessualmente non è per colpa di un pezzetto di stoffa. È forse necessario ricordare le migliaia di donne violentate e uccise a Ciudad Juarez, un altro spaventoso femminicidio dei nostri tempi? Qualche giorno prima, l’episcopato aveva pubblicato un ampio testo con le proprie riflessioni sulla violenza di genere: naturalmente, ancora una volta, la colpa era tutta delle donne che se ne vanno in giro mezze nude e truccatissime a provocare gli uomini.
Sentenze minigonna
Nella giurisprudenza spagnola esistono le cosiddette “sentenze minigonna” (il che suona molto poco credibile, provenendo da uomini vestiti con lunghe toghe). Nei nostri tribunali si applicano a malapena le aggravanti di omofobia e razzismo, e non esiste nemmeno il precedente giuridico di transfobia. Tuttavia, il fatto che una donna indossi una minigonna può abbreviare la condanna del suo aggressore. La più nota di queste perle giuridiche è opera dell’indimenticabile giudice Rodrigo Pita che ha condannato un uomo di Lleida a una multa di 40.000 pesetas per gli abusi perpetrati sulla sua dipendente diciassettenne, comunque segnalando che la giovane “aveva provocato, forse innocentemente, l’imprenditore con il proprio abbigliamento” (il colmo è quel “innocentemente”, nemmeno volontariamente).
Va da sé che il capo d’abbigliamento era una diabolica minigonna. Questa sentenza venne emessa nel febbraio 1989 e confermata dalla Corte Suprema, parola per parola, anni più tardi. Ricordo chiaramente lo scalpore.
Avevo quindici anni, frequentavo il liceo e fu il mio primo contatto con un gruppo femminista. Partecipai a una riunione con altre studentesse e due insegnanti. Stavamo commentando la famosa sentenza quando una delle insegnanti, protetta dall’intimità del gruppo, disse: Be’, ci sono alcune ragazze che indossano gonne troppo corte. Tutte annuirono, se non ricordo male. Era l’ultima stronzata che mi aspettavo di sentire in un ambiente femminista. Non sono mai più andata a una delle loro riunioni.
Malgrado quello stupido commento, mi ricordo lo straordinario attivismo delle donne in quegli anni. Pamplona si svegliò ricoperta di cartelloni antiaborto nei quali si mostrava un’immagine grottesca a metà tra stralci di foto di Cindy Sherman e una lattina di calamari nel loro inchiostro. I pro-life assicuravano si trattasse di un aborto umano, nessuno ha mai chiesto loro dove avessero trovato il modello. Pochi giorni fa, Josune Heredia mi raccontava i suoi ricordi di quei presidi carichi di tensione di fronte ai tribunali nei quali stavano processando dottoresse che praticavano aborti, e la brava gente aggrediva le femministe. E la polizia le caricava. Josune mi ha anche raccontato di manifestazioni di donne in minigonna per protestare contro la famosa sentenza, come quelle che siamo solite ascoltare.
Allora, il supremamente sapiente arcivescovo di Pamplona lo disse senza mezzi termini: quando le donne tornavano presto a casa per recitare il rosario davanti alla radio e non andavano in giro di notte tirandosi addosso la sfortuna, queste cose non succedevano (poverini, non riusciranno mai a superare la nostalgia franchista). Non riesce a capire, questo caro signore, che se ti rinchiudi in casa è più facile che ti violenti tuo padre, tuo marito, tuo zio. Le donne devono essere esclusiva degli uomini della famiglia, non di un estraneo qualsiasi in un portone buio.
Come dicevamo il giudice Pita e io, quando si esce di casa strizzata nella lingerie e mostrando le chiappe, è più facile che i passanti “machi” che incroci per strada non riescano a reprimere la propria imperiosa necessità di importunarti in qualche modo. Anche se l’uomo di legge di cui sopra e io non siamo d’accordo nell’identificare la parte responsabile.
«Se l’immagine della femminilità viene venduta sempre legata al desiderio maschile è un problema maschile, pertanto siamo stufe di discutere di stronzate. Sono loro problemi che devono risolversi da soli. Se mi va di indossare una minigonna o uscire con indosso un corsetto è una questione relativa alla definizione della mia identità, nessun maschio me lo ha imposto. Il macho si eccita se indosso un corsetto, punto», ha detto Vero nel solito modo esplicito che tanto ci affascina.
Ma il problema è che il suddetto giudice non è l’unico a pensarla così. Incolpare le donne di essere la causa degli eccessi del desiderio maschile sfrenato è un’abitudine così radicata nella coscienza storica e collettiva che non se ne va nemmeno con l’acetone. Ci sono gonne troppo corte, e non uomini troppo violenti.
Unite e ribelli
Le musulmane sono sottomesse poiché indossano lo hijab, e noi siamo puttane perché mostriamo le cosce. Tutte dobbiamo sopportare la violenza accessoria di coloro che dicono di difenderci. Tutte dobbiamo sopportare di essere trattate da stupide, di venire esaminate sotto una luce accecante, pretenziosa e stigmatizzante, che la nostra voce non venga ascoltata con la scusa che non sappiamo quello che diciamo. Tutte calibriamo, nell’uscire di casa ogni giorno, la misura in cui ciò che indossiamo o non indossiamo sui nostri corpi condizionerà la tranquillità, il rifiuto o il disagio nel nostro contatto con il mondo esterno. Tutte a volte desideriamo di essere invisibili.
E proprio per questo auspico una grande manifestazione di musulmane e cristiane, con minigonne e hijab, nella quale mescolarci e incontrarci fino a diventare irriconoscibili, e gridare insieme: lasciateci in pace, non abbiamo bisogno della vostra protezione intimidatoria.