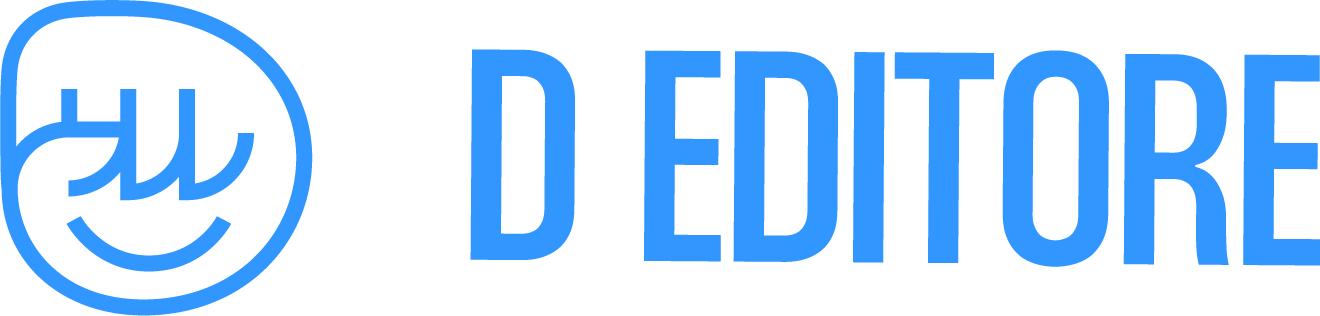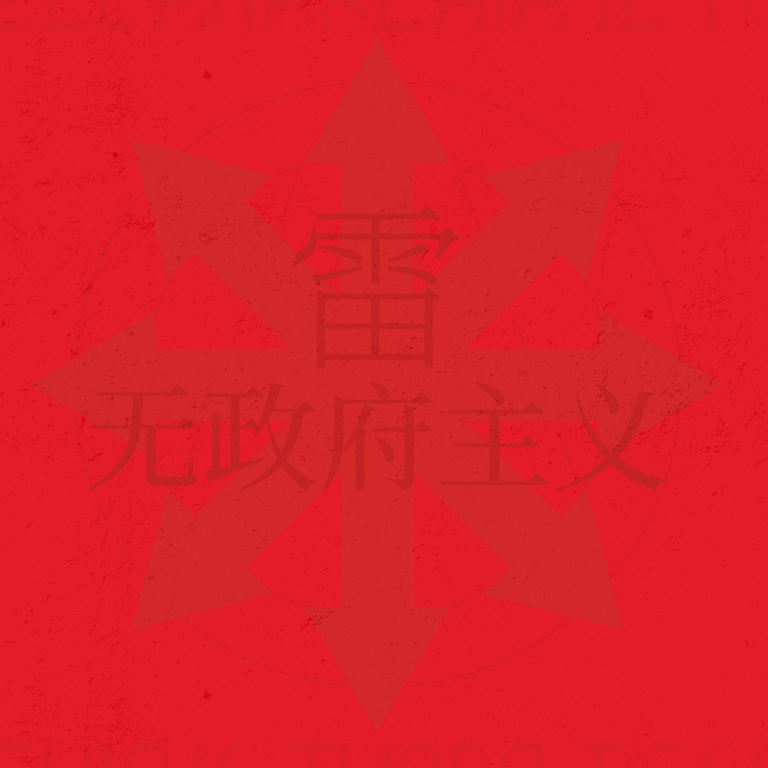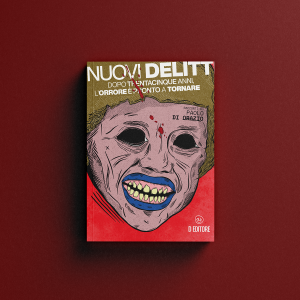L’insostenibile efficienza del calcolo
Di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
∞
Epistola scritta in occasione di OSA, evento conclusivo del progetto Funder35 organizzato da Fondazione Fitzcarraldo – 29 aprile 2022, Oratorio San Filippo Neri (Bologna).
Questa lettera è rivolta alla comunità di Funder35.
A chi di voi sarà presente in sala.
E a tutti gli operatori della cultura che in un modo o nell’altro la leggeranno. Specialmente a chi, facendo questo mestiere, soffre per la violenza e la competizione degli ecosistemi comunicativi e relazionali in cui siamo immersi.
Non siete soli e questa sofferenza ha ragioni strutturali profonde che parlano del nostro tempo.
Sostenibilità è una parola che fa riflettere, se applicata alle culture. Unico confine insieme all’empatia che ci separa dalla violenza, le nostre culture sono prove di coesistenza grazie alle quali siamo diventati società, imparando ad esprimerci, a comunicare e a convivere nella continua co-evoluzione fra tecnica, tecnologia e ambiente di cui siamo il risultato. Da ciò derivano due considerazioni che possono fare luce sul tema di oggi, ma anche sul ruolo e sulla posizione degli operatori culturali nelle società tecnologicamente avanzate, esposte alla continua mediazione di dati e della computazione.
La prima considerazione è ovvia, ma ci preme ricordarlo: le nostre culture sono necessarie. Abbiamo bisogno dell’acqua, dell’ossigeno, di un tetto sopra la testa o del cibo per sopravvivere, come abbiamo bisogno delle nostre culture per restare umani e continuare ad evolverci. Esseri umani non si nasce, lo si diventa. Stanley Kubrick ce lo mostra nella sequenza iniziale di 2001: Odissea nello Spazio, quando l’osso lanciato nel cielo si trasforma in una navicella spaziale. L’essere umano nasce in quel momento. La storia delle tecnologie è la storia dell’essere umano: ogni volta che ne stringiamo in pugno una, ci muta per sempre. Nonostante ciò, l’idea che le tecnologie si possano semplicemente usare è quella più diffusa.
La seconda considerazione discende da questo fatale fraintendimento. Pensiamo che le tecnologie vivano nel dominio dell’utilità, che siano là: meri strumenti per servire o asservire (una risorsa del mondo animale, vegetale, minerale, umano…) e ottenere risultati (che possiamo misurare, calcolare, esporre…). Questa ingenua concezione delle tecnologie è all’origine di una devastante relazione di dominio fra noi (soggetto) e l’ambiente (oggetto) al cui centro oggi ci sono le sfere culturali, sociali e psicologiche umane. Nel mondo in cui i dati sono diventati il nuovo petrolio, i giacimenti su cui piazzare i pozzi estrattivi siamo diventati noi: le nostre emozioni, espressioni, i modi in cui ci rappresentiamo e stabiliamo relazioni (affettive, professionali, intime). Il calcolo e la contabilizzazione hanno raggiunto il sé: il cuore generativo delle nostre identità. Nelle nostre società tecnologicamente avanzate c’è un movimento riconoscibile: dal corpo, il confine della violenza si sposta progressivamente sui territori immateriali della cultura e della psicologia delle persone. La comunicazione è palesemente intrisa di linguaggio balistico: facciamo campagne per colpire i nostri target, anche quando si tratta di un festival. La stessa parola impatto è di origine militare. La guerra è entrata nelle parole della cultura e del progetto, fino al punto in cui noi stessi (il nostro sé) diventa l’oggetto più o meno consapevole di tali campagne: quanti like ha fatto il mio ultimo post? quanti amici ho raggiunto? quanto valgo? quanto vale il mio ecosistema di relazioni?
Il risultato è un ambiente competitivo e auto-estrattivo in cui potremo farci solo male, proprio come in guerra l’unica certezza è contare morti e feriti sul campo di battaglia. E al fronte ci siamo noi: artisti, curatori, operatori della cultura, persone.
Che fare?
Non c’è nulla che obblighi le cose ad andare così, possiamo uscire dal realismo che costringe le tecnologie, i progetti, la comunicazione e i nostri stessi sè nella gabbia del calcolo e dell’estrazione. Ciò che serve è un cambio di prospettiva. Dobbiamo riconoscere che le tecnologie vivono prima nel dominio del sentire che in quello dell’usare. Che il loro status è quello di artefatti culturali ed esistenziali: estensioni dei nostri corpi e delle nostre identità attraverso cui percepiamo, ci esprimiamo e auto rappresentiamo, ci relazioniamo fra di noi e con l’ambiente stabilendo ponti con gli attori dei nostri ecosistemi.
Si tratta in sintesi di riconoscere che non abbiamo (solo) bisogno di tecnologie efficienti per risolvere problemi. Abbiamo bisogno di tecnologie sensibili.
La buona notizia è che i linguaggi tecnologici contemporanei basati sui dati e la computazione – intelligenze artificiali in testa a tutti – sono tecnologie perfette per fare questo mestiere. Se oggi si spendono milioni in programmi focalizzati sul calcolo, l’estrazione o le celeberrime attività predittive, è solo a causa della dilagante ideologia realista: chiuse in questo recinto, istituzioni pubbliche e private non sembrano in grado di immaginare altro. Quando in realtà abbiamo a che fare con le tecnologie più relazionali che l’essere umano abbia mai concepito: quelle in grado di descrivere, farci abbracciare e percepire la complessità. Il mutamento è strutturale e si manifesta già nelle nostre culture: dall’arte alla scienza, tutto prende la forma della rete, quel -net che ci ha reso un mondo non solo globale ma anche interconnesso. In questo processo accadono cose sorprendenti. Mentre matematica e fisica raggiungono punte di poesia che fanno impallidire il genio letterario – come le conturbanti figure degli attrattori strani – il calcolo ci consegna una realtà sorprendente: oggi i dati non hanno più senso perché si possono contare, ma perché ci si possono trovare forme dentro. Le intelligenze artificiali, immerse in una peculiare forma di contemplazione algoritmica, fanno questo tutto il giorno: scrutare miriadi di dati alla ricerca di pattern ricorrenti.
Ecco cosa osserviamo. Contemplazione e interpretazione, relazione e traduzione, coesistenza e sensibilità (o sense-ability, il bel neologismo mutuabile dell’inglese per descrivere nuove abilità del sentire): a guardarle più da vicino, le tecnologie dei dati e della computazione parlano la lingua dell’estetica, dell’ecologia, della collaborazione fra l’arte e la scienza.
Tutto questo per noi non sono gusci di parole alla moda, accozzate per scrivere un nuovo bando. È la vita che abbiamo scelto come artisti, e come operatori della cultura quando siamo diventati noi stessi un centro di ricerca, con un obiettivo: ottenere che l’arte non fosse una decorazione ma il driver dei processi di innovazione tecnologica e sociale. Dal 2020 questo movimento della pratica e del pensiero è confluito nel Nuovo Abitare: abbiamo capito che restituire i dati sotto forma di opere d’arte o processi partecipativi come facevano anche solo pochi anni fa, non basta più. Nel Nuovo abitare creiamo rituali che riposizionano sistematicamente i dati nel bel mezzo della società, rendendoci sensibili ai fenomeni complessi. La nostra speranza è che impareremo a danzare insieme intorno al fuoco della computazione, esplorando i nostri cieli fatti di dati, per scoprire nuove stelle e tracciare nuove costellazioni.
Tutto questo ci dà gioia, e dà senso alle nostre vite. Ma bisogna riconoscere che essere organizzazioni culturali, nell’ambiente competitivo ed estrattivo in cui siamo immersi, è una fatica immensa, persino soverchiante. Nel 2019 siamo finiti dallo psicologo per questo: un bravissimo professionista di formazione sistemica che ci ha aiutato ad osservare le forme del nostro ambiente relazionale e comunicativo. Per un anno abbiamo parlato solo di lavoro: non della precarietà o della sua assenza, ma della sofferenza di avere a che fare con la burocrazia, il calcolo, l’amministrazione e la violenza dei progettifici della cultura in cui le organizzazioni sono spinte a trasformarsi nella corsa a bandi e finanziamenti.
Il nostro psicologo era un costo aziendale. Per questo, nella nostra esperienza la prima sostenibilità di cui prendersi cura è quella psicologica. Facendolo, saremo costretti ad occuparci dei nervi scoperti delle nostre società, fino ai midolli. Nel 2020, Nuovo Abitare è nato così, esposti al dolore di una metamorfosi in cui da coppia di artisti siamo diventati un’organizzazione: ogni bando, ogni collaborazione, ogni progetto una cicatrice che racconta sulla pelle la storia dell’impresa. In questo corpo a corpo con entità non umane, fatte di bilanci, commercialisti, budget e mitologiche application form, abbiamo imparato moltissimo. Ne siamo usciti trasformati, come artisti, ricercatori, professionisti ed esseri umani.
Per questo vogliamo lasciarvi con un messaggio. Il mestiere di operatore culturale probabilmente ad oggi non è sostenibile, ma è necessario.
Non è sostenibile non solo a causa della precarietà, della penuria di risorse o dell’accesso ai bandi. Ma anche per come i bandi sono scritti. Per le parole usate nel descriverli e valutarli. Per i media che abitiamo e attraverso i quali ci esprimiamo, e il modo in cui la comunicazione e le nostre tecnologie sono concepite.
Nel Nuovo Abitare stiamo prendendo decisioni radicali, ve ne raccontiamo due. Da febbraio abbiamo intrapreso “Comunicazione Ecosistemica: il workshop senza fine”. Non sappiamo ancora come sia fatta una comunicazione ecosistemica, ma su di noi e in chi sta prendendo parte all’esperimento gli effetti sono stati già definiti terapeutici. Abbiamo inoltre deciso che non parteciperemo più a manifestazioni ed eventi come gli hackaton né a bandi culturali basati su estetiche e logiche estrattive riduzioniste, che costringono partecipanti e operatori a competere in lotta fra loro o per accaparrarsi pubblici e like. Alcuni bandi e alcuni inviti li abbiamo già scartati, e anche questo si è rivelato un atto terapeutico.
Abbiamo creato le culture per unire, non per dividere. Ciò di cui abbiamo bisogno non sono solo risorse, ma il coraggio e la sensibilità di nuova immaginazione sociale.
Testo rilasciato in licenza Creative Commons Attribution Share Alike 4.0