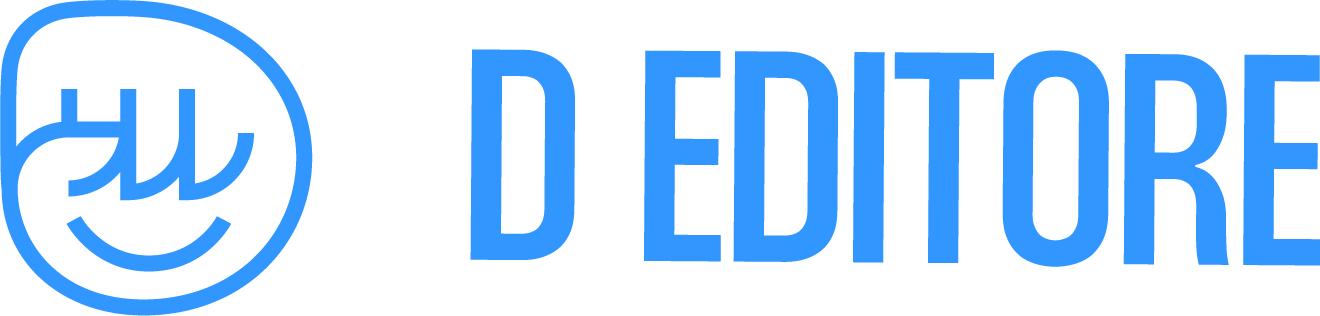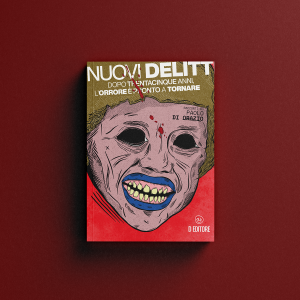Breve storia della disoccupazione tecnologica
Breve storia della disoccupazione tecnologica è contenuto in La società degli automi.
∞
Un concetto controverso
Quando si analizza il discorso pubblico sulla disoccupazione tecnologica, ciò che sorprende maggiormente è la sostanziale mancanza di accordo sull’esistenza stessa del fenomeno. C’è chi presenta la disoccupazione tecnologica come un mostro tentacolare che sta sovvertendo completamente l’economia del pianeta e chi invece afferma che si tratta di un miraggio dei soliti catastrofisti. Poiché nel dibattito sono impegnati studiosi rispettabili, non possiamo imputare la polarizzazione delle narrazioni semplicemente all’incompetenza dell’una o dell’altra scuola di pensiero. È ormai evidente che il termine “disoccupazione tecnologica” assume un significato diverso a seconda della prospettiva teorica di partenza.
Le definizioni del termine che si trovano in circolazione non sono poi così diverse. Quella proposta dal dizionario online delle Edizioni Giuridiche Simone è la seguente: «Disoccupazione tecnologica. È generata dall’introduzione, sempre più diffusa, di macchinari ed impianti nel processo produttivo (v. Automazione) che riduce la quantità di lavoro impiegata per ogni unità di prodotto». Come si può notare si tratta di un concetto che include già una teoria, giacché pone in relazione causale due fenomeni distinti: lo sviluppo tecnologico e la disoccupazione. Il disaccordo tra le scuole di pensiero nasce sul modo di intendere questo rapporto causale.
La disoccupazione è di per sé un fenomeno complesso. Può essere temporanea o permanente. Se è temporanea, può essere di breve o lungo periodo. Inoltre, il fenomeno può essere studiato a diversi livelli dell’economia: a livello degli attori individuali, a livello delle aziende, a livello del settore produttivo, a livello del sistema-paese, a livello dell’economia globale. Che almeno un individuo abbia perso l’impiego, perché il datore di lavoro o il committente ha acquistato un macchinario in grado di svolgere esattamente le sue mansioni è un fatto che non può essere negato. Allo stesso modo, non può essere negato che intere aziende sono state automatizzate e che questo processo ha provocato una drastica riduzione del livello occupazionale nell’azienda. Così come non può essere negato che, in seguito all’innovazione tecnologica, interi settori si sono “svuotati” di forza lavoro. Il passaggio dall’agricoltura tradizionale all’agricoltura intensiva, attraverso l’uso di macchine agricole, diserbanti, fertilizzanti, anticrittogamici, eccetera, ha portato allo svuotamento demografico delle campagne. L’evaporazione dei posti di lavoro nel settore primario degli Stati Uniti d’America offre numeri impressionanti: se nel 1900 il 41% della popolazione era impiegata in agricoltura, un secolo più tardi, nel 2000, soltanto il 2% degli americani lavorava ancora nello stesso settore. Un fenomeno analogo è stato osservato nel settore secondario, o manifatturiero, a cavallo tra il XX e il XXI secolo. Sempre negli Stati Uniti, l’incidenza dell’occupazione nelle fabbriche è scesa dal 22,5% del 1980 al 10% attuale e si prevede un’ulteriore discesa sotto il 3% entro il 2030. Situazioni simili sono osservabili in altri paesi industrializzati, inclusa l’Italia.
Certamente, questo “svuotamento” di interi settori dell’economia è stato accompagnato da una “migrazione” della forza lavoro da un settore all’altro. Una prima migrazione si è osservata dall’agricoltura alla manifattura, fenomeno molto più visibile perché ha comportato anche una migrazione di massa dalla campagna alla città. Una seconda migrazione della forza lavoro, meno visibile ma altrettanto consistente, è avvenuta dal settore manifatturiero al settore terziario o dei servizi. Nel complesso, almeno finora, l’aumento della produttività nei singoli settori non ha provocato l’emersione di una disoccupazione tecnologica permanente e cronica a livello globale. Questo non significa, però, che la disoccupazione tecnologica – intesa come fenomeno temporaneo e locale – non esista.
Va anche messo in chiaro che il riassorbimento della disoccupazione tecnologica è finora avvenuto grazie a due leve principali: una è quella del libero mercato che ha consentito la nascita e lo sviluppo di nuovi settori dell’economia e l’altra e quella delle politiche pubbliche (sociali e industriali). Il fatto che entrambe le forze siano all’opera è spesso oscurato dal fatto che gli osservatori sono perlopiù divisi in due tribù: i liberisti, che hanno elevato il Mercato a un dio onnipotente, e gli statalisti, che hanno attribuito il carattere di divinità allo Stato. Coloro che non appartengono stabilmente a nessuna delle due “religioni” possono constatare che tanti fattori hanno contribuito a smorzare il fenomeno della disoccupazione tecnologica. Imprenditori privati hanno creato industrie manifatturiere e impiegato la manodopera a basso costo che fluiva dalle campagne alle città, a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Nuovi intraprendenti capitalisti hanno creato aziende di servizi per reimpiegare la manodopera che fuoriusciva dalle manifatture, sul finire del XX secolo. Contemporaneamente, i lavoratori salariati, attraverso dure lotte politiche e sindacali, sono riusciti ad ottenere una costante riduzione degli orari di lavoro (addirittura un dimezzamento se si considera il periodo dal XIX secolo al presente), le pensioni di anzianità e inabilità, le ferie retribuite, la malattia retribuita, il congedo per maternità, e altri diritti sociali, che nel complesso hanno obbligato gli imprenditori privati ad assumere più lavoratori di quelli che avrebbero assunto in un regime di capitalismo laissez-faire.
Inoltre, l’idea di un sistema-paese in equilibrio economico grazie alla Mano Invisibile è smentita dal fatto che la crisi occupazionale è stata talvolta risolta grazie all’emigrazione in massa da un paese all’altro. Questo significa che non è scritto nelle stelle che debbano continuamente nascere imprenditori privati capaci e creativi che creano nuovi posti di lavoro o addirittura nuovi settori economici. Laddove non nascono, o non ci sono le condizioni perché nascano, la crisi occupazionale generata dall’introduzione di nuove tecnologie può diventare cronica e irreversibile. Infine, ad attutire il fenomeno hanno contribuito altre forme di intervento pubblico come le politiche industriali, la creazione di manifatture pubbliche, la nazionalizzazione di aziende private, le commesse pubbliche (si pensi solo all’incidenza della spesa militare negli Stati Uniti), le guerre, il crimine (la popolazione carceraria negli USA supera ormai i due milioni di individui), nonché la creazione di milioni di posti di lavoro nell’ambito della pubblica amministrazione – lavori che talvolta sono inutili e costituiscono dunque un sussidio di disoccupazione permanente mascherato.
Se si considerano tutti questi aspetti, alcuni dei quali ignorati dalla teoria economica, pare difficile negare l’esistenza della disoccupazione tecnologica. Diversa la questione se si tratti di un fenomeno rilevante. Dal punto di vista psicologico, sarà certamente preoccupante per coloro che perdono il lavoro, quand’anche temporaneamente. Ma la questione inizia ad acquisire rilevanza politica soltanto se la percentuale di individui interessati dal fenomeno è tale da mettere in difficoltà l’intero sistema-paese. Nel corso della storia, sono stati osservati diversi momenti in cui il fenomeno della disoccupazione tecnologica ha assunto proporzioni critiche.
Passato: il passaggio dal feudalesimo al capitalismo
Notoriamente, un momento piuttosto critico della storia europea è stato il passaggio dal sistema feudale al sistema capitalistico, e non soltanto per le sanguinose rivoluzioni politiche che hanno accompagnato la trasformazione. Nel sistema feudale il lavoro non costituiva “un problema”, nel senso odierno, perché la mobilità sociale era minima. I figli ereditavano il lavoro dei padri. I figli dei contadini sapevano che sarebbero stati contadini a loro volta, o servi della gleba. I figli degli artigiani avrebbero appreso il mestiere nelle botteghe dei padri. Il figlio primogenito di una famiglia aristocratica avrebbe ereditato il feudo o il latifondo, mentre i suoi fratelli minori sarebbero stati avviati alla carriera militare o ecclesiastica. Mendicanti, banditi, vagabondi e avventurieri costituivano le eccezioni a una regola ferrea. Nel Medioevo le preoccupazioni economiche erano altre: le guerre, le epidemie, le carestie. Un grave problema che si poteva presentare era piuttosto la carenza di manodopera in seguito a un’epidemia.
Con il passaggio al sistema capitalistico, nascono problemi prima sconosciuti: in primis, la sovrapproduzione e la disoccupazione. L’introduzione di macchine nel sistema produttivo e la mobilità sociale sconvolgono la concezione stessa del lavoro e della vita. Che qualcuno possa non lavorare è inconcepibile, tanto che la prima reazione delle autorità politiche è quella di limitare l’uso delle macchine laddove provocano disoccupazione. Persino il mercantilista Jean-Baptiste Colbert, che diede grande impulso all’industrializzazione della Francia con la creazione delle cosiddette Manifatture Reali, passò provvedimenti volti a limitare l’utilizzo di macchine nelle aziende private.
Laddove le autorità non intervengono, sono gli operai stessi a intraprendere una lotta feroce e disperata contro la macchina, della quale troviamo un resoconto dettagliato anche nel Capitale di Karl Marx.
Quasi tutta l’Europa poté assistere nel corso del XVII secolo alle rivolte operaie contro la cosiddetta Bandmühle (chiamata pure ‘Schnurmühle’ ο ‘Mühlenstuhl’), una macchina per tessere nastri e passamani. Intorno al 1630 circa una segheria a vento, costruita da un olandese nelle prossimità di Londra, fu distrutta dagli eccessi della plebe. In Inghilterra sul principio del XVIII secolo le segherie idrauliche riuscirono a mala pena ad aver ragione dell’opposizione del popolo, sostenuto dal parlamento. Quando Everet nel 1758 costruì la prima macchina ad acqua per cimare la lana, centomila operai rimasti disoccupati le dettero fuoco. 50.000 operai, che guadagnavano di che vivere con la cardatura della lana, inviarono al parlamento una petizione contro gli scribbling mills e le cardatrici meccaniche di Arkwright. La distruzione in massa di macchinari nei distretti manifatturieri d’Inghilterra nel corso del primo quindicennio del secolo XIX, causata in special modo dallo sfruttamento del telaio a vapore e conosciuta con il nome di movimento dei Ludditi, dette al governo antigiacobino di un Sidmouth, un Castlereagh, eccetera, il pretesto per violenze ultrareazionarie. Occorre tempo ed esperienza perché l’operaio sia in grado di distinguere le macchine dall’uso che il capitale fa di esse, e perciò per rivolgere le sue accuse non al mezzo materiale di produzione preso in sé stesso, bensì alla forma sociale del suo sfruttamento.
Tale è l’incidenza del fenomeno che in Inghilterra viene addirittura introdotta la pena di morte per i luddisti. L’“uccisione” di una macchina viene messa sullo stesso piano dell’uccisione di un essere umano. Eppure, gli economisti sono restii a modificare le proprie teorie per rendere conto della disoccupazione tecnologica. Un primo tentativo di concettualizzazione viene offerto da James Steuart nel 1767. Si ammette che la meccanizzazione improvvisa di un segmento della produzione può produrre disoccupazione temporanea e, perciò, sono necessarie politiche pubbliche per facilitare il riassorbimento della forza lavoro in altre mansioni. Per Steuart i vantaggi della meccanizzazione restano superiori agli effetti collaterali negativi, ma è altresì convinto che il problema non si risolva necessariamente da sé. Quella di Steuart è però una voce isolata. L’economia classica è dominata dall’indirizzo ottimistico di Adam Smith che enfatizza gli effetti positivi della meccanizzazione e i meccanismi autoregolativi dell’economia di mercato. Gli economisti classici elaborano la cosiddetta “teoria della compensazione” – «una teoria secondo cui la classe lavoratrice viene compensata dalle sofferenze iniziali conseguenti all’introduzione delle macchine che risparmiano lavoro in virtù dei successivi effetti favorevoli di queste». Secondo tale teoria, se nuovi macchinari permettono di risparmiare lavoro, sarà comunque necessaria manodopera per la produzione di detti macchinari. Inoltre, se inizialmente i nuovi processi di produzione permettono di risparmiare lavoro, successivamente stimoleranno la domanda e l’occupazione, attraverso la riduzione dei costi e quindi dei prezzi dei beni offerti. Infine, si ipotizza l’esistenza di una perfetta identità tra redditi e spesa, e pertanto si assume che le maggiori rendite derivanti dal cambiamento tecnologico dovranno tradursi in una maggiore domanda di beni di consumo.
Se così stanno le cose, perché mai gli operai licenziati si arrabbiano tanto? Evidentemente, anche ammesso che vi sia compensazione nel medio o lungo termine, gli effetti nel breve termine sono devastanti per una classe sociale che non ha capitali o patrimonio. Per chi vive alla giornata, e magari ha numerosi figli da mantenere, anche un periodo di disoccupazione di poche settimane può risultare letale. Se poi si considera che, per trovare un nuovo lavoro, il proletario talvolta deve emigrare, lasciando affetti e luoghi cari, oppure deve accettare un’occupazione meno soddisfacente e meno remunerata, mentre vede il datore di lavoro arricchirsi ulteriormente grazie al macchinario, la sua reazione violenta appare meno misteriosa.
È per tale ragione che il grande economista David Ricardo, nel 1821, decide di riportare di peso la questione della disoccupazione tecnologica nella teoria economica. C’è da dire che, inizialmente, Ricardo non solo era rimasto nel solco dell’economia classica, negando il problema e sostenendo che l’introduzione delle macchine è benefica per tutte le classi sociali, ma aveva anche prodotto quella che è stata definita «la prima formulazione soddisfacente della teoria della ‘compensazione automatica’». Successivamente, però, disorientando i suoi stessi seguaci, «ritratta la sua precedente opinione sul tema». L’idea che «la sostituzione del lavoro umano con macchinari è spesso molto dannosa per gli interessi della classe dei lavoratori» può essere trovata nel capitolo XXXI, “On Machinery,” nella terza edizione dei suoi Principles, pubblicata nel 1821. In questo modo, l’idea di disoccupazione tecnologica «segna la sua prima apparizione nella letteratura economica rispettabile».
Come abbiamo visto, i luddisti avevano denunciato questo problema molto prima, ma solo nella teoria economica di Ricardo la disoccupazione tecnologica assume l’aura di un concetto scientifico. Successivamente, anche Marx nota che il macchinario non ha liberato l’uomo dal lavoro e diffuso il benessere come pensavano gli utopisti. Esso ha piuttosto causato la perdita di qualsiasi fonte di sostentamento per una parte della classe operaia e lo sfruttamento inumano di coloro che rimanevano impiegati nella fabbrica. Ciò perché, semplificando e alleggerendo il lavoro fisico, esso consentiva di espellere dal processo produttivo i maschi adulti – prima essenziali in quanto fisicamente più forti – per sostituirli con donne e bambini. Il vantaggio per i proprietari dei mezzi di produzione era triplo: minore manodopera necessaria; minori retribuzioni salariali, perché donne e bambini erano considerati lavoratori di rango inferiore; e allungamento indefinito dell’orario di lavoro, giacché non costituiva più un impedimento il naturale affaticamento fisico dei lavoratori. Il risultato era la disoccupazione e l’abbruttimento dei maschi adulti, che restavano a casa a ubriacarsi, mentre i loro familiari erano sepolti vivi in fabbrica. Non stupisce allora che Marx abbia lodato Ricardo per «la sua caratteristica spregiudicatezza scientifica» e «il suo amore della verità». Similmente, Lowe ha descritto il capitolo “On Machinery” di Ricardo come «un raro caso di onestà intellettuale auto-distruttiva».
Presente: la disputa tra marginalisti e keynesiani
Il dibattito sulla legittimità scientifica del concetto non si chiude però qui. La nascita dell’economia neoclassica e del paradigma marginalista cambia le carte in tavola. In particolare, è con l’opera dell’economista svedese Knut Wicksell che la bilancia ricomincia a pendere a favore della teoria della compensazione. Wicksell, basandosi sulla legge della produttività marginale dei fattori produttivi, sostiene che sono i salari la chiave del problema. Non c’è un rapporto causale diretto tra progresso tecnologico e disoccupazione, perché la vera causa della disoccupazione è un’altra. Se è vero che l’espulsione di lavoratori per l’attuazione di innovazioni tecniche comporta un aumento dell’offerta di lavoro rispetto alla domanda, è anche vero che in un’economia libera l’aumento di offerta comporta una diminuzione dei salari. A sua volta, la diminuzione della remunerazione del lavoro rispetto a quella del capitale stimola la domanda di lavoro, giacché i settori non ancora interessati dall’innovazione tecnologica troveranno conveniente assorbire la manodopera in eccesso. In altre parole, la disoccupazione che permane nel medio-lungo periodo – ovvero quella che preoccupa davvero – non è da imputare all’aumento della produttività causato dal progresso tecnologico, ma eventualmente alla rigidità dei salari verso il basso che impedisce il riassorbimento dei lavoratori in settori meno avanzati.
Rispetto agli economisti classici, gli esponenti della scuola marginalista adottano strumenti matematici più sofisticati, come il calcolo infinitesimale, e grazie alla maggior professionalizzazione riescono a definire in modo accurato e formale il concetto di utilità marginale che sta alla base della loro teoria. Lo stesso Wicksell nasce come matematico e soltanto successivamente approda all’economia. Si diffonde l’idea che tutta la polemica tra teorici della disoccupazione tecnologica e teorici della compensazione automatica abbia potuto svilupparsi soltanto per via della scarsa professionalità degli economisti dell’Ottocento. A proposito, Schumpeter afferma che «la polemica che proseguì per tutto il secolo XIX e oltre, soprattutto sotto forma di argomentazioni a favore o contro la compensazione, è morta e sepolta: …essa sparì dalla scena non appena nell’uso generale s’infiltrò una tecnica più progredita che non lasciò nulla su cui dissentire».
In realtà, la polemica era “morta e sepolta” soltanto per gli economisti della scuola neoclassica. Per gli economisti non ortodossi, nelle pieghe dei calcoli, si nascondeva una tesi a dir poco desolante: se i luddisti attribuivano la “colpa” della disoccupazione ai macchinari e i marxisti al sistema di sfruttamento capitalistico, i neoclassici la scaricavano sugli operai che non si accontentavano di lavorare per un piatto di lenticchie, o sui governi socialdemocratici che imponevano una retribuzione oraria minima affinché gli operai potessero almeno sopravvivere.
L’egemonia dell’economia neoclassica nelle accademie sembra ormai inattaccabile, quando viene incrinata dalla devastante crisi economica del 1929. Un nuovo paradigma, quello keynesiano, è destinato a prendere quota negli ambienti politici e scientifici. Sfidando l’ortodossia, nel 1930, John Maynard Keynes reintroduce nel discorso economico il concetto di disoccupazione tecnologica. Significativo il fatto che ne parla come di un fatto nuovo, come se Ricardo e Marx non avessero mai discusso il problema. Queste le sue parole:
We are being afflicted with a new disease of which some readers may not yet have heard the name, but of which they will hear a great deal in the years to come – namely, technological unemployment. This means unemployment due to our discovery of means of economising the use of labour outrunning the pace at which we can find new uses for labour. But this is only a temporary phase of maladjustment. All this means in the long run that mankind is solving its economic problem.
Keynes non è un catastrofista, né un luddista. Vede nel progresso tecnologico una grande risorsa. È convinto che la disoccupazione tecnologica sia soltanto di una malattia temporanea. Questo perché confida nella possibilità di risolvere il problema con le opportune politiche pubbliche, cominciando da una drastica riduzione dell’orario di lavoro. Nello stesso articolo prevede che, «nel corso della nostra vita» (dunque, nell’arco di alcuni decenni), vedremo in atto riforme sociali che ci porteranno a lavorare tre ore al giorno, cinque giorni alla settimana, per complessive quindici ore settimanali, a parità di reddito. Gli pareva, insomma, ragionevole risolvere la crisi economica lavorando meno, lavorando tutti, ossia ridistribuendo equamente i benefici del progresso tecnologico.
Keynes non aveva però fatto i conti con il ritorno del paradigma neoliberista. Dopo la crisi del 1929 pareva impossibile che si potesse tornare al capitalismo laissez-faire. Invece, com’è noto, la controffensiva neoliberista ha pieno successo con l’approdo di Margaret Thatcher a Downing Street nel 1979 e di Ronald Reagan alla Casa Bianca nel 1981. Quello che accade in seguito alle loro politiche non è, naturalmente, la scomparsa del lavoro, ossia la disoccupazione tecnologica globale permanente, nonostante siano state introdotte nel tessuto produttivo innovazioni che nel 1930 appartenevano soltanto alla sfera della fantascienza. Il pericolo è, però, scongiurato grazie alla flessibilità, in pieno accordo con la teoria marginalista.
L’introduzione di computer e robot nelle fabbriche e negli uffici, negli ultimi quarant’anni, ha portato all’arricchimento di una minoranza e alla precarizzazione e al depauperamento della maggioranza. Ci sono ancora molti lavori sul mercato, perché le macchine, al loro attuale grado di sviluppo, non sono necessariamente sostitutive della manodopera, ma soltanto complementari. I lavori che non scompaiono del tutto sono però quelli più umili e meno pagati, quelli che comportano uno sforzo fisico che non può essere definito da una lista di regole facilmente implementabili in una macchina. Pensiamo, per esempio, ai badanti di anziani e disabili, ai pony express, agli addetti dei call center, ai camerieri, ai lavoratori dei fast food, agli addetti delle imprese di pulizie, ai “tassisti” Uber, ai collaboratori esterni con partita iva, agli operatori ecologici, ai postini privati, ai magazzinieri, ai commessi dei negozi, eccetera. In questi casi, al datore di lavoro risulta economicamente più vantaggioso assumere – per dire – un immigrato sottopagato che non meccanizzare il lavoro (ammesso che esista una macchina in grado di svolgerlo). Al contrario, nella fase neoliberista, i posti di lavoro a tempo pieno e a vita, come gli impieghi nelle grandi fabbriche e negli uffici, riservati in genere alla classe media, si sono contratti tanto nel numero quanto nel livello della retribuzione.
Gli osservatori sembrano stupiti di questo fenomeno, come dimostra un articolo recentemente apparso sul The Wall Street Journal:
The typical man with a full-time job–the one at the statistical middle of the middle–earned $ 50,383 last year, the Census Bureau reported this week. The typical man with a full-time job in 1973 earned $ 53,294, measured in 2014 dollars to adjust for inflation. You read that right: The median male worker who was employed year-round and full time earned less in 2014 than a similarly situated worker earned four decades ago. And those are the ones who had jobs.
Ci si stupisce che i lavoratori guadagnino mediamente meno nel 2014 che nel 1973, nonostante tutti i progressi fatti dall’uomo nel frattempo, ma la teoria della compensazione non dice che grazie al progresso tecnologico vivremo tutti felici e contenti. Dice che non ci sarà disoccupazione di massa se sarà garantita la flessibilità dei salari. L’effetto collaterale negativo diventa così, ipso facto, quello che potremmo definire “impoverimento tecnologico”. Se a questo si aggiunge il danno provocato dalle speculazioni finanziarie e dalla bolla immobiliare globale, il quadro è completo. La crisi del 2008 «ha dimostrato l’assurdità tecnica – oltre che morale – del paradigma neoliberista, centrato sul mercato autoregolato».
Futuro: l’automazione dei servizi e delle professioni
Ora, all’orizzonte, si intravvedono innovazioni in grado di sconvolgere ulteriormente il mercato del lavoro. Sui possibili scenari futuri legati all’automazione ho già dedicato una monografia in inglese, un capitolo della quale – Cittadini e automi – è stato recentemente tradotto in italiano e inserito in un’antologia dedicata al Reddito di cittadinanza. In questa sede, voglio limitarmi soltanto a un esempio attinente al racconto letterario “Il duello” di Francesco Grasso, inserito in questa collettanea.
Nel maggio del 2013, il McKinsey Global Institute ha pubblicato uno studio dettagliato su una dozzina di nuove tecnologie definite “dirompenti” per le loro potenziali ricadute sull’economia. Tra le innovazioni più significative compaiono i veicoli autonomi o semi-autonomi.
It is now possible to create cars, trucks, aircraft, and boats that are completely or partly autonomous. From drone aircraft on the battlefield to Google’s selfdriving car, the technologies of machine vision, artificial intelligence, sensors, and actuators that make these machines possible is rapidly improving. Over the coming decade, low-cost, commercially available drones and submersibles could be used for a range of applications. Autonomous cars and trucks could enable a revolution in ground transportation—regulations and public acceptance permitting. Short of that, there is also substantial value in systems that assist drivers in steering, braking, and collision avoidance. The potential benefits of autonomous cars and trucks include increased safety, reduced CO2 emissions, more leisure or work time for motorists (with hands-off driving), and increased productivity in the trucking industry.
Come si può notare, i ricercatori della McKinsey mettono in evidenza la crescita della produttività e, come ricaduta per gli autotrasportatori, l’aumento del “tempo libero” o delle “ore di lavoro” (grazie al minore affaticamento psico-fisico). Utilizzando un linguaggio più brutale potremmo anche dire: l’aumento della “disoccupazione” o dello “sfruttamento”. Curiosamente, in un rapporto lungo 164 pagine, la parola “unemployment” compare soltanto una volta. Si ammette che nel breve termine potrebbe presentarsi questo inconveniente, per precisare subito dopo che nel lungo termine l’innovazione comporterà la creazione di nuovi posti di lavoro «di più alto valore». Un mese più tardi, il premio Nobel per l’economia Paul Krugman nota che dal rapporto si possono trarre conclusioni ben meno ottimistiche, giacché l’intelligenza artificiale non solo promette di diminuire ulteriormente la forza lavoro nelle manifatture, ma inizia a intaccare i lavori degli specialisti nel settore dei servizi, ovvero di attori economici che hanno investito molto tempo e denaro per acquisire la propria professionalità, come medici e insegnanti.
In altre parole, in un’economia capitalistica, la scelta sembra ridursi a due prospettive: se si introducono politiche volte a salvaguardare il tenore di vita dei lavoratori stabilendo che il salario minimo non possa scendere sotto una certa soglia (politica della sinistra moderata) avremo “disoccupazione tecnologica”, se invece si stabilisce che il governo non deve interferire nelle contrattazioni tra capitalisti e lavoratori lasciando che sia il mercato a decidere i livelli salariali (politica della destra moderata) avremo “impoverimento tecnologico”.
In genere, a chi porta l’attenzione su questa paradossale situazione, viene retoricamente fatto notare l’ovvio: i sistemi alternativi al capitalismo storicamente conosciuti – feudalesimo, corporativismo fascista, collettivismo comunista – sono falliti. Ma la questione può essere inquadrata in altri termini. Posto che non vogliamo rinunciare al progresso scientifico-tecnologico (questa è naturalmente un’opinione soggettiva), possiamo chiederci com’è possibile che esseri senzienti che riescono a inventare i computer quantistici e a creare la vita artificiale, poi, non riescano a escogitare un nuovo sistema di produzione e consumo in cui queste e altre innovazioni, se proprio non vanno a vantaggio di tutti nella stessa misura, perlomeno non vanno a detrimento della maggioranza. Davvero la mente dell’uomo del XXI secolo è così limitata?