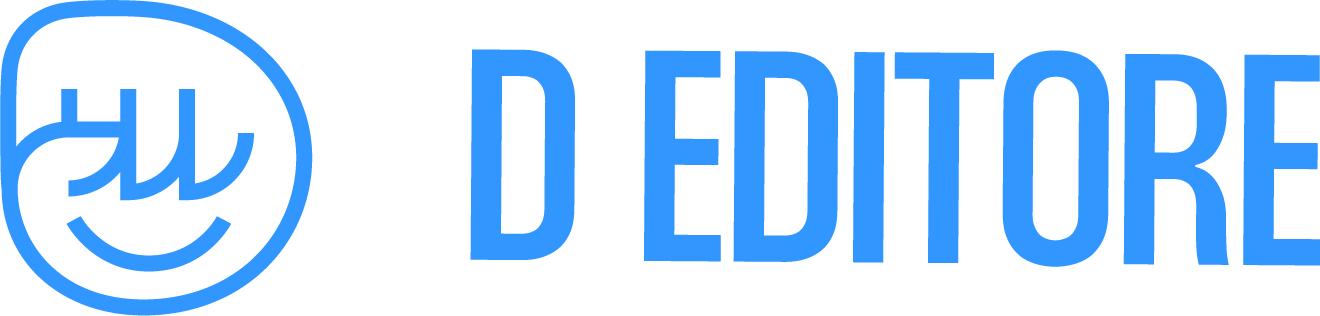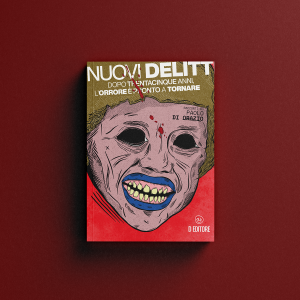Contro il tubo catodico
∞
Nonostante le recenti restrizioni abbiano contribuito ad affrettare il processo – ancora incerto – di digitalizzazione, l’arte contemporanea sembra spesso assoggettata al fascino analogico del tubo catodico. Se da una parte gli NFT e la criptoarte hanno monopolizzato il dibattito, dall’altra continuano ad avvicendarsi gli allestimenti realizzati con apparecchi obsoleti. Si aprono scenari tutt’altro che inediti: le pareti bianche dello spazio espositivo celebrano il totem ormai consunto, gli altoparlanti emettono armonie stridenti e stanche, le immagini si degradano, faticano ad affiorare dallo schermo, sono inafferrabili, sfuggenti. Eppure è sempre lì, ostinato, come una reminiscenza atavica e indiscutibile.
Sembriamo assuefatti dai raggi catodici. Nell’era dell’alta definizione, rivendicano la pregnanza del difetto, l’autenticità dell’imperfezione. Soddisfano il bisogno di evadere, anche solo per qualche istante, dalla quotidianità. Allo stesso tempo, però, consolidano la paradossale fascinazione per il démodé, avvalorando la presenza assidua – più che il ritorno – del vintage. Rappresentano la costante tensione tra uniformità e differenziazione. Esprimono quello che George Simmel ha definito come «il desiderio contraddittorio di essere parte di un gruppo e simultaneamente stare fuori dal gruppo, affermando la propria individualità». Di fatto, anche l’arte contemporanea sembra sconfessare la rivoluzione digitale pur facendone parte, pur dipendendone. Perché in fondo la moda è anche frutto della frammentazione sociale: l’esclusività e la chiusura verso l’esterno vanno di pari passo con la coesione interna al gruppo stesso. Ed è allora che le pile stilo e gli adattatori scart diventano merce preziosa per artisti e curatori, mentre gli schermi ultrapiatti e le mele morsicate cedono il passo alla gravosa fisicità del passato, alle suggestioni orientali provocate da simboli arcani e nomi impronunciabili.
Forse è proprio questo equilibrio a consolidare l’inamovibilità del tubo catodico. Non è un caso che le sottoculture o l’arte contemporanea facciano spesso affidamento a un passato sempre più prossimo. Come se la nostalgia di una vagheggiata purezza dovesse riconoscere e legittimare il presente. Se da una parte, infatti, è vero che il potenziale utopico del mezzo può liberarsi solo nel momento della propria obsolescenza, dall’altra è innegabile che l’intramontabile fascinazione per l’analogico suoni abbastanza ridondante. Non si tratta di sfruttarne a proprio vantaggio le limitazioni tecniche: è una convenzione, un automatismo. Lo stesso dicasi, ad esempio, per tutti quei cataloghi pubblicati con le immagini pixellate. Rispettano uno schema compositivo, soddisfano le aspettative, diventano il messaggio. Parlare di emancipazione del medium rischia di risultare abbastanza anacronistico e fine a sé stesso. Claire Bishop ha evidenziato come «la prevalenza di bobine e diapositive nel mondo dell’arte mainstream sembra dire meno sull’estetica rivoluzionaria di quanto non faccia sulla fattibilità economica». Non si rimette in discussione il concetto di obsolescenza programmata, né si sa affrontano le possibili conseguenze socioculturali della digitalizzazione. Anche perché – ragionando in termini di popolarità ed emancipazione – i musei dovrebbero essere stipati di lavori realizzati con Tamagotchi, Nokia 3310 e cercapersone. Ma non è così.
Il tubo catodico è ormai una presenza costante quanto esclusiva dell’arte contemporanea e del cinema horror. Per quanto possa sembrare paradossale, In entrambi i casi assistiamo – sempre più spesso – alla stretta osservanza degli stilemi tipici del genere. L’omologazione rappresenta una certezza. Non c’è da stupirsi che l’arte contemporanea possa risultare passatista. Perfino i film splatter più oltranzisti sanno essere conservatori a modo loro. Il bisogno di appartenenza segue pedissequamente la tradizione. La responsabilità è in buona parte anche del pubblico. La contemporaneità, infatti, appare fin troppo condizionata dalla nostra ossessione per il passato. Il rimpianto soddisfa l’impulso archivistico, si espande nel mercato dei ricordi. Talvolta sono memorie usate, di seconda mano, e forse proprio per questo così appetibili. Viviamo la frustrazione di un futuro apparentemente irraggiungibile. Il domani ha le fattezze di una chimera inquieta. In tal senso, la Retromania teorizzata da Simon Reynolds così come la “sonnolenza persistente” descritta da Jaron Lanier non sembra affatto un fenomeno circoscritto al panorama musicale. I vinili, le reunion, i revival e il monopolio sperimentale delle musicassette sono le altre facce della stessa medaglia. Certo, il passato è sempre stato in competizione con il presente. Tuttavia, se in origine la nostalgia riconduceva a un luogo fisico, oggi assume un’accezione temporale spesso approssimativa, indefinita. Le frasi fatte sono senza dubbio l’esempio più fastidioso ed eclatante: i vari “si stava meglio quando si stava peggio” e “le cose di una volta duravano di più” continuano imperterriti a scandire le nostre giornate, come il peggiore dei tormentoni estivi.
La presunta immaterialità del digitale è un elemento altrettanto centrale nel consolidamento del passato. Affrontare la fisicità dei media diventa un passaggio sempre più necessario. Il tubo catodico, ad esempio, afferma in maniera netta la propria presenza all’interno dello spazio espositivo, mentre il digitale, il più delle volte, appare etereo, immateriale. Eppure, fin dall’etimologia del termine stesso, il punto focale è la relazione tra il sistema logico e la sua interfaccia, la sua corporeità. Nonostante in latino Digitalis indichi l’uso delle dita per il calcolo, implicando un gesto fisico, il digitale viene recepito fin troppo spesso come un qualcosa di inafferrabile, di sfuggente. Come un iperoggetto costantemente presente, ma così vasto da risultare intangibile. Tuttavia, questa astrazione telematica ha eccome un suo peso specifico. Vincenzo Estremo – in Teoria del lavoro reputazionale – ha sottolineato come questo risulta piuttosto evidente se pensiamo alle conseguenze climatiche, occupazionali e sociali. Forse, l’idea che i nuovi media siano sostanzialmente immateriali è frutto di una precisa strategia comunicativa e dell’imperante retorica aziendalistica. Per quanto riguarda il calcolo digitale o il cloud computing, ad esempio, questa narrazione sembra rispondere all’intento di stabilire un’inedita struttura gerarchica. Il paradigma della produzione odierna passa dall’elaborazioni di informazioni, ma il potere effettivo non risiede tanto nei “nostri” dati quanto piuttosto nella gestione delle infrastrutture telematiche. Pertanto, la comprensione del digitale come sostanza immateriale – così come la teocratica associazione dei dati e delle informazioni all’immagine della nuvola – si afferma come un atto interpretativo, economico e soprattutto politico.
Tutti i nostri dispositivi, infatti, sono progettati in relazione alla fornitura di servizi. Questi devices interagiscono con lo spazio mediale circostante, ma fanno riferimento a sistemi centralizzati. Ogni genere di attività produttiva deve essere accettata, passata al vaglio delle “autorità”. Gli utenti sono in realtà dipendenti, prosumers, i cui dati – e quindi i beni in proprio possesso – sono acquisiti dalle aziende che controllano l’apparato infrastrutturale, ossia la rete e i server dove si articolano i servizi stessi. Il modus operandi è più o meno riassumibile così: svalorizzare e inflazionare queste informazioni, per poi riacquisirle e rimetterle in vendita, generando profitto. Si tratta di strategie sistemiche che sottraendo questi beni economici e deprezzandone il valore, vanno ad assoggettare il consumatore – l’utente. È il principio dell’accumulazione per espropriazione, è il “Capitalismo macchinico”: materialismo senza materia, il raggiungimento della deterritorializzazione.
L’arte contemporanea è parte integrante di questo processo. I tanto discussi NFT, in questo caso, sono l’esempio più significativo. A tal proposito, David Joselit ha recentemente sottolineato – sulle pagine di October – come questi siano dei ready-made al contrario: se da una parte il concetto duchampiano di “già fatto” utilizza l’arte per liberare la materialità dalla propria mercificazione, decontestualizzando l’oggetto d’uso quotidiano per esporlo in quanto opera, dall’altra i Non Fungible Token sfruttano la stessa categorizzazione artistica, privatizzando informazioni pubbliche già disponibili gratuitamente. La relazione tra materia e proprietà è in sé un fatto politico: il voler osservare, se mosso dalla volontà di possesso, rischia di tradursi nell’appropriazione.
Esporre la fisicità dei media diventa quanto mai necessario. Bisogna visualizzarne la corporeità, prenderne coscienza, occorre rivelarne la complessa topologia di rete. Forse, mettere da parte il tubo catodico potrebbe aiutarci a comprendere meglio tutto ciò. Un simile gesto potrebbe rappresentare un punto di partenza, il primo passo verso una generale ridiscussione dell’ormai consolidato pensiero computazionale.
Continuiamo ad accelerare verso il futuro con lo sguardo costantemente rivolto all’indietro. Eppure siamo stati avvertiti: la sindrome dello specchietto retrovisore aumenta il rischio di incidenti. Forse, a questo punto, sarebbe meglio rallentare e osservare. Per afferrare ogni dettaglio, per confrontarsi, per tentare di comprendere la realtà circostante.