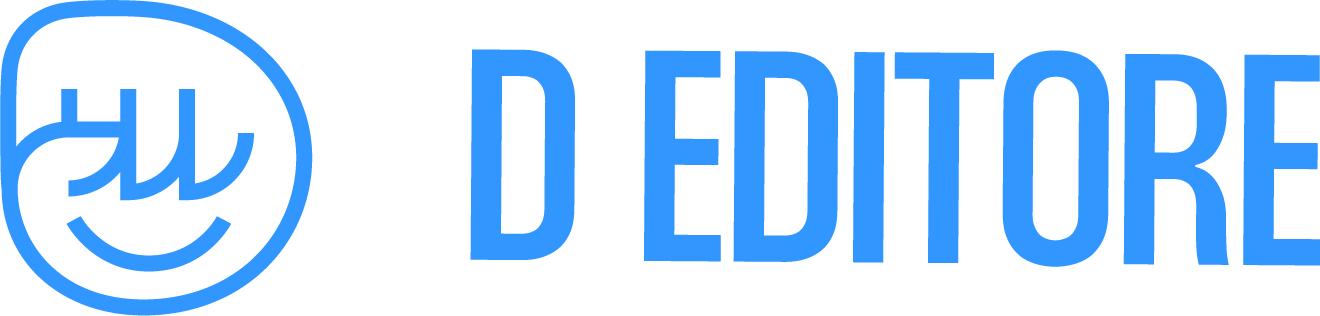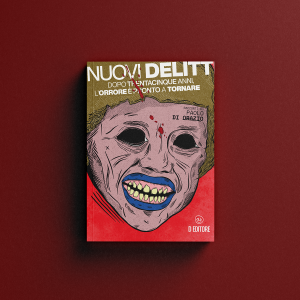Animaletti e pandemia
∞
La condizione pandemica impatta in primis l’individuo e la propria capacità di reagire rispetto ad un ignoto, il futuro, impegnato in un’acuta genuflessione verso divinità vacciniche e totem economici che non intendono rinnegare un’inflessibilità discriminante. Essa richiede la nascita di nuove abitudini, la riscoperta dei meccanismi in grado di muovere l’azione, un’enfasi speciale sulle ricompense quotidiane in grado di sottendere una volontá di andare avanti.
Pur lasciando da parte tutte quelle pratiche di auto-fascistizzazione del quotidiano, dai manuali di self-help ai video motivazionali di ex ammiragli della marina statunitense che spiegano su Youtube perché rifarsi il proprio letto la mattina debba essere il centro motore dell’etica individuale, è comunque opportuna una graduale rielaborazione di prassi quotidiane in grado di motivare l’individuo e impedire che subisca in modo passivo la condizione pandemica. Non è semplice ricostruire quel filo che lega la ripetizione di gesti quotidiani, l’instaurazione di routine più o meno variabili, con le più grandi macro-narrative all’interno delle quali questi gesti sono situati. La riscoperta delle futurità insite nell’atto presente non è una pratica scontata né facile. La condizione pandemica la rende ancor più frustrante, ma non impossibile, né nuova in essenza.
A ricordarci perché la pandemia non stia necessariamente instaurando condizioni esistenziali ex novo è uno dei testi che negli ultimi anni è stato tra i più letti, e forse abusati, nell’intero panorama intellettuale di critica all’ideologia neoliberale. Testo di cui abuserò anche io nelle seguenti righe. In Realismo Capitalista, Mark Fisher pone i suoi studenti in relazione con la condizione postmoderna di Jameson, descrivendoli come carenti di una particolare qualità, quella di saper sintetizzare il proprio tempo all’interno di narrative coerenti.
I suoi studenti rappresentano per lui un esempio concreto di “interpassività agitata”, l’esemplificazione di come per l’individuo sia sempre più necessaria una partecipazione costante, anche se passiva, all’interno di diverse matrici dell’intrattenimento. In particolare, Fisher ricorda l’aneddoto di un suo studente che era solito indossare delle cuffie durante la lezione pur senza che esse emanassero alcun suono, interpretando questo comportamento come la possibilità costante di fuoriuscire in ogni momento dalla relazione tra la continuità della propria azione e la grande narrativa in cui questa azione si situa, la praxis in divenire. Questa impossibilità di sintesi si nutre e si struttura quindi attorno alla connessione costante tra un individuo e i diversi territori virtuali con cui esso interagisce, una connessione che può essere totalmente passiva e non richiede necessariamente la fruizione di un contenuto.
Pur non soffermandosi in maniera approfondita sulla natura abitudinaria di queste operazioni, Fisher si inserisce in una corrente di pensiero che tenta di rielaborare l’azione del singolo all’interno di ecosistemi cognitivi più ampi. La sua aula è il luogo dove si intersezionano due linee di problematicità: la difficoltà di inserire la continuità della propria azione all’interno di macro-narrative più ampie, e la presenza costante di espedienti virtuali in grado di interrompere in ogni momento la stessa continuità. Oggi, il vuoto lasciato dalla stessa aula potrebbe simboleggiare la creazione di una terza linea di problematicità, in grado di sovrapporsi e forse assorbire le condizioni precedenti.
La condizione pandemica accelera infatti l’impossibilità di sintesi di cui parla Fisher, sia perché è in grado di interrompere la continuità di molte macro-narrative pre-esistenti, sia perché incoraggia il progressivo assorbimento dell’individuo all’interno di quelle matrici dell’intrattenimento la cui funzione diventa sempre più vitale per la stabilità psicologica del soggetto che ne fruisce.
Tra i diversi ecosistemi virtuali in grado di generare delle vere e proprie matrici dell’intrattenimento, ce n’è uno in particolare su cui mi focalizzerò, sia per l’immensa portata di coinvolgimento che sta generando, sia perché le situazioni di gioco che presenta sono state spesso messe sotto una lente critica in grado di evidenziarne le dinamiche colonialiste e parassitarie. Come è già stato fatto ampiamente notare, Animal Crossing: New Horizons è un moderno simulatore di esperienze proprie del capitalismo, una matrix colonialista dotata di un’estetica fanciullesca e bonaria. Il male incarnato, se non altro perché il proprio male è splendidamente nascosto, tale da sembrare originario e quindi ineluttabile. L’esperienza di gioco punta a catturare il giocatore tramite diverse situazioni e meccanismi che richiamano direttamente alcune fondamenta organizzative del capitale moderno.
Pur venendo catapultato all’interno di un contesto originario e incontaminato, quello di un’isola deserta, il giocatore è costretto fin da subito a fare i conti con la necessità di fare debito – rispetto al proprietario-colonialista-procione Tom Nook – per costruire le prime fondamenta della sua abitazione. Il legame tra proprietà privata e indebitamento viene contemplato dal giocatore come un’esigenza comprovata, una dinamica ineluttabile. Quella che era un’isola incontaminata diviene immediatamente una sinergia di dinamiche simil-capitalistiche che devono essere necessariamente seguite, e godute, dal giocatore. Assistiamo quindi alla repentina nascita di una sorta di mercato finanziario, esemplificato dalle rape (tra i due concetti c’è anche una sovrapposizione semantica. In giapponese “Kabu” è utilizzato sia per indicare le rape sia le azioni finanziarie, o stock), che prevede possibilità di compravendita e imprevedibili oscillazioni dei prezzi di bitcoiniana memoria. Le risorse dell’isola, compresi pesci, frutta, alberi e insetti, possono essere depredate senza nessun richiamo a qualsiasi limite etico. Una visione puramente consumistica struttura l’estetica del gioco, la cui essenza visiva si basa sulla produzione e lo scambio di beni essenzialmente decorativi. Pescare o raccogliere frutta non sono atti funzionali all’alimentazione dell’individuo, ma modi per ricavare risorse da inserire in circuiti economici interni all’isola. Anche la socialità tra gli abitanti dell’isola sembra essere mossa da motivi meramente opportunistici e lontana dall’essere ispirata dall’eterogeneità delle forme sociali che possono venirsi a strutturare all’interno di un ecosistema simile.
Lontano dal suggerire una qualche utopia sperimentale, AC nega la possibilità di qualsiasi sorta di alternativa sociale che non sia derivativa rispetto ai modi organizzativi del capitale con cui il giocatore si rapporta nella propria realtà non virtuale. È un difetto enorme per un gioco che potrebbe ispirarsi alle straordinarie ed eterogenee situazione di socialità che si sono venute a formare in contesti isolani. Sarebbe stato sicuramente più interessante rapportarsi con gli altri abitanti dell’isola secondo logiche di scambio simboliche, staccate da logiche consumistiche.
Una possibile fonte di ispirazione sarebbe potuta essere lo studio di Malinowski del 1914 nelle isole Trobriand. Osservando gli abitanti di alcune isole contigue nel Pacifico, l’antropologo polacco si accorse che queste comunità erano soliti scambiarsi doni di tipo decorativo, come delle collane o dei braccialetti costruiti con materiali della propria isola. Continuando l’osservazione degli abitanti nel corso di mesi, Malinowski capì che questo scambio svolgeva una funzione essenziale all’interno dell’ecosistema di queste isole. Trafficando questi oggetti ornamentali tra loro, le varie popolazioni riconoscevano vicendevolmente una volontà di essere pacifici, allontanando quindi lo spettro della guerra.
In Animal Crossing, invece, ogni possibilità simbolica rimane senza referente. È possibile donare oggetti o fare favori agli abitanti dell’isola, ma in cambio si potrebbe invece ricevere una somma di denaro particolarmente cospicua, o in alternativa degli oggetti costosi. Le dinamiche di scambio sono quindi principalmente opportunistiche e nessuna alternativa è offerta al giocatore. Non si può rifiutare di ricevere una somma di denaro da un co-abitante dell’isola che ha particolarmente gradito un regalo. Per godere a pieno del prodotto è necessario rispettare rigidamente le regole imposte da un’esperienza di gioco che replica svariati paradigmi del capitalismo moderno in modo semplicistico, svuotato di ogni malignità e capace di costruirsi nel tempo all’interno di un’estetica rassicurante e ingenua. Animal Crossing è la matrix capitalista perfetta, il luogo dove dettami economici in crisi ideologica rinascono in forma rassicurante. È un gioco che si basa sul sistema che rappresenta e decide di sigillarlo in chiave onirica. Ma non per questo si riduce ad una chiave simbolica, formale.
Ciò che rende AC uno splendido simulatore capitalista non è la base ideologica su cui è costruito, ma le meccaniche interne all’esperienza del giocatore. AC applica in modo estremamente efficace tutti quei principi di ludicizzazione (“gamification”) in grado di rendere diversi territori virtuali fortemente additivi. La ludicizzazione è il grande paradigma delle dipendenze virtuali, un filo conduttore che lega l’esperienza di Animal Crossing all’utilizzo compulsivo di Instagram, le notifiche di Facebook ai punteggi di Candy Crush. Non è altro che l’applicazione della logica che muove le slot machine a qualsiasi infrastruttura desideri far sì che l’utente replichi più e più volte uno stesso gesto. Basta associare un’azione dell’utente con una ricompensa variabile. Tanto più la ricompensa sarà variabile, tanto più alte saranno le possibilità di generare legami additivi con l’utente.
Questo principio lo troviamo associato molto spesso a contesti in natura non ludici. App di apprendimento come Duolingo o di fitness come Nike Fit riescono infatti a simulare dinamiche di gioco associando ricompense più o meno variabili ai gesti degli utenti, il più delle volte costruendo l’esperienza dell’utente attraverso veri e propri livelli di abilità in grado di rendere ancora più intersezionale il legame tra piccoli gesti e macro-ricompense.
Ma la ludicizzazione è una meccanica propria anche di molti videogiochi costruiti con l’intenzione di stimolare un legame costante tra micro-ricompense e abitudini, progettati in modo tale da creare delle vere e proprie abitudini ricorrenti del giocatore all’interno del gioco stesso. In AC sono molte le dinamiche di questo tipo. Il giocatore ad esempio è spinto a consultare quotidianamente un terminale simile a un qualsiasi ATM: per ogni giorno consecutivo in cui questo terminale viene consultato, il giocatore ottiene dei crediti extra. Ma se per caso non venisse azionato nel corso di una giornata, il conteggio dei crediti ripartirebbe da 0.
Ci si può imbattere in logiche di ludicizzazione ogni volta si decida di tagliare la legna, o andare a pesca: il giocatore sa già che ad attenderlo ci sarà un set quasi limitato di pesci, o di tipologie di legna, ma fino a che l’azione non viene eseguita è impossibile conoscerne l’outcome preciso. Creando un equilibrio coerente tra varietà di menù (composto da un set di ricompense più o meno variabili) e ricompense effettive (ad alternanza intermittente), AC riesce a far sì che il giocatore sia incentivato a ripetere abitualmente le stesse identiche azioni.
È normale quindi che queste tipologie di contesti videoludici tendano a scatenare un certo tipo di reazione da parte di chi non partecipa o non ne comprende il bisogno: perché mai qualcuno vorrebbe continuare a svolgere un lavoro essenzialmente ripetitivo ed omogeneo, intellettivamente non stimolante, anche nel proprio tempo libero? E quali sono gli aspetti positivi di un lavoro immateriale che tende a riprodurre dinamiche di tipo capitalistico, e di un contesto che distribuisce questo tipo di valori all’interno della sua esperienza di gioco? Per rispondere adeguatamente a queste domande è necessario immergersi fino in fondo nell’esperienza di gioco.
Pur essendo vero che questi ecosistemi replicano e distribuiscono valori appartenenti a una determinata logica, quella del profitto, essi al contempo riescono anche a creare un contesto sociale all’interno del quale il singolo può vedere realizzati determinati bisogni. AC è un ecosistema basato anche sulle relazioni con altri giocatori, relazioni che possono portare alla creazione di grafiche e oggetti esteticamente stimolanti, e in generale un sentimento di partecipazione all’interno di un’estetica collettiva e collettivizzante. L’idea di lavoro in Animal Crossing racchiude tutta una sfera di valori e di incentivi che sono staccati da quelli che vengono assegnati nella realtà non virtuale. Nessun incentivo di natura economica motiva l’azione dei giocatori, che è invece osservabile come una sorta di “free labor” (Terranova): l’etica lavorativa interna al gioco riesce a soddisfare determinati bisogni e desideri di tipo sociale o personale. I giocatori possono sviluppare una vera e propria etica fordista che, invece di rispondere al contratto o al salario, sia motivata da una più grande mente alveare – l’unione immateriale in grado di unire i vari giocatori di Animal Crossing all’interno di un’ecosistema uniforme. AC è infatti in grado di formare reti sociali più ampie, scambi di idee e pareri sul gioco, riuscendo a far convergere i giocatori su piattaforme mainstream come il popolatissimo subreddit dedicato o i vari gruppi Facebook. L’universo di AC spinge il giocatore a rispettare un tipo di etica che sa unire la dimensione del gioco a un bisogno produttivo. Un’esperienza di questo tipo può essere definita come “playbour”: un certo tipo di attività che, pur essendo separata da quella lavorativa, ne replica alcuni dettami all’interno di un contesto propriamente ludico.
Etica lavorativa e immersione ludica si mescolano all’interno di questi calderoni virtuali, accompagnati dai vari incentivi affinché l’utente sviluppi legami di carattere compulsivo con il gioco. Un’apologia di queste esperienze si può trovare in Capitalismo e Candy Crush di Alfie Bown, all’interno del quale l’autore si inerpica in un tentativo estremo di difendere il proprio utilizzo compulsivo di Football Manager. Per Bown, immergersi in esperienze ludiche strutturate su dinamiche simil-lavorative è un rimedio necessario per riuscire a dare valore alla propria esperienza quotidiana. Ciò deriva dal fatto che la generalizzata alienazione derivante da un’attività lavorativa priva di senso può essere compensata dall’immedesimazione in alias virtuali in grado di conferire valore all’esperienza. Se il lavoro è il problema, Football Manager può invece essere un ottimo palliativo.
Il discorso di Bown è interessante perché sottende la possibilità di instaurare abitudini quotidiane di tipo ludico che vadano di pari passo, fino a compensare, le abitudini che si sviluppano nella propria sfera lavorativa. Sia legami di produzione immateriale con ecosistemi virtuali che legami di produzione materiale basati su condizioni contrattuali-lavorative possono essere potenzialmente portatori di valori in grado di incoraggiare o scoraggiare l’azione dell’individuo. Ma la considerazione di Bown è anche essenzialmente misoneista, poiché implica che il legame tra abitudini quotidiane e grandi narrative sia già spezzato di suo e impossibile da ricostruire, e che l’incapacità di sintesi di cui parla Fisher sia un conseguenza diretta di condizioni lavorative essenzialmente irreversibili. Inoltre, questo discorso riduce la funzione della distrazione solamente in relazione al lavoro, scontrandosi clamorosamente con la nuova realtà pandemica. Se la funzione di queste distrazioni è quella di conferire valore nei confronti di un’attività lavorativa che non ne ha, perché oggi sembrano essere ancora più necessarie? La pandemia ha distrutto condizioni salariali e contrattuali pre-esistenti, spazzato via il fragile equilibrio che reggeva in piedi quello che rimaneva del precariato italiano e globale. Ha modificato in essenza la relazione tra distrazione e lavoro. Ma cosa accade quando il lavoro svanisce e la distrazione prende il suo posto?
Il COVID-19 ha intensificato quel punto di problematicità accennato all’inizio, portando a galla una delle sue condizioni: siamo già strutturati su complessi sistemi di dipendenze e co-dipendenze che trapassano il divario tra reale e virtuale, la dimensione ludica e quella seriosa.
Un’osservazione approfondita di Animal Crossing dovrebbe far capire che la sua forza non risiede in delle condizioni di gioco ispirati da logiche colonialiste, o dalla sua capacità di ridurre lo spettro di potenzialità con cui si trova a interagire il giocatore ad un’ideologia ben precisa e spoglia di malignità. La vera grande fortuna di Animal Crossing risiede nel coinvolgere il giocatore in un gameplay a cui è già abituato, di replicare delle dinamiche che sono diventate per molti essenziali al funzionamento corretto dell’ecosistema cognitivo. Non è di per sé Animal Crossing a ispirare la ferrea volontà di ripetere svariate volte lo stesso gesto, ma è la necessità di compiere quel tipo di gesto, in un modo o nell’altro, che rende un simulatore di vita come AC ancora più appetibile.
L’analisi di questo fenomeno non deve quindi sbattere la testa contro il gioco in sé, emarginarlo dal contesto più ampio in cui è situato, ritenerlo un caso particolare e isolato. Il caso Animal Crossing esemplifica invece un bisogno generalizzato, mettendo alla luce le dinamiche che rendono alcune matrix maggiormente additive rispetto ad altre. La partecipazione che ha generato invita a riflettere sull’essenziale abilità di logiche additive di situarsi contemporaneamente in più generi e territori. Un legame con delle ricompense più o meno variabili tende a strutturare l’esperienza dell’individuo contemporaneo, attivando aree neuronali in grado di motivare l’individuo tramite vere e proprie dipendenze.
Non ci resta che accettare questa realtà, e di sfruttarla nel modo migliore possibile affinché non diventi un meccanismo ancor più di rottura, uno stratagemma per distaccarsi completamente dalla possibilità di costruire un futuro. Abbandonati a una condizione di isolamento fisico e sociale, possiamo cercare di mappare ancor di più la nostra relazione con le matrici virtuali in cui ci muoviamo. Che esse siano inserite in una cornice insignificante, imperialista, demoniaca o iper-colonialista non ha poi troppa importanza.
L’importante è imparare a relazionarsi con questi bisogni in modo positivo, capire che la costruzione di abitudini e routine quotidiane intrise di significato può, e in alcuni casi deve, andare di pari passo con un’immersione automatizzata in vari territori che sono disegnati per replicare meccanismi a cui l’individuo è abituato, e di cui non può fare a meno.
Il lavoro pandemico è un lavoro costante, che deve costruirsi giorno dopo giorno, in grado di basarsi su quel poco che ha per far sì che l’individuo possa continuare a immaginare un futuro. Le matrici virtuali in cui ci muoviamo non devono essere considerate per forza come nemici, dipendenze da allontanare, ma possono essere ricondotte a una visione omogenea che non separi le varie sfere della nostra quotidianità. La condizione pandemica impone di omogeneizzare virtuale e reale, di considerare queste dimensioni su un piano unico, affinché la nostra azione si possa reggere su un nuovo equilibrio, mutevole e scomposto. Un filo che regga, anche se in modo precario, la nostra capacità di essere parte del futuro che sarà, qualsiasi esso sia.